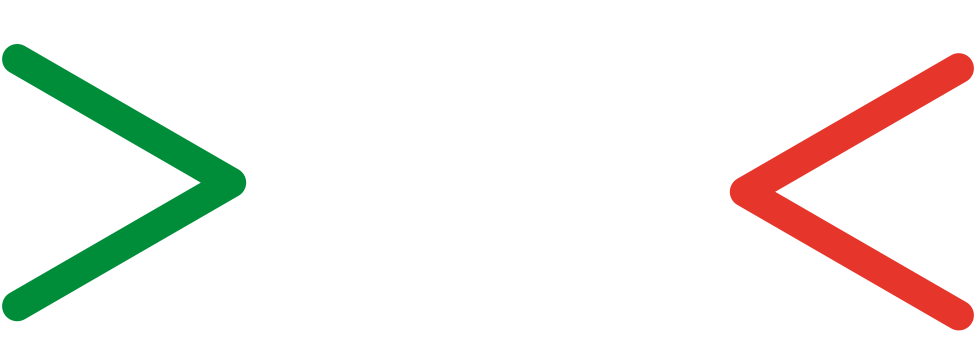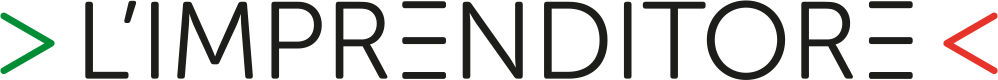In questi mesi stiamo uscendo, sia pure faticosamente, dall’incubo della pandemia e oltre a concentrare gli sforzi per recuperare quanto perso nel 2020 e intercettare le opportunità per consolidare la ripresa, da più parti si tenta di verificare le conseguenze di questa discontinuità, di comprendere quali paradigmi e quali modelli siano da considerarsi ancora validi e quali, invece, siano da aggiornare, se non da considerare definitivamente superati. Una riflessione che richiederà tempo anche se alcuni elementi cominciano a chiarirsi.

ANTONIO ANGIONI
Oltre a costringere tutti ad un drastico esercizio di gestione del cambiamento (per il quale non siamo naturalmente portati ma che abbiamo dimostrato a tutti i livelli di saper affrontare), la pandemia ha accelerato processi in corso da tempo ed uno dei risultati più evidenti può sicuramente considerarsi: la ritrovata centralità della persona.
A parte le testimonianze autorevoli a livello internazionale, vedasi per tutte Stakeholder Capitalism di Klaus Schwab, che offre una lettura economica che ruota intorno alle tre P di Progress, People and Planet, abbiamo registrato, e stiamo tuttora registrando, nell’attività di assistenza e di supporto a molte delle aziende clienti, una crescente attenzione alle risorse umane.
Oltre alla doverosa tutela da un punto di vista sanitario, di cui le aziende si sono fatte carico a causa della pandemia, ha sicuramente contribuito l’aver riscoperto nei momenti più critici dei lockdown il valore di affrontare insieme la sfida della difesa e, in certi casi, della sopravvivenza dell’azienda, nonché il valore della resilienza. Non solo: comincia a diffondersi la convinzione che lo sviluppo non sia e non possa essere fine a sé stesso, ma sia connesso alla sostenibilità e all’inclusione. Tanto è vero che alcune aziende italiane, 14 per l’esattezza, hanno iniziato da tempo un percorso che le ha portate di recente ad essere certificate dal Dow Jones Sustainability World Index fra le aziende che in base a criteri economici, ambientali e sociali a lungo termine forniscono le migliori performance in termini di sostenibilità.
Diversi sono gli elementi endogeni che hanno facilitato questa presa di coscienza, fra i quali occorre annoverare da ultimo il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma è pur vero che da alcuni anni determinati aspetti cominciavano ad emergere, sia pure faticosamente, anche in Italia. Inizialmente, soprattutto nella piccola e media impresa, certi temi venivano liquidati in passato come “americanate”, riferibili a realtà completamente diverse dalla nostra, o come “lussi che non ci possiamo permettere”. Poi, a seguito anche della maturazione in corso nella società civile, categorie come la diversity e l’inclusion hanno cominciato progressivamente ad essere prese in considerazione. Crediamo sia utile precisare il perimetro sia perché certi termini sono utilizzati troppo frequentemente, sia per chiarire le dimensioni evocate da queste categorie che nel linguaggio manageriale stanno conoscendo diverse evoluzioni: diversity, diversity and inclusion, diversity, equality and inclusion. Riteniamo, però, che il termine più adeguato e nello stesso più pregnante sia semplicemente quello di inclusione, che comprende tutte le altre possibili declinazioni. Nella cultura africana esiste un termine egualmente significativo: Ubuntu. Nel linguaggio degli Zulu e degli Xhosa è utilizzato per esprimere l’essenza dell’essere umano: “I am because you are”, quale migliore sintesi della dimensione esistenziale e relazionale.
Trasferendo la riflessione nelle aziende si potrebbe sintetizzare come attraverso l’inclusione si possa creare un contesto nel quale ogni collaboratore riesca ad essere autentico, a sentirsi riconosciuto come persona per i contributi che può offrire indipendentemente dalle caratteristiche personali che possano essere percepite come “differenze”, spesso oggetto di pregiudizi inconsapevoli (i famosi unconscious bias). Non si tratta di un processo semplice, soprattutto se si considerano le implicazioni gestionali, alcune già evidenti altre forse sottovalutate se non ignorate. Limitandoci a quanto percepito nel vissuto delle aziende italiane di cui abbiamo fatto esperienza, ci riferiamo a tematiche relative: il genere, l’età, la razza, il gruppo etnico, la religione, le disabilità, l’orientamento sessuale.
Per quanto riguarda il genere non si fa solo riferimento alle differenze retributive fra uomini e donne, ancora pesantemente rilevanti come di recente confermato da una rilevazione dell’Inps, o alle quote rosa nei Cda (nei quali è stato registrato comunque un sensibile sviluppo), ma a differenze più sottili, più quotidiane, relative: i ruoli, le responsabilità, gli stili relazionali, terreno dove c’è ancora molto da fare per recuperare sinergie e complementarietà.
Se passiamo poi all’età, oggi in molte aziende convivono ben cinque generazioni, ognuna portatrice di valori, di modelli, diversi per non dire spesso inconciliabili ma che esigono comunque la capacità di creare sintesi, di cogliere il meglio e di adottare soluzioni controcorrente, si pensi al reverse mentoring. Senza dimenticare come per affrontare le differenze generazionali sia importante liberarsi da certi schemi e presunzioni. Basti citare, per esempio, come proprio le generazioni più giovani e più digitali abbiano, pur apprezzandone le opportunità offerte, patito, come confermato da recenti indagini, il remote working, che ha frustrato sia l’induction in azienda sia la parte relazionale e creativa.
Quelle che sembravano problematiche di altri paesi in Europa, con passati coloniali, se non di oltre Atlantico, sono diventate realtà in molte aziende, dove cominciano ad essere presenti componenti razziali ed etniche diverse che richiedono sia un approccio multiculturale (che non può esaurirsi nella tradizionale e proverbiale apertura che ci ha permesso di affermarci a livello internazionale), sia una gestione attenta a riconoscere e valorizzare (si pensi per esempio all’inserimento di menu multietnici nelle mense aziendali).
Per non parlare della religione perché al di là delle statistiche occorre prendere atto della compresenza di fedi diverse che, se non possono portarci a sconvolgere calendari e tradizioni, spesso oggetto di strumentalizzazioni politiche, possono però indurre a gesti di rispetto in occasione di determinate ricorrenze religiose. La disabilità poi viene spesso ignorata perché foriera di costi, considerata tema da “terzo settore” quando invece in alcune situazioni è risultata vincente l’integrazione anche a livello produttivo, grazie anche all’introduzione di soluzioni di AI. Quello dell’orientamento sessuale poi resta ancora in molti casi un tema percepito come un rischio di cui è preferibile non farsene carico anche perché non se ne vede (rectius non si vuole vedere) l’esigenza.
Le esperienze sin qui realizzate ci hanno portato ad elaborare una metodologia ad hoc per supportare le aziende in funzione del livello di percezione e di consapevolezza. Abbiamo individuato infatti quattro diversi stili di leadership:
- Inconsapevole, di chi più o meno volutamente ignora l’esistenza di questi problemi o non li ritiene di sua responsabilità;
- Consapevole, di chi cerca di capire e di identificare la soluzione migliore;
- Proattivo, di chi ha iniziato a sperimentare nuove soluzioni;
- Testimone, di chi ha impostato una tangibile politica di attenzione non solo a livello gestionale ma anche di marketing e sviluppo del vantaggio competitivo e distintivo.
Possiamo confermare che le aziende che hanno intrapreso questo percorso hanno registrato non solo un livello di motivazione crescente e di appartenenza dei collaboratori, il cosiddetto belonging, ma anche positive performance economiche a conferma di quella relazione fra sviluppo, inclusione e sostenibilità sopracitata.