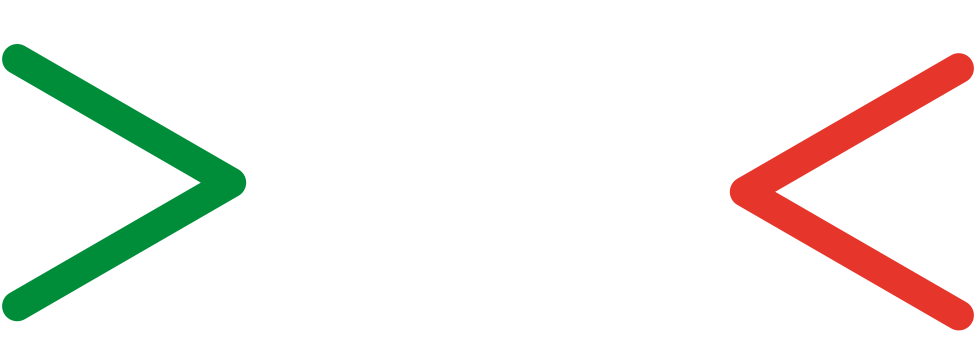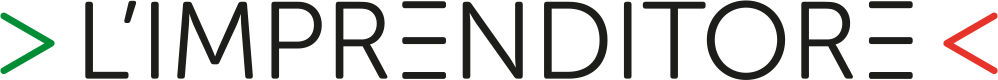“Affrontiamo un tema di attualità, ma anche di straordinaria emergenza per l’Italia, che la politica ha sottovalutato. Basti dire che per istruzione e formazione professionale spendiamo meno di tutti i paesi europei, sia in rapporto al Pil sia in rapporto alla spesa pubblica sociale, dove le pensioni fanno la parte del leone. La politica non ha compreso che l’adeguamento e la ristrutturazione della formazione professionale riguardano il futuro sia dei lavoratori di oggi che di quelli che entreranno nel sistema nei prossimi vent’anni”. A parlare è Stefano Manzocchi (nella foto in alto), prorettore alla ricerca all’Università Luiss Guido Carli di Roma e direttore della Rivista di Politica Economica. Il primo numero del 2023, uscito da poche settimane, si intitola “L’impresa delle competenze – I nuovi saperi e il lavoro” e si distingue per la ricchezza di dati, un ampio apparato di tabelle e grafici che arricchiscono i sette contributi ospitati. “Non parliamo né di scuola, né di università, ma entriamo nello specifico di argomenti tecnici che riguardano la formazione professionale in Italia”, sottolinea Manzocchi.
Fra i vari aspetti, il volume indaga cause e caratteristiche di tre fenomeni, richiamati anche nella prefazione, ovvero lo skill shortage, lo skill gap e lo skill mismatch. In che misura ne soffre il nostro Paese?
Il primo è la carenza in termini assoluti di lavoratori idonei per occupare alcuni posti, ovvero competenze che le imprese non trovano sul mercato del lavoro.
Lo scorso anno il Centro Studi Confindustria ha calcolato che circa un quarto delle imprese ha difficoltà a trovare personale e la quota sale a un terzo quando parliamo di imprese con oltre 100 addetti. Questo fenomeno ha due spiegazioni: la prima è che il sistema universitario, o professionale, non ha saputo intercettare le esigenze delle imprese; la seconda è che il tipo di formazione erogata è stata completamente superata. Oggi, per esempio, in azienda non serve più un ragioniere ma un controller.
Questa carenza si traduce di fatto in una perdita di Pil che, è stato calcolato, ammonta a circa 40 miliardi di euro all’anno, risorse che il sistema brucia perché non immette le professionalità di cui ha bisogno.
E lo skill gap?
In questo caso quantificare è più difficile. Lo skill gap è il ritardo con cui il sistema Italia modifica e aggiorna le competenze delle persone che già lavorano ma non riescono a tenere il passo con le trasformazioni dell’economia e della società. È un tema legato al cambiamento del sistema produttivo e alle transizioni in corso, da quella digitale a quella ecologica. Ma riguarda anche l’invecchiamento della popolazione e le professionalità sempre più necessarie nella telemedicina, diagnostica, fisioterapia e che però sono carenti sul mercato del lavoro.
In campo digitale, per fare un esempio, tra il 2013 e il 2021 abbiamo registrato un peggioramento delle competenze dei nostri lavoratori perché non si è stati in grado di fornire la formazione on the job che sarebbe servita per metterli al passo.
È anche vero, però, che l’accelerazione tecnologica avvenuta nell’ultimo decennio in alcuni settori è senza precedenti. Pensiamo alla cybersecurity…
Verissimo. E nel caso specifico questa accelerazione aggrava sia lo shortage di tecnici esperti in cybersecurity che possano essere inseriti in aziende medio-grandi, sia lo skill gap di lavoratori che, pur gestendo dati per la loro mansione, non sono capaci di risolvere problemi giornalieri legati alla loro sicurezza. Eppure, noi sappiamo che per garantire la sicurezza del sistema produttivo italiano sarà necessario dare formazione in maniera continuativa a milioni di lavoratori.
Passando al terzo fenomeno, quello dello skill mismatch, ci troviamo di fronte a un problema organizzativo, nel quale imprese e lavoratori non riescono a incrociare bene le competenze con le funzioni. Abbiamo il cosiddetto mismatch orizzontale, ovvero il divario tra il campo di studi della propria formazione (scolastica o universitaria) e l’impiego svolto, e poi abbiamo il mismatch verticale, con lavoratori ai quali sono richieste mansioni al di sopra delle loro competenze (underskilling) oppure di lavoratori molto qualificati impiegati a svolgere mansioni dove questa preparazione non è necessaria (overskilling).
A questo proposito, nel volume si cita un’indagine condotta dal Cedefop su un campione di lavoratori europei, nella quale risulta che “in Italia circa il 70% dei lavoratori presenta un certo grado di overskilling rispetto al dato, comunque elevato, del 50% in media UE a 27”.
Questo accade perché il sistema non fornisce, in tutte le fasi, le professionalità o la formazione adeguate a ciò che le aziende richiedono. E così quelle che possono permetterselo assumono figure super preparate per mansioni per cui non ci sarebbe bisogno.
Uno dei capitoli più interessanti è quello intitolato “Formarsi tutti, formarsi sempre”, nel quale si afferma la necessità di istituire un sistema di formazione di massa. Citiamo testualmente: “La parola sistema non è casuale (…) perché non può essere una semplice sommatoria dei corsi di formazione esistenti più o meno organizzati”. Gli autori la riconoscono come una sfida tecnica complessa. L’Italia può farcela?
Nel capitolo emerge chiaramente l’incapacità di fare sistema, che si manifesta in vari aspetti. Da un lato c’è la mancata comprensione del problema da parte della politica, come abbiamo già ricordato prima; dall’altro c’è una carenza territoriale, legata al campanilismo tipico italiano, che dà luogo a un sistema di formazione parcellizzato e disorganico. Esistono iniziative, anche molto pregevoli, ma sono per lo più estemporanee e legate a sistemi produttivi locali.
Nonostante questo, io credo che l’Italia abbia le risorse per affrontare una sfida del genere. Per quanto riguarda le competenze tecnologiche, il nostro Paese non è secondo a nessuno in termini di università e aziende leader in settori quali ingegneria, costruzioni ed energia e vanta ancora sistemi ospedalieri di buon livello. Le grandi imprese riescono a provvedere da sole al proprio fabbisogno formativo, le medio piccole hanno sì più difficoltà a meno che non vengano ricomprese in un sistema pubblico-privato sul modello degli ITS.
Il tema della formazione sicuramente andrà avanti almeno per i prossimi vent’anni e occorre il contributo del sistema pubblico della formazione. Certo, qui apriamo un problema spinoso, se solo pensiamo ai ritardi con cui l’innovazione digitale sta entrando nella Pubblica amministrazione. Ma le risorse ci sono, anche quelle del Pnrr, e le aziende pure. Il settore pubblico deve cogliere l’urgenza del tema.
Nel dibattito sulle nuove competenze e la necessità di continuare a formarsi non si parla però altrettanto spesso dell’aspetto didattico, ovvero dei formatori che dovrebbero erogare questo sapere. Non è un punto di debolezza dell’analisi?
Sono d’accordo, il tema dei formatori è fondamentale. Uno degli obiettivi che un nuovo partenariato pubblico-privato dovrebbe porsi è proprio quello di creare un sistema per la formazione dei formatori perché altrimenti questo causa uno scadimento della qualità, lasciando prosperare iniziative non all’altezza.
Le aziende grandi e medie possono giocare un grande ruolo, specie quelle tecnologicamente avanzate, attive nell’economia circolare, nelle costruzioni e nel digitale. Già oggi, di fatto, “formano” le piccole e medie imprese della propria filiera perché richiedono loro determinati standard per collaborare. Questo sistema, a mio avviso, deve essere il più possibile codificato e replicato per individuare come queste aziende operano per garantire la qualità dei propri formatori.
Nel settore pubblico, invece, a volte ci si accontenta di immaginare un sistema sulla carta, senza andare a verificare che la qualità erogata sia quella richiesta. È un problema antico, che richiama l’assenza di una cultura della valutazione nella Pubblica amministrazione.
(Per informazioni e acquistare il volume cliccare qui)