

NICOLA RONDINONE
Le nozioni di imprenditore e impresa riscontrabili nel codice civile vigente sono ancora adeguate alla realtà attuale oppure meritano di essere modificate? È corretto contrapporre l’impresa all’imprenditore come se la prima fosse un “bene comune” da sottrarre al secondo in alcune particolari situazioni? Per rispondere a questi interrogativi è utile comparare passato e presente.
1942-2000: La legittimazione dell’imprenditore e la neutralizzazione della teoria dell’impresa-organismo
In una monografia intitolata “Impresa e commercialità attraverso il ‘lato oscuro’ dell’unificazione dei codici” (nella foto in basso), ho messo in luce che la disciplina delle attività economiche contemplata nel codice civile del 1942 è stata il frutto di una complessa disputa fra centri di interessi, in cui ebbe un ruolo rilevante la Confindustria dell’epoca.
All’esito della tenzone si decise di: a) legittimare il ruolo centrale dell’imprenditore nel processo economico e nel sistema giuridico, definendolo come “chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” (art. 2082 c.c.); b) lasciare indefinita la nozione di impresa, poiché il corporativismo ne predicava la coincidenza con l’organismo produttivo, volano per la protezione di interessi ulteriori rispetto a quello dell’imprenditore.
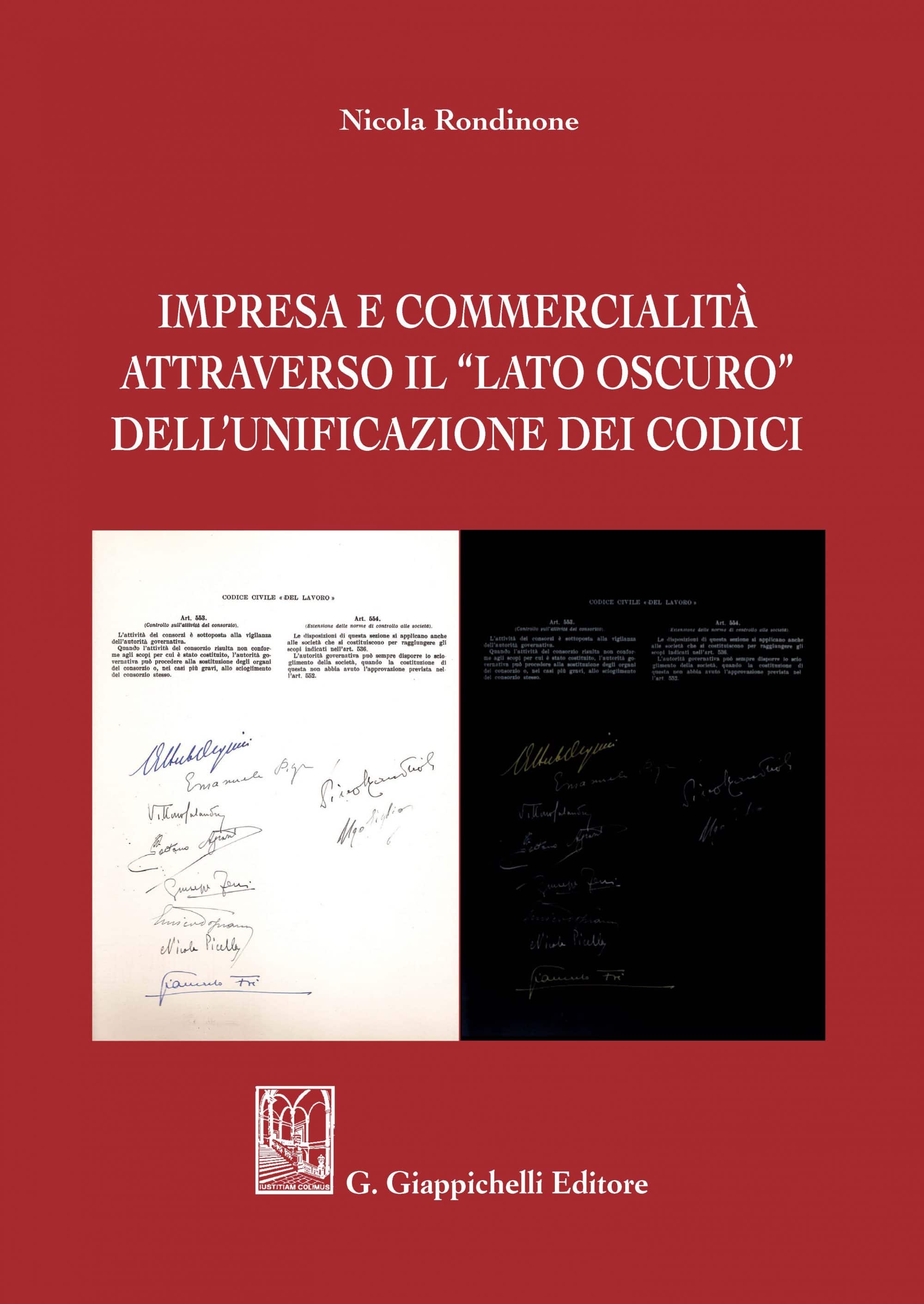
LA MONOGRAFIA PUBBLICATA DA G. GIAPPICHELLI EDITORE
In realtà, vennero introdotte molte norme suscettibili di limitare i poteri dell’imprenditore in ottica dirigista, ma, prima ancora della caduta del fascismo, la stella dell’impresa corporativa era già tramontata, a vantaggio della teoria neutrale dell’impresa come attività imprenditrice.
Con alcuni ritocchi al codice civile e l’entrata in vigore della Costituzione, le norme dirigiste scomparvero quasi integralmente e, nonostante episodiche prove di programmazione, l’impostazione liberista in tema di iniziativa economica si affermò stabilmente. Quasi tutti gli interventi di riforma susseguitisi sino alla fine del secondo millennio hanno poi confermato la centralità dell’imprenditore nel sistema economico e giuridico, ma la nozione di impresa come organismo collettore di interessi ulteriori, in specie quello dei prestatori di lavoro, è tornata più volte a emersione, ad esempio nei provvedimenti sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
2001-2021: La concezione paternalistica del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Anche nel nuovo millennio le riforme inerenti alla disciplina delle attività economiche si sono concentrate sulla regolamentazione delle crisi di impresa: il legislatore è intervenuto in materia con plurimi ripensamenti, da ultimo con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Tratto qualificante di questo è l’introduzione di istituti di allerta, con cui si dichiara di perseguire l’obiettivo di una precoce esteriorizzazione della crisi dell’impresa mediante un sistema di obblighi – interni ed esterni – di segnalazione capace di “forzare la mano” all’imprenditore.
Si vorrebbe contrastare la presunta naturale tendenza dello stesso a temporeggiare nell’accedere ai vari strumenti giuridici di regolazione della crisi. Si presume che egli confidi “oltre i limiti della ragione” in una ripresa della vitalità dell’impresa senza aiuti esterni.
Come risulta dai precedenti cenni storici, la concezione teorica sottesa al nuovo Codice non è nuova: l’impresa non è dell’imprenditore, bensì è un bene comune che gli va sottratto a beneficio di altri interessi quando non si mostra capace di reagire con tempestività. Il nuovo legislatore si spinge con ciò persino oltre la soglia cui era approdato il dirigismo fascista.
I rischi dei sistemi di allerta e la sopravvalutazione delle procedure per la risoluzione della crisi
Sennonché ‒ va detto a chiare lettere ‒ a prescindere dalle molte criticità della macchina operativa concretamente modellata nel predetto Codice, la sottrazione all’imprenditore del potere di decidere delle sorti della propria impresa rappresenta una forma di esproprio della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., la quale può essere giustificata solo quando sia stata giudizialmente accertata l’incapacità del primo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, ossia il suo stato di insolvenza.
Come già notavano gli studiosi più qualificati della materia 100 anni fa (!), lasciare ogni iniziativa al solo imprenditore prima di tale stadio è la soluzione preferibile, in quanto: 1) questi è in grado meglio di ogni altro, anche con l’aiuto di suoi consulenti, di cogliere con carattere di plausibilità i segnali di difficoltà; 2) egli può mantenere il segreto sulle strategie aziendali sino alla soglia dell’insolvenza; 3) il cosiddetto stato di crisi o pre-insolvenza è reversibile, controvertibile e insuscettibile di precisa circoscrizione temporale e sarebbero frequenti i casi di un’attivazione al di là del necessario.
La tutela della riservatezza di cui l’imprenditore ha bisogno per coltivare i propri affari non va solo a suo giovamento: consentire a giudici o a professionisti esterni di indagare anzitempo le difficoltà dell’imprenditore può rivelarsi controproducente, poiché la fuga di notizie è un fenomeno difficile da scongiurare; e comunque il necessario negoziato con i creditori è destinato a svelare lo stato di crisi, la cui percezione all’esterno è destinata a diminuire il credito sul mercato del debitore.
L’ovvio pericolo è che parta una nociva “corsa alla diligenza”, atta a facilitare il radicalizzarsi della crisi. Ingenerare allarme sociale sulle sorti dell’impresa, inducendo i creditori ad azioni di autotutela (revoca degli affidamenti, richiesta di garanzie, procedure esecutive, etc.) idonee a menomare le chances di recupero della normalità aziendale, rischia insomma di determinare l’effetto opposto a quello auspicato, cioè il definitivo crollo dell’impresa.
Infine, quand’anche non si determinasse questo effetto deteriore, non c’è da farsi troppe illusioni su quanti (pochi) potranno essere i casi in cui le ricette di risoluzione della crisi si riveleranno vincenti nei ristretti tempi previsti per lo svolgimento della “procedura di composizione assistita” prevista nel citato Codice.
Più in generale, nessuno strumento giuridico è stabilmente in grado di garantire tale risoluzione e quindi di evitare l’esito liquidatorio.
Conservare la centralità della nozione di imprenditore e mettere a punto valide leggi speciali
Da quanto sopra, emerge che la revisione delle leggi più importanti in materia economica postula un’adeguata conoscenza delle ragioni per cui in passato certe strade non sono state imboccate; e che occorre diffidare delle sirene suonate da soggetti che hanno interessi di categoria da tutelare.
A maggior ragione, non intravedo i presupposti politici e le capacità tecniche per mettere mano alla parte del codice civile relativa alla disciplina delle attività economiche senza rischiare di peggiorarla, e in specie di creare lacci e lacciuoli inopportuni. In particolare, per quanto concerne l’imprenditore, la cui definizione all’art. 2082 appare ancora attuale e ben ne rappresenta la funzione di motore essenziale del ciclo economico, tanto da essere stata assunta a modello in altri ordinamenti.
Un intervento legislativo non auspico neppure circa la nozione di impresa, in quanto anche oggi le possibili connotazioni ideologiche sconsigliano di avventurarsi in una definizione. Ciò, beninteso, non significa che gli altri interessi implicati dall’esercizio dell’impresa non debbano essere tutelati: ma ciò deve avvenire mediante le limitazioni e le cautele imposte dall’esterno dal legislatore, non agitando il vessillo di una concezione di impresa che metta in ombra il ruolo e la capacità di giudizio dell’imprenditore sulle azioni migliori da intraprendere, anche nelle situazioni di difficoltà che è fisiologico possa attraversare.
Dunque, non occorre alcuna riforma? Non è esatto: se il codice civile è meglio non toccarlo, non appare inutile raccomandare all’attuale governo, che in forza dell’argent dell’Unione europea si è visto riattribuire un ruolo decisivo ai fini dell’auspicata recovery, di supportarla adeguatamente sul piano giuridico, mediante provvedimenti legislativi precisi, comprensibili ed elaborati con l’ausilio delle categorie produttive, le quali vantano la concreta percezione delle esigenze meritevoli di soddisfacimento. Perché francamente non si vorrebbe essere costretti a riconoscere che sotto questo profilo si facesse preferire il metodo legislativo utilizzato negli anni ‘40.

