
Rinasce la Rivista di Politica Economica. Quali caratteristiche presenta e quali obiettivi si pone la nuova pubblicazione?
L’idea è quella di fare un prodotto simile a quello che fu concepito alle origini, nel 1911, e che ne giustifica il nome e cioè creare un luogo di discussione e confronto aperto sui temi della politica economica italiana. Quindi non intendiamo fare concorrenza alle riviste accademiche, ma raccogliere i migliori esperti di ogni settore per discutere di temi rilevanti per l’economia italiana.
Il pubblico a cui ci rivolgiamo non è dunque quello degli addetti ai lavori, ma è un pubblico più largo, fatto di persone che nel mondo del lavoro, dell’impresa e delle istituzioni si occupano delle policy. Ciò significa anche i lavori sono scritti in italiano e che sono tipicamente più brevi di un articolo accademico, anche se più lunghi, in quanto più approfonditi, di un articolo di giornale.
Il primo numero è una monografia dedicata al debito pubblico, annosa questione che i rappresentanti politici sembrano per lo più ignorare. Cosa rischia l’Italia?

GIAMPAOLO GALLI
L’opinione unanime degli autori che hanno collaborato al primo numero della rivista è che per l’Italia il debito pubblico sia un problema molto serio, in un contesto nel quale la crescita economica è pressoché nulla.
Nel breve periodo, non ci sembra ci siano pericoli perché i tassi d’interesse fissati dalla Bce sono al minimo storico. Tutti, però, ci preoccupiamo di cosa potrebbe succedere se i tassi di interesse tornassero a valori normali – il che prima o poi accadrà – oppure se ci fosse una nuova recessione internazionale.
Anche l’instabilità politica interna potrebbe creare problemi. Il rischio è quello di una nuova impennata dello spread, come nel 2011, oppure di una perdita di accesso al mercato finanziario, come accadde in Grecia. Se si dovessero verificare circostanze di questo tipo, si aprirebbero scenari davvero preoccupanti per l’economia e la società italiana.
Uscire dall’euro viene presentata come la panacea di tutti i mali dell’Italia, specie in campagna elettorale. Perché riscuote consenso e perché non sarebbe una soluzione praticabile, oltre che conveniente, per l’Italia?
L’ipotesi di uscire dall’euro ha riscosso un certo consenso perché appare come la classica soluzione semplice a un problema complesso.
La realtà è che una svalutazione della nuova valuta, poniamo, del 30% farebbe aumentare il rapporto debito/Pil dal 135% attuale a oltre il 190%. Ciò accadrebbe a meno di ridenominare il debito nella nuova moneta, il che però sarebbe equivalente ad un default e tale verrebbe considerato dalle agenzie di rating e dai mercati: lo Stato aveva promesso di pagare i debiti in euro e invece li paga, se li paga, in una valuta deprezzata.
Ancora più serie sarebbe le conseguenze sulle banche e le imprese che hanno debiti netti sull’estero. Se questi debiti fossero ridenominati, anche le singole imprese sarebbero in default; se non lo fossero, molte di esse non riuscirebbero a far fronte al mismatch valutario, derivante dall’avere ricavi nella nuova valuta deprezzata e debiti in euro. Non a caso, nei famosi piani B si immagina che tutte le grandi imprese e le grandi banche vengano commissariate e che per le altre imprese ci sia un’inondazione di liquidità da parte della banca centrale. Ma questo non farebbe che aggravare l’inflazione e la svalutazione del valore esterno della moneta. Soprattutto, ci sarebbe il problema della transizione: un cambiamento enorme, come l’uscita dall’euro, non potrebbe certo essere tenuto segreto ed essere deciso di notte a mercati chiusi in un fine settimana: non appena si diffondesse la notizia, o anche solo il timore che è intenzione del governo abbandonare l’euro si verificherebbero massicce fuoriuscite di capitali che metterebbero in ginocchio lo Stato e l’intera economia.
Lei è stato anche in Parlamento, deputato dal 2013 al 2018. In base alla sua esperienza che cosa impedisce di portare avanti le cosiddette riforme strutturali di cui il Paese ha bisogno?
Non buttiamoci troppo giù: alcune riforme sono state fatte. Il problema è che c’è sempre qualcuno che le vuole cancellare. È successo così per la riforma Fornero, che è stato un fattore essenziale per salvare il Paese in un momento di grave difficoltà e che, tuttavia, è stato uno degli obiettivi preferiti degli attacchi dei populisti e una delle ragioni principali del loro successo alle elezioni politiche del 2018.
Lo stesso è accaduto con il Jobs Act: dopo la sentenza del novembre 2018 della Corte Costituzionale, il Governo avrebbe dovuto chiedersi come si possa conciliare al meglio la discrezionalità del magistrato, che la Corte ha ritenuto necessaria, con l’esigenza di dare certezze alle imprese sui costi dei licenziamenti. Purtroppo, ciò non è stato fatto perché nella maggioranza delle forze politiche, a destra come a sinistra, ha prevalso la demagogia di chi guarda ai risultati nel breve periodo.
In effetti, questa è la vera dicotomia: la politica tende a guardare al breve periodo – ossia alle prossime elezioni, nazionali o locali che siano – mentre ciò che serve è uno sguardo lungo sugli interessi di fondo degli italiani.
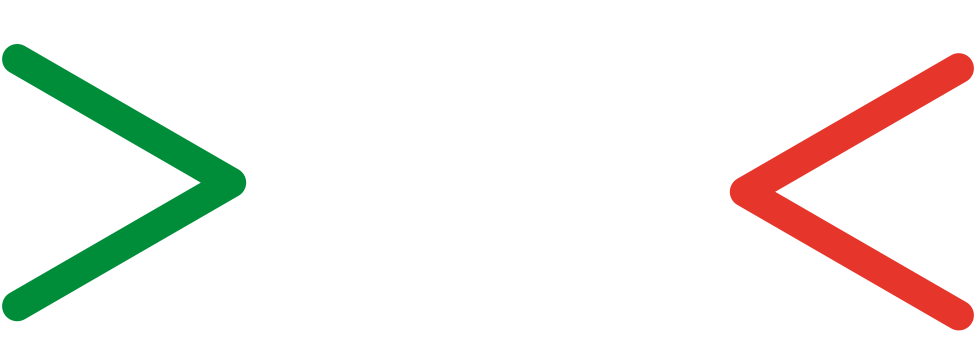
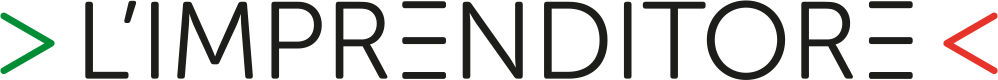
6 commenti