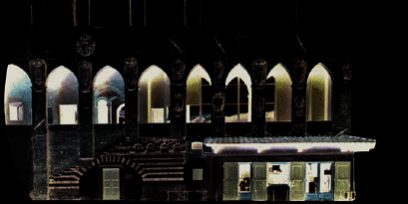
SEMINARIO RESIDENZIALE CSC – II EDIZIONE
Esiste ancora in Italia una direttrice territoriale dello sviluppo manifatturiero? Ovvero, è possibile identificare aree che si muovono insieme e che condividono tratti evolutivi? A partire dall’inizio del nuovo secolo sembra proprio di no. Per molti anni lo sviluppo della manifattura italiana ha coinciso con una crescente articolazione del sistema territoriale: a mano a mano che si faceva più complessa – e che investiva nuovi territori – l’industria cambiava forma, dando vita nei “nuovi” territori a modalità di organizzazione della produzione diverse da quelle del passato. Quella che per molto tempo è stata una caratteristica definita del modello di industrializzazione dell’Italia (diffusione delle attività manifatturiere verso le aree meno industrializzate, secondo un meccanismo di graduale e quasi regolare filtering down) appare tuttavia ormai dissipata e i diversi ambiti territoriali sembrano attualmente procedere in ordine sparso. L’evoluzione della manifattura a livello locale ha assunto l’aspetto di un patchwork, in cui le diverse aree si muovono ciascuna per conto proprio (si veda figura nella pagina successiva). Il punto è che gli anni della globalizzazione, e poi della crisi, hanno ristretto i confini della manifattura, che in molte industrie solo ora sta cominciando a recuperare i livelli pre-crisi. Anche se una parte di questo ridimensionamento si accompagna in molte aree a una crescita dei servizi, si può dire che la forza dei territori nella fase attuale si esprima principalmente – piuttosto che come capacità di espandersi – sul piano della resilienza: ovvero come capacità di resistere agli shock che li hanno colpiti dall’esterno. Un maggiore grado di resilienza della manifattura è una misura di quanto un territorio riesca a garantire stabili livelli di occupazione, l’identità sociale dei luoghi e più in generale il presidio delle diverse aree. Perché le imprese sono prima di tutto infrastrutture sociali che “organizzano” lo spazio. Come si misura il grado di resilienza di un territorio? Il modo più semplice di guardare al problema è quello di considerarlo sul piano per così dire meccanico (resilienza cosiddetta “ingegneristica”). C’è un equilibrio che è stato perturbato da uno shock esterno e che va ripristinato. Il sistema deve recuperare la posizione perduta, come fosse una sbarra d’acciaio che viene flessa e una volta rilasciata torna com’era per forma e posizione. In questo caso l’attenzione è tutta sul grado di elasticità del sistema, da cui dipende la sua velocità di reazione. Ma i sistemi economici non sono meccanismi omeostatici, che tendono per loro natura all’equilibrio; dopo essere stati perturbati non tornano allo stato iniziale da soli. Anche perché gli shock non sono eventi “puntuali”: che arrivano, colpiscono e se ne vanno. Gli shock tipicamente arrivano per restare (neanche un terremoto o un uragano sono eventi che passano senza effetti persistenti) e, anche se non restano per sempre, la loro durata determina comunque l’ingresso in un percorso di adattamento. Quando i contesti cambiano, devono cambiare anche le strategie. E dunque accade che un sistema, un territorio, introduca i cambiamenti che nel frattempo servono a evitare il suo declino, così spostandosi dalla sua traiettoria inerziale. Quando lo shock viene meno, il sistema è già cambiato e non torna più dove era prima.Ma quali sono le condizioni che rendono un territorio più resistente di un altro? E in particolare, di fronte a uno shock strutturale è meglio disporre di una diversificazione merceologica elevata – come sostiene una parte della letteratura economica – o essere specializzati? La risposta varia a seconda che si consideri un intero paese, una macro-ripartizione territoriale (insieme di regioni), una regione (insieme di province), una provincia (insieme di comuni), un comune (insieme di municipi). La diversificazione non si crea facilmente. Le conoscenze che servono per ampliare la gamma dei beni prodotti maturano lentamente e in modo cumulativo, e senza “salti” merceologici. La componente endogena dello sviluppo produce cioè diversificazione solo nel lungo periodo. Ne deriva in generale, a parità di altre condizioni, che la diversificazione dei settori presenti su un territorio dipende dalla sua dimensione e dal suo grado di sviluppo, ossia i territori più diversificati (meno concentrati) sono quelli più grandi e sviluppati. L’estensione della gamma di offerta è un processo che va quindi costruito: le “leggi” dello sviluppo endogeno comportano tempi lenti e se si vuole accelerare il processo di diversificazione bisogna intervenire a livello esogeno attraverso politiche deliberate, come l’attrazione di nuove imprese dall’esterno. Occorre dunque una politica territoriale che, avvalendosi di una conoscenza adeguata dei singoli territori anche sul piano qualitativo, svolga un ruolo attivo nel garantire prima di tutto la loro tenuta e poi il loro sviluppo. Il Centro Studi Confindustria ha avviato a questo riguardo, da poco più di un anno, un “Progetto Territorio”, che ha l’obiettivo di ricostruire il cambiamento della manifattura a livello territoriale e fornirne una chiave di lettura complessiva; ma ha anche lo scopo di identificare “che cosa fare” per sostenerne la tenuta e il rilancio. Un progetto che coinvolge l’intera articolazione del Sistema Confindustria e si avvale di un complesso di conoscenze unico. È la possibile premessa di una politica per le imprese fondata su riscontri fattuali.

