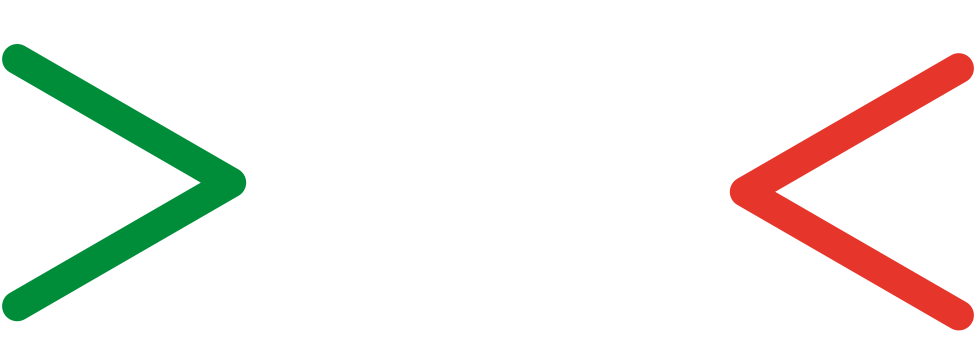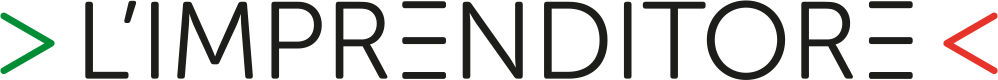MARCO REVELLI
Nel suo viaggio ha percorso un’Italia che cambia e che non riconosce. Perché stenta a riconoscerla?
Perché il cambiamento è stato così rapido e così profondo, il taglio delle radici è stato così radicale, che ho davvero l’impressione di vivere in “another country”. Non si tratta solo del cambiamento economico, tecnologico, produttivo. Non è solo la fine di quell’Italia industriale che aveva compiuto il proprio “miracolo” tra la fine della guerra e la fine degli anni ‘60 intorno all’asse portante del manifatturiero. È un cambiamento anche mentale, culturale, antropologico. È mutato il paesaggio mentale del nostro Paese insieme al suo paesaggio fisico. E questo cambiamento non è stato accompagnato da un adeguato “racconto”, da una narrazione che permettesse di dare un senso a ciò che accadeva. Molti slogan vuoti, certo. Discorsi rassicuranti su quanto sia bello il post-industriale senza più tutto quel grigio, quel ferro e quel lavoro. O su come era noioso quel fordismo tutto fabbrica e quartiere. E intanto ci aggiravamo nelle nostre periferie delabré tra vuoti produttivi rugginosi e hard discount o “Compro oro“. Ho sentito il bisogno di mettere i piedi sulla strada e costruire un mio racconto, non pretendo vero in assoluto, ma quantomeno non reticente, scrivendo quel che vedevo, ascoltavo, intuivo dietro i volti e i silenzi.
Ha trovato significativi “punti di forza” nelle persone che via via ha incontrato e dove in special modo?
In ogni tappa del mio viaggio – dalla Brianza alla Marca trevigiana al “distretto di Prato fino alla tragedia di Taranto e alla Piana di Gioia Tauro – ho trovato, accanto a molte macerie, almeno un punto di forza, nelle persone più che nelle istituzioni, che fossero i geniali makers del tool-box fab lab di Torino o le imprese high tech del Nordest o gli uomini-ponte di Prato. Ma è soprattutto a Gioia Tauro, per altri aspetti una sorta di girone infernale, che ho trovato la speranza: un pugno di uomini che in un contesto pesantissimo resistono. Uno in particolare, Nino De Masi, un imprenditore di altissima qualità e creatività, che rischia la morte tutti i giorni per aver rifiutato di pagare il pizzo, in una fabbrica presidiata dall’eser- cito, sotto scorta continua, consapevole del rischio che corre e tuttavia capace di continuare a sviluppare la propria impresa nonostante le banche gli abbiano imposto tassi d’interesse da usura perché soggetto “a rischio”. Sono quelli come lui le persone che salvano l’Italia.
Il suo viaggio eretico finisce a Lampedusa dove le speranze finiscono. Ha tuttavia intravisto qualche segnale positivo?
Temevo la tappa finale, a Lampedusa. Temevo che il viaggio finisse in un lutto disperato. E invece anche in quel luogo in cui si respira e si vede ogni giornola morte di quanti l’Italia e l’Europa ufficiali hanno abbandonato al mare, anche lì sopravvive un istinto popolare a salvare. È il sostrato antropologico di una civiltà come quella Mediterranea che ha imparato, dalla propria storia, a non abbandonare nessuno in mare.
UNA PAGINA D’AUTORE

Non ti riconosco Un viaggio eretico nell’Italia che cambia di Marco Revelli Einaudi
“Ho incominciato a perdermi nella mia città. O meglio, a non ritrovarmi. Non nel centro, certo, fissato dai recenti restauri in cartolina da consumare (con i piedi, con lo sguardo) più che da abitare. Ma già nella prima periferia sì, nel caos non più calmo delle chiusure (sempre più numerose) e riaperture (sempre più rare), ogni giorno una vetrina che cambia volto, o si spegne; una serranda che non si rialza; una gastronomia che si muta, come per una magia maligna, in hard discount; una chincaglieria, o una piccola gioielleria di quartiere che inalbera la pacchiana ma smagliante insegna gialla e blu dei “compro oro”. Vecchi punti di riferimento che cambiano segno. Linguaggi delle cose fino a ieri amichevoli, o rassicuranti, oggi sordamente minacciosi…”
(tratto da “Non ti riconosco. Un viaggio eretico nell’Italia che cambia”)