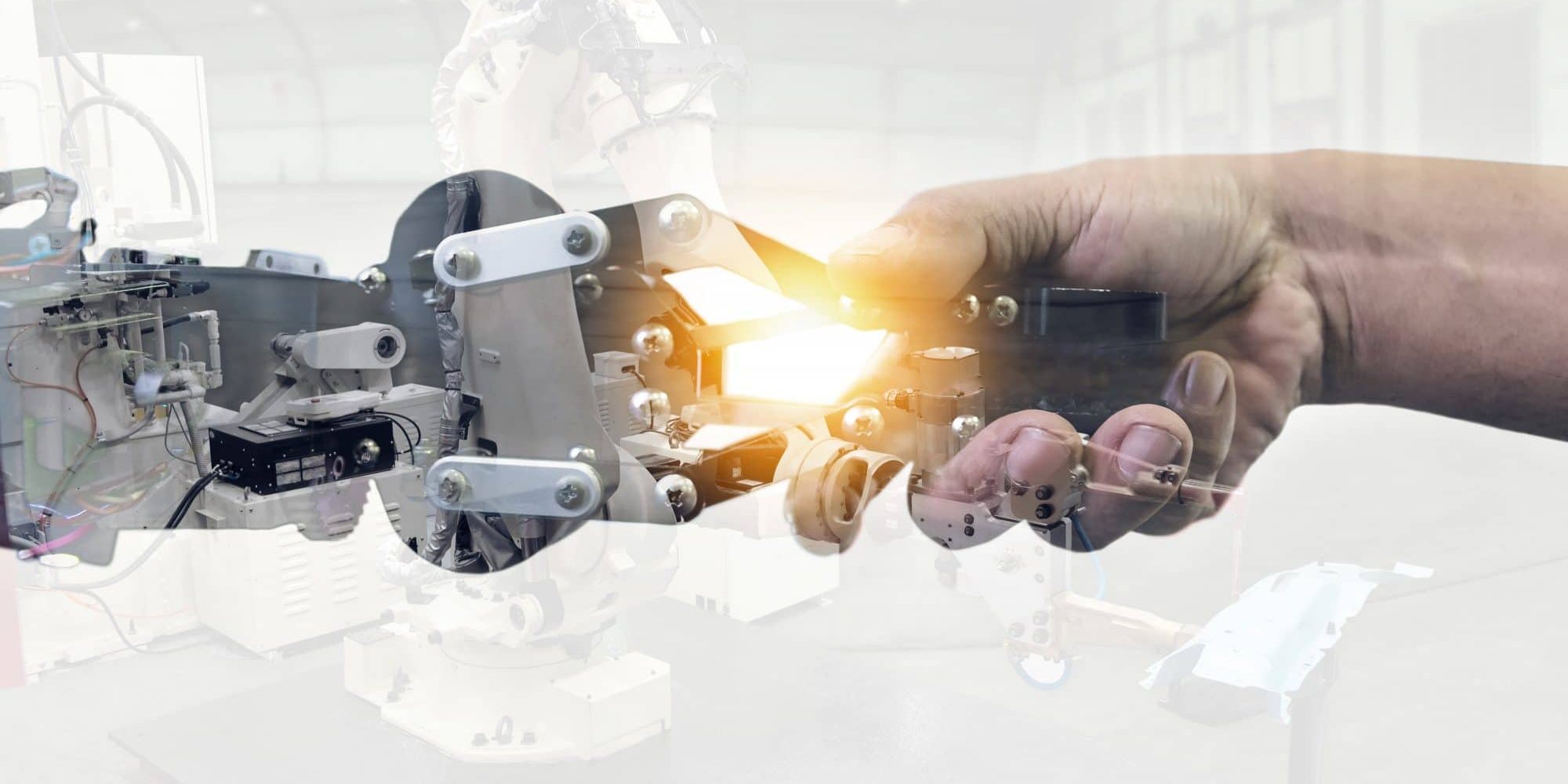
L’avvento della quarta rivoluzione industriale ha diviso gli analisti – e l’opinione pubblica in generale – in due correnti: apocalittici e integrati, per dirla con il grande maestro Umberto Eco. Lei da che parte sta?
Nel corso della storia le innovazioni hanno sempre portato opportunità ma anche generato ansie. La rivoluzione tecnologica in corso è senza precedenti. I più pessimisti vorrebbero ostacolare e rallentare la diffusione delle macchine. All’estremo opposto, c’è chi si dichiara felice di delegare gran parte del lavoro alle macchine per aumentare il tempo libero dell’uomo.
Nessuna delle due strade mi convince. La storia ha infatti dimostrato che una strategia luddista non è praticabile perché è impossibile arrestare il progresso. Quanto alla seconda strategia, essa presuppone una sorta di resa dell’uomo all’avanzata delle macchine, richiede l’introduzione d’importanti meccanismi di redistribuzione e impone un ripensamento della funzione del lavoro stesso (che non significa solo reddito ma ha anche una forte valenza identitaria e sociale).

MARCO MAGNANI
Credo che l’approccio migliore sia quello di una terza via: una collaborazione intelligente tra uomo e macchina. L’idea è di sfruttare le innovazioni per migliorare le prestazioni dell’uomo. La tecnologia fornisce all’uomo l’opportunità di concentrarsi su quelle mansioni che, nell’ambito di ogni professione, generano maggiore valore aggiunto. Quelle basate su caratteristiche difficili da automatizzare, come pensiero critico e creativo, capacità di risolvere problemi e prendere decisioni, empatia e altre dimensioni dell’intelligenza emotiva, attitudini relazionali, sociali e comunicative.
Cosa vuole dire – concretamente – adottare una terza via? Cosa dovrebbero cominciare a fare, da domani, gli imprenditori dentro le loro aziende?
La spartizione dei ruoli tra uomo e macchina all’interno dell’azienda è, in certi casi, inevitabile. Ci sono mansioni che è più efficiente automatizzare completamente perché pesanti o pericolose. Altre che, per loro natura, richiedono esclusivamente il lavoro dell’uomo perché hanno bisogno di particolare creatività o flessibilità.
Tuttavia, nel mezzo ci sono molte attività che possono trarre vantaggio dall’interazione tra uomo e tecnologia, da una collaborazione intelligente tra i due.
Gli esempi non mancano. In molte fabbriche con produzioni complesse sono sempre più diffusi robot collaborativi ed esoscheletri. I primi affiancano l’operaio, interagendo con lui nello stesso ambiente senza separazioni fisiche, e ne aumentano efficienza e produttività. I secondi sono indossati dal lavoratore e ne potenziano capacità fisiche e performance. La combinazione di IoT, Big data e capacità computazionale consente di estrarre, da enormi quantità di dati, informazioni utili per aumentare la produttività del lavoro. In molti settori, l’intelligenza artificiale aiuta i manager a prendere decisioni migliori in minor tempo.
Il connubio uomo-macchina può dare ottimi risultati. Perché ciò avvenga, è importante che l’uomo acquisisca le competenze necessarie per utilizzare al meglio la tecnologia. E che la macchina non sia vista in contrapposizione all’uomo ma come un’opportunità per estenderne le abilità.
 Il secondo capitolo guida il lettore e lo aiuta a orientarsi fra i neologismi di questi anni. IoT, blockchain, big data, cloud, realtà aumentata, intelligenza artificiale, machine learning (e così via) trovano finalmente una spiegazione semplice e chiara. Perché questa scelta? C’era troppa confusione in giro?
Il secondo capitolo guida il lettore e lo aiuta a orientarsi fra i neologismi di questi anni. IoT, blockchain, big data, cloud, realtà aumentata, intelligenza artificiale, machine learning (e così via) trovano finalmente una spiegazione semplice e chiara. Perché questa scelta? C’era troppa confusione in giro?
In effetti c’è confusione e anche un po’ di superficialità. Ho cercato di identificare le innovazioni potenzialmente dirompenti e analizzare opportunità e minacce che ognuna fa emergere, per l’economia e per l’impresa ma anche per qualità di vita dell’uomo, società, politica e etica. Ho anche approfondito le implicazioni per l’occupazione – in termini di professioni distrutte, ridimensionate o fortemente mutate – e cercato d’identificare i nuovi mestieri.
Le innovazioni analizzate sono robotica avanzata, droni, auto senza pilota, stampa 3D e manifattura additiva, Internet delle Cose, Big data, calcolo quantistico, archiviazione cloud e nuvola informatica, intelligenza artificiale (con machine e deep learning), realtà aumentata e virtuale, blockchain, nanotecnologie e nanomateriali, e biotecnologie. Ma non viene trascurato il potenziale dei progressi in stoccaggio di energia, ingegneria del genoma, micro e nano sensori, neurobionica, space economy e infrastruttura 5G.
Peraltro, lo stretto collegamento tra diverse di queste innovazioni, da una parte ne accelera ulteriormente sviluppo e diffusione e dall’altra consente nuove e inaspettate applicazioni. Emblematico è il caso dell’intelligenza artificiale, che amplia e accelera – tra l’altro – sviluppo di robotica, nanotecnologia, scienze dei materiali, editing del genoma umano.
Nel prefigurare un ingresso massiccio dei robot nelle nostre vite si fa spesso riferimento ai problemi etici che potrebbero sorgere e, per questo motivo, all’esigenza di continuare a studiare filosofia, diritto e in generale le scienze umane. Ci fa un esempio pratico di questioni nuove che potremmo essere chiamati a dirimere?
Alcune delle questioni etiche poste dalle nuove tecnologie sono complesse. Si pensi a dati e algoritmi, utilizzati per analizzare il comportamento dei consumatori, prendere decisioni, gestire risorse umane, regolare rapporti con i cittadini. Si tratta di applicazioni con grande potenziale ma notevoli rischi. Come quello che i dati siano usati e manipolati per esercitare interventi invasivi e persuasivi al fine di influenzare decisioni di consumo o scelte politiche. Oppure, nei regimi totalitari, per controllare o reprimere i cittadini.
Un altro esempio è quello dei veicoli a guida autonoma e come sono programmati. In caso di scelta obbligata, è meglio che l’auto senza pilota subisca un incidente frontale, mettendo a rischio i passeggeri, oppure sterzi bruscamente, investendo ciclisti e pedoni? I robot sono addestrati dall’uomo, che ne definisce il comportamento. È quindi indispensabile che chi sviluppa la tecnologia abbia una formazione etica oltre a quella tecnica. Anche perché esiste il rischio che gli algoritmi, se realizzati e istruiti da persone con preconcetti o influenzate da fattori socio-ambientali distorcenti, prendano decisioni discriminatorie.
Certamente i settori di educazione e formazione beneficeranno da un punto di vista occupazionale dall’introduzione di nuove tecnologie. Per la necessità di formare figure professionali adeguate a gestire i nuovi sistemi a livello tecnico e manageriale, ma anche per la crescente domanda di figure con preparazione classica necessarie per affrontare i temi etici.
La questione del lavoro. Per smorzare le paure si dice che scompariranno alcuni mestieri ma ne nasceranno di nuovi e che nelle rivoluzioni precedenti è sempre stato così. Quando la macchina a vapore ha sostituito il bue, il contadino che tirava l’aratro è diventato magazziniere. Ma oggi a quel contadino si chiede di diventare programmatore elettronico, competenze che non si acquisiscono dall’oggi al domani. Cosa si fa?
La tecnologia sta contribuendo a rendere il percorso professionale mutevole, frammentato e ricco di periodi d’inattività. Diventa quindi indispensabile che la formazione sia disponibile per tutto il corso della vita professionale: per facilitare il reinserimento di chi perde il lavoro e per il costante aggiornamento di chi è occupato. Anche perché la frequenza d’introduzione delle innovazioni dirompenti è senza precedenti. Non c’è il tempo sufficiente per metabolizzarle, a volte nemmeno per comprenderle a fondo.
Concretamente, è utile estendere il diritto dei lavoratori di usufruire di permessi di studio, introdurre incentivi fiscali per persone e aziende che investono in formazione, diffondere l’uso di tecnologia per accedere a piattaforme di life long learning, prevedere interventi pubblici mirati per l’alfabetizzazione digitale delle fasce più deboli.
La formazione continua è utile anche per ruoli di leadership e deve comprendere temi di apertura (comprensione di scenari internazionali, quadro macroeconomico, responsabilità sociale) e di frontiera (quali fintech e blockchain). L’obiettivo è aggiungere alla tradizionale capacità di gestire un’organizzazione quella di introdurvi e utilizzare al meglio le innovazioni.
Nel libro lei ricorda la finitezza delle risorse del pianeta. Dobbiamo imparare a comportarci come astronauti piuttosto che come cowboy, per usare la metafora del libro. Secondo lei, chi non l’ha ancora capito?
L’approccio dell’astronauta è caratterizzato dalla prudenza di chi, impegnato in pericolose missioni nello spazio, deve gestire con oculatezza le risorse a disposizione per sopravvivere. Nella metafora dell’astronauta, la Terra è uno spazio chiuso, grande ma non infinito, in fondo non così diverso da una stazione spaziale. È fondamentale acquisire questa sensibilità a temi di scarsità e sostenibilità, e capire che costituiscono seri vincoli alla crescita economica. È anche importante, tuttavia, mantenere lo spirito pionieristico e l’ottimismo del cowboy, per non avere paura di superare le colonne d’Ercole della frontiera tecnologica.
Purtroppo, nonostante l’impatto dei grandi cambiamenti sulla sostenibilità della crescita – ambientale, ma anche energetica, alimentare, demografica, sociale – possa avere conseguenze dirompenti, una buona parte della classe dirigente non sembra preoccuparsene più di tanto. Alla politica sembra mancare sia l’interesse ad affrontare queste sfide, sia la competenza per farlo.
Lo scenario attuale è certamente complesso ma, come spesso accade, è anche una questione di uomini. In passato la politica ha gestito rivoluzioni industriali e altre importanti transizioni economiche con statisti del calibro di Bismarck in Germania e Gladstone e Disraeli nel Regno Unito, Wilson e i due Roosevelt negli Stati Uniti. Tutti leader con visione di lungo periodo che hanno saputo prendere decisioni coraggiose. La sensazione è che oggi, nelle classi dirigenti di molti paesi, queste caratteristiche siano rare.
Ultima domanda: dopo aver scritto il libro si sente più ottimista o pessimista di prima?
Nei due anni impiegati per realizzare questo saggio, ho cercato di comprendere a fondo funzionamento e conseguenze delle principali innovazioni tecnologiche. Questo lavoro di ricerca e analisi mi ha convinto che molte di queste innovazioni, pur ponendo dilemmi etici e prestandosi a rischiose manipolazioni, offrono all’uomo opportunità senza precedenti: in termini di crescita economica, ma anche di miglioramento della qualità di vita.
Più che di ottimismo parlerei quindi di speranza. Siamo di fronte a una grande sfida. L’auspicio è che l’uomo sappia affrontarla con coraggio e passione, e che riesca a governarla, come tante volte ha fatto nel corso della storia. E che possa, ancora una volta, dimostrare che fatti non fummo a viver come ròbot!

