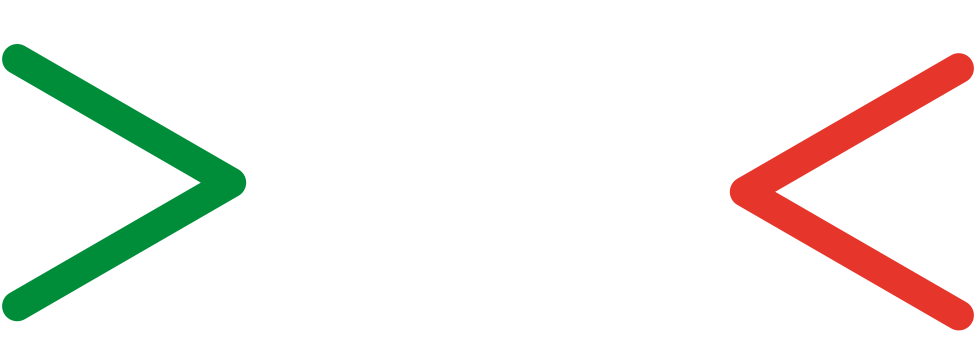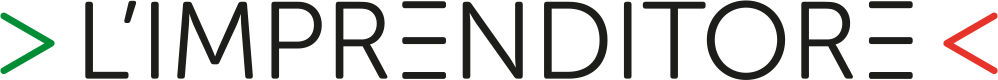MASSIMO BECCARELLO
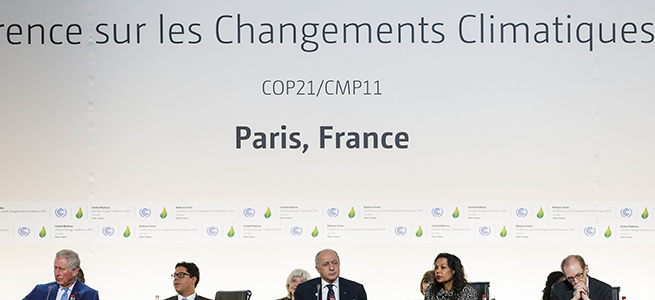 La ventunesima Conferenza, tenutasi a Parigi lo scorso dicembre, delle Parti dell’Unfccc (COP21), costituisce una tappa fondamentale nello sviluppo della politica internazionale di lotta ai cambiamenti climatici. Per la prima volta nella storia 195 paesi hanno sottoscritto un accordo globale che ha lo scopo di affrontare una delle più importanti sfide del nostro tempo: contenere il surriscaldamento del pianeta entro i limiti di sostenibilità stabiliti dalla comunità scientifica. L’obiettivo che ci si è posti è particolarmente ambizioso e ben definito: contenere l’innalzamento medio delle temperature al di sotto del 2°C rispetto ai livelli preindustriali, sforzandosi di limitarlo a 1,5 °C. Meno chiari sono gli strumenti per raggiungere l’obiettivo, dato che non emerge dal testo dell’Accordo un metodo condiviso per ridurre le emissioni in maniera efficace ed equilibrata.
La ventunesima Conferenza, tenutasi a Parigi lo scorso dicembre, delle Parti dell’Unfccc (COP21), costituisce una tappa fondamentale nello sviluppo della politica internazionale di lotta ai cambiamenti climatici. Per la prima volta nella storia 195 paesi hanno sottoscritto un accordo globale che ha lo scopo di affrontare una delle più importanti sfide del nostro tempo: contenere il surriscaldamento del pianeta entro i limiti di sostenibilità stabiliti dalla comunità scientifica. L’obiettivo che ci si è posti è particolarmente ambizioso e ben definito: contenere l’innalzamento medio delle temperature al di sotto del 2°C rispetto ai livelli preindustriali, sforzandosi di limitarlo a 1,5 °C. Meno chiari sono gli strumenti per raggiungere l’obiettivo, dato che non emerge dal testo dell’Accordo un metodo condiviso per ridurre le emissioni in maniera efficace ed equilibrata.
L’Accordo di Parigi è prima di tutto un successo politico, per il quale un grande merito va riconosciuto all’Unione Europea (e ai suoi Stati membri), che da circa vent’anni mantiene la leadership indiscussa nella lotta ai cambiamenti climatici.
Il principale merito del testo sottoscritto è quello di formalizzare una responsabilità condivisa nella sfida globale al surriscaldamento del pianeta, sfida che da oggi non interessa più solo il club dei paesi che ai tempi del Protocollo di Kyoto potevano dirsi “ricchi”, ma tutti i firmatari dell’Accordo, anche se con alcune differenze.
Negli ultimi venti anni la globalizzazione ha stravolto gli equilibri che contrapponevano un occidente ricco di risorse e know-how a intere aree del mondo che si affacciavano appena alla modernità. Oggi l’economia globale è trainata proprio da quei paesi che ponevano al centro dell’agenda politica il solo imperativo della crescita economica, ad ogni costo e con ogni mezzo: si pensi ai paesi BRICS o al sud-est asiatico, le cui performance in termini di PIL sono ben più dinamiche di quelle della vecchia Europa. Il successo di Parigi sta proprio nel riconoscimento che la sostenibilità ambientale va di pari passo con lo sviluppo economico, e che per raggiungere gli ambiziosi obiettivi condivisi dalla Comunità internazionale, sarà necessario lo sforzo di tutti.In questo contesto, l’Europa vede confermati i propri obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050, per i quali continuerà a sviluppare le politiche stabilite dal Pacchetto Clima-Energia e dalla strategia sull’Energy Union.
 Tali obiettivi sono stati universalmente riconosciuti come i più ambiziosi a livello globale e dovrebbero imporsi come standard per le altre aree economiche del mondo, che ad oggi non hanno messo sul tavolo sforzi si mitigazione e contenimento delle emissioni equiparabili. Difatti, non possiamo parlare seriamente di lotta ai cambiamenti climatici globali se non teniamo in considerazione che l’Unione Europea è l’unica area economica del pianeta ad aver adottato una normativa vincolante sulla totalità delle emissioni prodotte sul proprio territorio, a fronte di un contributo europeo alle emissioni globali in progressivo calo (oggi è circa il 9%). I cambiamenti di rotta più significativi dovranno riguardare le politiche di mitigazione di quei paesi che oggi prevedono di raggiungere il picco di emissioni fra 15-20 anni, alla luce del fatto che noi europei già nel 2014 abbiamo ridotto le nostre del 23% rispetto ai livelli del 1990. Bisogna infatti ricordare che già nel 2008 i Capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea avevano indicato come linea-guida di lungo periodo il taglio delle emissioni dell’85-90% entro il 2050, obiettivo poi confermato dalla Roadmap verso un economia a basso contenuto di carbonio del 2011.
Tali obiettivi sono stati universalmente riconosciuti come i più ambiziosi a livello globale e dovrebbero imporsi come standard per le altre aree economiche del mondo, che ad oggi non hanno messo sul tavolo sforzi si mitigazione e contenimento delle emissioni equiparabili. Difatti, non possiamo parlare seriamente di lotta ai cambiamenti climatici globali se non teniamo in considerazione che l’Unione Europea è l’unica area economica del pianeta ad aver adottato una normativa vincolante sulla totalità delle emissioni prodotte sul proprio territorio, a fronte di un contributo europeo alle emissioni globali in progressivo calo (oggi è circa il 9%). I cambiamenti di rotta più significativi dovranno riguardare le politiche di mitigazione di quei paesi che oggi prevedono di raggiungere il picco di emissioni fra 15-20 anni, alla luce del fatto che noi europei già nel 2014 abbiamo ridotto le nostre del 23% rispetto ai livelli del 1990. Bisogna infatti ricordare che già nel 2008 i Capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea avevano indicato come linea-guida di lungo periodo il taglio delle emissioni dell’85-90% entro il 2050, obiettivo poi confermato dalla Roadmap verso un economia a basso contenuto di carbonio del 2011.
Ciò premesso, dobbiamo constatare che a Parigi non è stato sposato l’approccio top-down finora adottato dall’Unione Europea, in cui si stabilisce un obiettivo e si impone una legislazione di tipo vincolante per il suo raggiungimento. Si è piuttosto preferito un approccio bottom-up, in cui ogni paese decide, in base alle specificità nazionali, il proprio contributo di riduzione, gli strumenti più idonei per attuarlo e il periodo di riferimento.
Da queste premesse appare chiaro l’intento di alcuni Stati di impegnarsi nello sforzo di riduzione delle emissioni globali, senza però compromettere le proprie ambizioni future in termini di crescita economica e sviluppo (ad esempio, la Cina, che oggi conta per oltre un quarto delle emissioni, prevede di raggiungere il picco emissivo solo nel 2030, per poi iniziare un processo di graduale riduzione).
L’estrema eterogeneità dei piani nazionali sul clima, che costituiscono la colonna portante per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione, mina alla radice l’idea di creare uno strumento unico – ad esempio un mercato globale delle emissioni – e quindi di garantire un level playing field tra chi dovrà sostenere gli oneri della sfida al surriscaldamento globale.
In questo contesto, è fondamentale che il costo sostenuto dalle imprese europee per la lotta ai cambiamenti climatici non sia unilaterale, pena la delocalizzazione progressiva di interi comparti produttivi. Purtroppo dobbiamo constatare che a Parigi non si è riusciti a cogliere quella che per noi è una precondizione della sostenibilità ambientale, cioè il level playing field tra competitori del mercato globale. Nel testo non si fa mai cenno, se non per sommi capi, ai carbon markets, al carbon pricing più in generale o a sistemi di carbon tax come parte della fiscalità ambientale, segno che la comunità internazionale non è ancora pronta a sviluppare un metodo condiviso per ridurre le emissioni.
 Se è vero che le nostre imprese sono all’avanguardia nello sviluppo di processi produttivi sempre più sostenibili, chiedere alla manifattura di sostenere i maggiori oneri della decarbonizzazione rischia di spiazzare molte produzioni, anche a livello nazionale.
Se è vero che le nostre imprese sono all’avanguardia nello sviluppo di processi produttivi sempre più sostenibili, chiedere alla manifattura di sostenere i maggiori oneri della decarbonizzazione rischia di spiazzare molte produzioni, anche a livello nazionale.
Bisogna infatti considerare che una percentuale significativa del nostro settore manifatturiero rientra nel meccanismo europeo di scambio di quote di CO2 (ETS), la cui riforma è in corso in questi mesi a Bruxelles. L’ETS, che comprende circa 11.000 impianti in Europa, rappresenta il principale strumento della politica climatica ed energetica dell’Unione Europea e la sua riforma è una tappa fondamentale verso il percorso segnato dall’Accordo di Parigi.
Purtroppo, dalla proposta della Commissione europea per la regolazione del meccanismo nel periodo 2021-2030 emergono più problemi che soluzioni, poiché è altamente probabile che l’assegnazione di quote a titolo gratuito ai settori esposti al rischio di delocalizzazione, che oggi costituisce il principale strumento a tutela della nostra industria, non sia sufficiente a garantire gli impianti coinvolti dal rischio di “dumping ambientale”.
Peraltro, lo scenario di decarbonizzazione impone scelte radicali nel settore dell’approvvigionamento, della produzione e del consumo di energia, che pesa per circa il 70% delle emissioni globali.
In Europa il settore termoelettrico già da anni investe ingenti risorse nella trasformazione in chiave ‘green’ dei propri processi produttivi e, in Italia in particolare, la produzione di energia da fonti rinnovabili è tra le più significative del continente.Anche il settore industriale ha dimostrato di poter efficientare le proprie produzioni in maniera significativa, come mostrano i più recenti dati di prestigiosi istituti internazionali (OCSE, Agenzia Europea dell’Ambiente) e nazionali (Rapporto GreenItaly 2015, Relazione sullo stato della Green Economy in Italia a cura del Consiglio Nazionale per la Green Economy).
Altri settori, che pur contribuiscono in maniera importante alle emissioni climalternati, come i trasporti e il residenziale, offrono margini più ampi di riduzione delle emissioni, poiché fino ad ora hanno contribuito in maniera meno significativa al percorso di decarbonizzazione.
In questo frangente, il progresso tecnologico giocherà un ruolo fondamentale, tanto nei paesi industrializzati quanto in quelli in fase di transizione: lo sviluppo di nuove tecnologie è infatti essenziale per garantire l’efficacia degli sforzi che i paesi sviluppati dovranno compiere sul fronte interno ed è anche una conditio sine qua non dei processi di trasferimento tecnologico verso i paesi in via di sviluppo.
È evidente che gli obiettivi posti dall’Accordo di Parigi richiederanno un avanzamento sempre più repentino della frontiera tecnologica, nella direzione di una “zero emissions economy”.
Se l’intento è sicuramente condivisibile da un punto di vista teorico, risulta molto più arduo valutare gli effetti che questo percorso avrà sugli attuali sistemi economici, e infatti non è un caso che l’Accordo di Parigi rimandi ai Governi nazionali la definizione di strumenti adeguati per raggiungere l’obiettivo.
L’unica certezza, ad oggi, è che una trasformazione di tale portata avrà impatti non trascurabili sugli attuali assetti produttivi, così come sulla modalità di trasporto e urbanizzazione. In definitiva, si creeranno nuovi posto di lavoro, ma se ne perderanno altri e, nel medio termine, le conseguenze sui sistemi di welfare e sulle finanze pubbliche potrebbero creare tensioni sociali non trascurabili, soprattutto se non accompagnate da adeguate misure di supporto.
In questo frangente deve inserirsi la visione strategica dei singoli Governi, che affianchi agli investimenti del settore privato un chiaro e coerente impegno dello Stato, il quale dovrà essere in grado di orientare opportunamente le politiche pubbliche (fiscali, industriali, di R&I) verso i settori strategici per la trasformazione dell’economia in chiave ‘green’: bisogna già da ora impostare una strategia di lungo periodo che coinvolga in maniera proattiva enti pubblici e privati nel finanziamento alla politica di lotta ai cambiamenti climatici, i cui costi dovranno essere ripartiti equamente tra i diversi settori dell’economia.
 Auspicalmente, in Italia potremo sfruttare l’occasione offerta dall’annunciato ‘Green Act’, non solo per garantire il contributo del nostro paese al Green Climate Fund confermato dalla COP21, ma anche per rivedere i principi cardine che governano la complessa fiscalità ambientale ed energetica del nostro paese.
Auspicalmente, in Italia potremo sfruttare l’occasione offerta dall’annunciato ‘Green Act’, non solo per garantire il contributo del nostro paese al Green Climate Fund confermato dalla COP21, ma anche per rivedere i principi cardine che governano la complessa fiscalità ambientale ed energetica del nostro paese.
Da ultimo, è chiaro che la transizione verso un’economia low-carbon dovrà essere equa: a Parigi sono stati infatti confermati i principi, già riconosciuti dal Protocollo di Kyoto, delle ‘common but differentiated responsibilities’, secondo cui i paesi che meno hanno contribuito alle emissioni globali devono partecipare in maniera proporzionale alla loro riduzione. A questo si aggiunga il principio del ‘loss and damage’, che consiste nel riconoscimento di una sorta di “risarcimento danni” per i paesi in via di sviluppo impattati da cambiamenti climatici ai quali da soli non possono far fronte.
Questi due principi, insieme al fondo da 100 miliardi di dollari per finanziare il ‘capacity building’ nelle aree più povere del mondo, dovrebbero garantire l’equità della transizione energetica ed economica.
Bisogna però fare molta attenzione alle modalità con cui queste ingenti somme di denaro verranno effettivamente spese e a chi saranno destinate. Per le imprese italiane ed europee il rischio concreto è che competitor di aree del mondo oramai ampiamente sviluppate, come la Cina, l’India e il Brasile, godano di vantaggi competitivi dovuti non solo ai vincoli ambientali meno severi imposti nelle rispettive giurisdizioni, ma anche di aiuti pubblici che i nostri sistemi economici non possono garantire. Si tratta di fattori che inevitabilmente andranno ad impattare sulla competitività, e sulla stessa composizione, dei nostri tessuti produttivi.