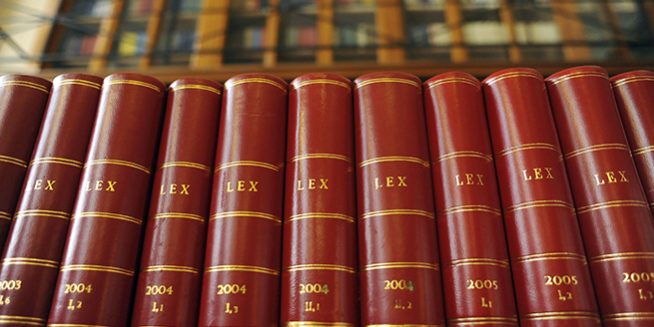
Il legislatore – attraverso il c.d. Jobs act – intende semplificare e razionalizzare la materia della salute e sicurezza sul lavoro ed, in particolare, alcune procedure ed adempimenti ad essa correlati, eliminando e semplificando norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi. L’analisi che segue evidenzia i motivi e la direzione di alcuni interventi di semplificazione.
Lavorare in sicurezza costituisce un valore per ogni impresa ed inoltre rappresenta anche un fattore decisivo per la ripresa economica, essendo elemento di qualità e competitività. Per questo motivo sono necessarie regole chiare e certe, semplici da applicare, che consentano all’impresa di mettere in atto misure di prevenzione efficaci a tutela dei lavoratori.
Il nostro sistema normativo, a causa della mancanza di certezza del diritto, non consente alle imprese di conoscere ex ante i propri obblighi sanzionati penalmente e gli adempimenti necessari per rispettare la legge, rendendo gravosa, quindi, una programmazione coerente delle azioni di miglioramento delle condizioni di sicurezza, il vero profilo di rilievo nell’approccio comunitario alla sicurezza sul lavoro.
L’impianto legislativo si fonda su previsioni specifiche e su norme a tratto generale che (come l’art. 2087 del codice civile) non individuano comportamenti puntuali, ma impongono genericamente all’imprenditore di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Per la giurisprudenza si tratta del fondamentale criterio interpretativo (e norma di chiusura, alla quale fare riferimento in mancanza di prescrizioni specifiche) di tutta la legislazione in materia di salute e sicurezza, necessaria in quanto le normative (specifiche e puntuali) non possono esaurire ed attualizzare tutte le possibili prescrizioni atte a governare compiutamente rischi indicibilmente vari e complessi. Per questo la normativa cautelare ha bisogno di essere integrata da sapere scientifico e tecnologico che reca il vero nucleo attualizzato della disciplina prevenzionistica. L’obbligo giuridico nascente dalla attualizzata considerazione dell’accreditato sapere scientifico e tecnologico è talmente pregnante che è sicuramente destinato a prevalere su quello eventualmente derivante da una disciplina legale incompleta o non aggiornata. Quindi, la responsabilità penale dell’imprenditore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c., la quale, per come interpretata, impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.
 In questo quadro normativo di totale indeterminatezza si collocano sia gli impropri obblighi in tema di vigilanza laddove rendono sempre penalmente responsabile il datore di lavoro anche per eventi riconducibili a responsabilità altrui, sia la responsabilizzazione penale e civile del datore di lavoro in tema di malattie professionali anche per fattori extraprofessionali.
In questo quadro normativo di totale indeterminatezza si collocano sia gli impropri obblighi in tema di vigilanza laddove rendono sempre penalmente responsabile il datore di lavoro anche per eventi riconducibili a responsabilità altrui, sia la responsabilizzazione penale e civile del datore di lavoro in tema di malattie professionali anche per fattori extraprofessionali.
Questa interpretazione (che dall’emanazione del codice civile nel 1942 ha attraversato indenne la rivoluzione copernicana introdotta dalla Direttiva madre del 1989) non è in linea né con il diritto comunitario né con quello costituzionale né con i principi fondamentali del nostro ordinamento.
Nel 2001 la Corte di Giustizia europea ha condannato l’Italia perché l’approccio prescelto dalle autorità italiane si risolve nella predisposizione di un quadro normativo comprendente, da un lato, disposizioni specifiche e, dall’altro, principi di carattere generale che non garantiscono in modo chiaro e inequivoco il livello minimo di protezione voluto da quest’ultima. La Commissione europea sostiene che il sistema italiano obbedisce ad una logica che, sebbene rispettabile, è diversa e incompatibile con quella della detta direttiva, offrendo agli interessati un grado inferiore di chiarezza e precisione e finendo con il compromettere il diritto di questi ultimi a conoscere i diritti loro spettanti e ad avvalersene dinanzi ai giudici nazionali.
In precedenza, nel 2000, l’Italia era stata condannata per non aver correttamente recepito la direttiva 89/391/CE in quanto l’obbligo generale di cui all’art. 2087 del codice civile (sulla base del quale l’Italia si era difesa) non corrisponde all’obbligo specifico di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ai fini perseguiti dalla direttiva e l’esistenza dell’art. 2087 del codice civile non può quindi dispensare la Repubblica italiana dal trasporre correttamente la direttiva nel diritto interno.
Attualmente pende una analoga procedura contro l’Italia e il governo difende l’impostazione ancora una volta attraverso il riferimento alla norma generale dell’art. 2087 del codice civile. La Commissione, per parte sua, conferma nuovamente che le spiegazioni delle autorità italiane non danno una chiara indicazione di ciò che è considerato reato e di ciò che non lo è, né di come avvenga la scelta (reversibile) né di come l’art. 2087 possa, nel caso degli illeciti civili, valere come “norma di chiusura”. Di conseguenza non è stabilito che questo sistema sia sufficiente ad assicurare la certezza del diritto.
La Corte costituzionale (sent. 312/1996) ha ritenuto questa impostazione incompatibile con la costituzione a meno che non si operi un notevole restringimento della discrezionalità dell’interprete, nel senso che le norme c.d. aperte si devono riferire solamente a misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata sia soltanto la deviazione dei comportamenti dell’imprenditore dagli standard di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive.
Nella logica della certezza del diritto, al livello nazionale, lo Statuto delle imprese (L. n. 180/2011), norma fondamentale di riforma economico-sociale e principio dell’ordinamento giuridico, sancisce il diritto dell’impresa ad operare un contesto normativo certo, riducendo al minimo i margini di discrezionalità amministrativa. Per la legge n. 183/2011, poi, gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse. Sul piano nazionale, secondo la Costituzione (art. 10), l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, ma la Corte di Giustizia ha evidenziato che la tecnica di recepimento della direttiva nell’ordinamento nazionale italiano è diverso e incompatibile con quello comunitario. A livello europeo la strategia 2014-2020 prevede espressamente la necessità di una rivalutazione globale dell’intero corpus legislativo anche nazionale per semplificarlo.
 Evidente il contrasto tra l’impianto normativo nazionale sulla sicurezza e i principi comunitari, costituzionali e fondamentali dell’ordinamento.
Evidente il contrasto tra l’impianto normativo nazionale sulla sicurezza e i principi comunitari, costituzionali e fondamentali dell’ordinamento.
Per superare questo forte contrasto occorre:
individuare in modo tassativo e puntuale gli obblighi del datore di lavoro, riconducendoli a norme penali puntuali ovvero a specifiche norme tecniche da queste puntualmente richiamate e conoscibili ex ante, riconducendo la responsabilità ad ipotesi di colpa specifica e non generica;
prevedere la possibilità di imputare al responsabile esclusivamente i comportamenti colpevoli causalmente diretti ed efficienti nella produzione dell’evento lesivo, da soli idonei a determinare l’evento; razionalizzare e distribuire in modo netto le responsabilità tra i destinatari degli obblighi di sicurezza e di vigilanza secondo le specifiche attribuzioni e sfere di competenza e controllo.
Tutto questo porterebbe ad una concreta semplificazione del corpus legislativo, confermando, in modo concreto e realmente efficace, la sicurezza come cardine nella gestione aziendale.

