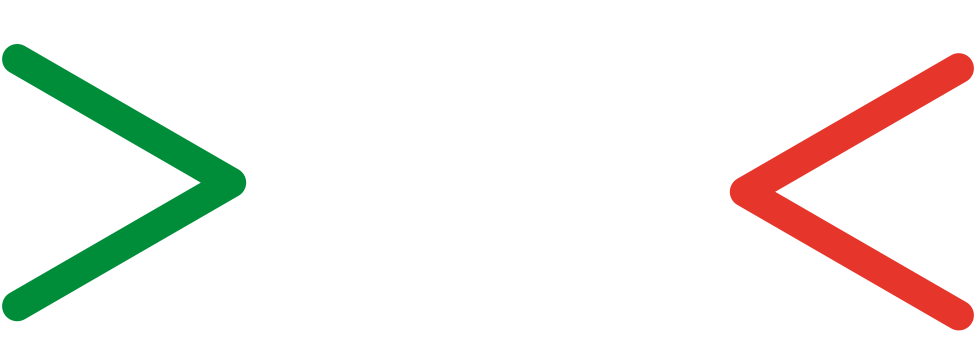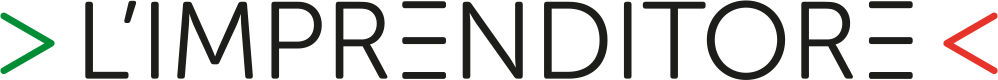Azionisti, consiglio di amministrazione, management e stakeholder. Sono questi i principali attori della corporate governance richiamati nel capitolo di Donato Iacobucci e Alessandro Zattoni, da cui prende avvio la terza parte della ricerca. Sotto la lente le aziende viste al loro interno, partendo proprio dall’analisi di quei meccanismi di corporate governance che, ricordano gli autori, “non hanno solo l’obiettivo di evitare comportamenti opportunistici da parte di chi controlla l’impresa, ma possono anche favorire la creazione di valore per gli azionisti e gli stakeholder dell’impresa”. Il capitolo esamina, nell’ordine, l’allocazione dei diritti proprietari, la composizione del consiglio di amministrazione e il funzionamento dei piani di incentivazione collegati al rendimento aziendale. L’insieme di questi strumenti viene poi riportato al caso più diffuso nel sistema industriale italiano, ovvero quello della piccola e media impresa. Con una puntualizzazione: il modello classico, nel quale proprietà, controllo e direzione si sovrappongono, non è l’unico esistente ed i gruppi di impresa e le startup innovative forniscono un ottimo esempio di complessità degli assetti proprietari e di controllo. Inoltre, le seconde si distinguono in particolare “fin dalle fasi di avvio per un elevato livello di trasparenza e comunicazione riguardo alle loro strategie”, notazione questa che consente agli autori di approfondire l’importanza della trasparenza stessa. Oggi infatti è una delle “condizioni essenziali per favorire la collaborazione degli stakeholder e la capacità di attrarre risorse umane e finanziarie”, in quanto, concludono Iacobucci e Zattoni “le nuove condizioni di tecnologia e di mercato impongono anche alle Pmi di abbandonare il tradizionale meccanismo di finanziamento esterno basato sulla banca per aprirsi a nuove possibilità di reperimento di capitali sul mercato, anche nella forma del capitale di rischio”.
Azionisti, consiglio di amministrazione, management e stakeholder. Sono questi i principali attori della corporate governance richiamati nel capitolo di Donato Iacobucci e Alessandro Zattoni, da cui prende avvio la terza parte della ricerca. Sotto la lente le aziende viste al loro interno, partendo proprio dall’analisi di quei meccanismi di corporate governance che, ricordano gli autori, “non hanno solo l’obiettivo di evitare comportamenti opportunistici da parte di chi controlla l’impresa, ma possono anche favorire la creazione di valore per gli azionisti e gli stakeholder dell’impresa”. Il capitolo esamina, nell’ordine, l’allocazione dei diritti proprietari, la composizione del consiglio di amministrazione e il funzionamento dei piani di incentivazione collegati al rendimento aziendale. L’insieme di questi strumenti viene poi riportato al caso più diffuso nel sistema industriale italiano, ovvero quello della piccola e media impresa. Con una puntualizzazione: il modello classico, nel quale proprietà, controllo e direzione si sovrappongono, non è l’unico esistente ed i gruppi di impresa e le startup innovative forniscono un ottimo esempio di complessità degli assetti proprietari e di controllo. Inoltre, le seconde si distinguono in particolare “fin dalle fasi di avvio per un elevato livello di trasparenza e comunicazione riguardo alle loro strategie”, notazione questa che consente agli autori di approfondire l’importanza della trasparenza stessa. Oggi infatti è una delle “condizioni essenziali per favorire la collaborazione degli stakeholder e la capacità di attrarre risorse umane e finanziarie”, in quanto, concludono Iacobucci e Zattoni “le nuove condizioni di tecnologia e di mercato impongono anche alle Pmi di abbandonare il tradizionale meccanismo di finanziamento esterno basato sulla banca per aprirsi a nuove possibilità di reperimento di capitali sul mercato, anche nella forma del capitale di rischio”.
Pregi e difetti dell’imprenditoria familiare sono al centro della riflessione di Marco Cucculelli e di Livio Romano. Dopo una preliminare definizione, le peculiarità delle imprese familiari vengono analizzate in rapporto alle performance che queste determinano con il fine di comprendere gli eventuali nessi. Nel fare chiarezza all’interno della materia, va detto inoltre che “family business” non sempre fa rima con piccola impresa e che “il controllo da parte delle famiglie coesiste in molti casi con realtà societarie di grandi dimensioni, spesso in concorrenza sui mercati globali”. Diverse, piuttosto, sono le forme in cui tale controllo viene esercitato perché alcune famiglie scelgono di farsi affiancare da manager professionisti, altre delegano in toto agli amministratori mantenendo soltanto “la supervisione sul loro operato”. In merito alle implicazioni di una proprietà concentrata nella mani della famiglia imprenditoriale, emergono senza dubbio alcuni vantaggi: il desiderio di preservare la reputazione o di mantenere il controllo per le generazioni successive induce infatti a una maggiore dedizione, una maggiore responsabilità e al contempo tiene basso il livello di contrasto fra proprietà e lavoratori. Fra i momenti più delicati vi è sicuramente la scelta del top management o il passaggio generazionale; quest’ultimo, fanno notare gli autori, “impone di interrogarsi su quali siano gli ‘asset imprenditoriali’ ancora detenuti e quale il loro valore nel caso si decidesse di trasmetterli alle generazioni successive” e richiede una gestione “che limiti al massimo le divergenze tra gli eredi e il conseguente rischio di lotte di successione”.
Giorgio Brunetti dedica il suo capitolo alle concezioni imprenditoriali dell’impresa. Due i modelli a confronto: nel primo l’imprenditore si identifica con l’azienda e ne è intimamente legato; nel secondo considera il “fare impresa” una professione. Analizzando le rispettive caratteristiche, la concezione identitaria si distingue tendenzialmente per la resistenza alla crescita dimensionale, la riluttanza ad aprire il capitale a terzi, la difficoltà ad assegnare deleghe piene ai collaboratori o ancora il considerare l’azienda come “la naturale fonte di lavoro per i familiari”. Aspetti, questi, molto presenti nelle piccole e medie imprese, ma che negli ultimi anni sono stati messi in discussione dalla crisi e dalla competizione globale. La progressiva ibridazione, secondo l’autore, è avvenuta attraverso il ricorso al management, ma anche grazie alla “riscoperta degli stakeholder”, che ha portato ad una nuova impostazione nel rapporto con i fornitori e con i dipendenti. Il risultato è l’impresa come “comunità che si rapporta con le altre contemperando gli interessi di tutti”.
L’impresa come professione è una concezione più diffusa fuori dall’Italia. “Imprenditori tecnologici” e “imprenditori seriali” sono le due categorie analizzate da Brunetti, accomunate dal fatto di guardare all’impresa “non come un proprio bene da mantenere nel tempo, ma come una realtà dove svolgere una professione stimolante e con la quale procurarsi, se le cose andranno bene, una certa ricchezza”.
 Con Innocenzo Cipolletta il campo di indagine si sposta sul contributo che la finanza apporta alla creazione e allo sviluppo delle imprese, nonostante oggi sia vista come “il male dei mali dopo la crisi globale iniziata nel 2008”. Il sintetico excursus storico con il quale l’autore apre il capitolo rintraccia negli anni Settanta la nascita di un mercato delle imprese, all’interno del quale le aziende “sono valutate sulla base delle loro prospettive, dei fattori di innovazione, della situazione patrimoniale delle professionalità esistenti”. Da qui, inizialmente nel solo mondo anglosassone “si delinea la figura del fondo di private equity”, mentre l’Italia arriverà a questa tappa successivamente, a partire dagli anni Ottanta con primi operatori come Ettore Quadrani e Giorgio Tellini. Oggi il numero degli operatori di private equity e di venture capital ha superato quota 100 e l’Aifi, nata nel 1986 su iniziativa degli economisti Marco Vitale e Anna Gervasoni, è l’associazione che li raggruppa. Accanto ad operatori privati, inoltre, esistono fondi istituzionali di natura pubblica, si pensi per esempio al Fondo italiano di investimento oppure al Fondo strategico italiano.
Con Innocenzo Cipolletta il campo di indagine si sposta sul contributo che la finanza apporta alla creazione e allo sviluppo delle imprese, nonostante oggi sia vista come “il male dei mali dopo la crisi globale iniziata nel 2008”. Il sintetico excursus storico con il quale l’autore apre il capitolo rintraccia negli anni Settanta la nascita di un mercato delle imprese, all’interno del quale le aziende “sono valutate sulla base delle loro prospettive, dei fattori di innovazione, della situazione patrimoniale delle professionalità esistenti”. Da qui, inizialmente nel solo mondo anglosassone “si delinea la figura del fondo di private equity”, mentre l’Italia arriverà a questa tappa successivamente, a partire dagli anni Ottanta con primi operatori come Ettore Quadrani e Giorgio Tellini. Oggi il numero degli operatori di private equity e di venture capital ha superato quota 100 e l’Aifi, nata nel 1986 su iniziativa degli economisti Marco Vitale e Anna Gervasoni, è l’associazione che li raggruppa. Accanto ad operatori privati, inoltre, esistono fondi istituzionali di natura pubblica, si pensi per esempio al Fondo italiano di investimento oppure al Fondo strategico italiano.
Cipolletta precisa come il confronto tra i risultati ottenuti da imprese tradizionali e imprese partecipate da private equity sia naturalmente viziato dal fatto che queste ultime costituiscono di per sé un campione di aziende selezionate. E tuttavia questo parallelo consente di dimostrare che proprio grazie al contributo della finanza il potenziale di queste imprese ha potuto esprimersi al meglio.
La finanza ha cambiato anche la tipologia degli imprenditori nati negli ultimi decenni consentendo per esempio “a molti dirigenti di azienda (…) di fare un salto verso l’imprenditorialità, trasformandosi da dipendenti in azionisti” oppure ha permesso a seconde e terze generazioni di mettersi alla prova senza aspettare passaggi generazionali a volte tardivi. Nel caso più specifico del venture capital, che vede in campo un finanziatore pronto a investire capitale su un’idea da sviluppare, si è osservato come gran parte degli esempi degli ultimi anni provenga dal settore Ict. Uber, Expedia, Airbnb sono i casi forse più clamorosi, ma in generale numerose sono le startup che grazie all’attenzione dei venture capitalist, dei cosiddetti business angels, hanno potuto mettersi alla prova. La conseguenza più significativa – e certamente positiva – è che “si è ricostruito un filo di collegamento tra le università (…) e il mondo dell’impresa, che sta facendo nascere e crescere nuovi imprenditori e soprattutto che sta diffondendo una cultura d’impresa”.