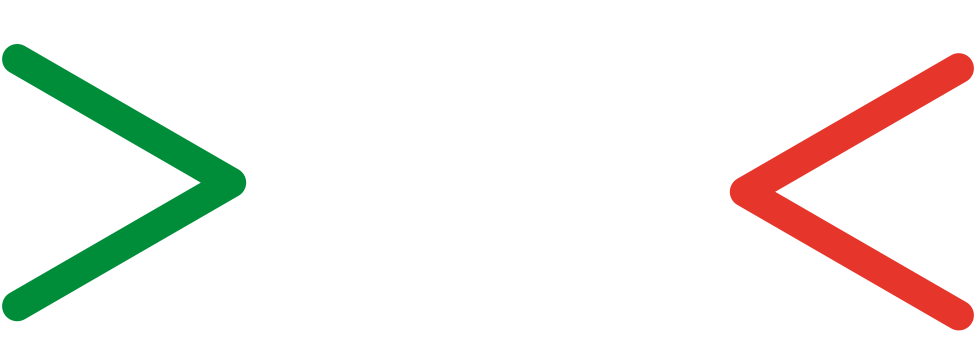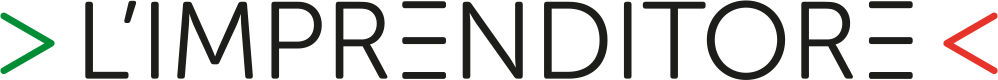Imprenditore va declinato al plurale: imprenditori. Questa notazione di Daniele Marini, autore del quarto capitolo, bene sintetizza il leitmotiv che percorre la seconda parte della ricerca, dedicata alle modalità in cui si manifesta l’imprenditorialità. Dai cinque capitoli che la compongono, infatti, si evince che sono numerose e come sia quasi impossibile tracciare un identikit unico ed esaustivo dei mille volti dell’imprenditore.
Imprenditore va declinato al plurale: imprenditori. Questa notazione di Daniele Marini, autore del quarto capitolo, bene sintetizza il leitmotiv che percorre la seconda parte della ricerca, dedicata alle modalità in cui si manifesta l’imprenditorialità. Dai cinque capitoli che la compongono, infatti, si evince che sono numerose e come sia quasi impossibile tracciare un identikit unico ed esaustivo dei mille volti dell’imprenditore.
Mauro Sylos Labini, nell’analizzarne il ruolo in Italia, prova a rintracciare alcune caratteristiche comuni: “uomini, spesso residenti nel luogo dove sono nati e con una rilevante esperienza lavorativa” sono i primi tratti, a cui va aggiunta, in alcuni casi, la mancanza di alternative. Sono i cosiddetti push-selfed employed, ovvero i lavoratori indipendenti “spinti” dalle avversità economiche, ai quali però non mancano mai altre motivazioni, inclusa la volontà di dare vita a un’idea di business. Gli imprenditori in Italia sono tanti e, fa notare Sylos Labini, “nemmeno la crisi del 2008 o il rallentamento della crescita dell’economia italiana negli ultimi decenni hanno modificato significativamente l’alta intensità imprenditoriale del Paese”.
Nella scelta il livello di istruzione incide, ma non come forse ci si aspetterebbe: la probabilità di lavorare in proprio è più frequente ai poli opposti, ovvero tra chi ha conseguito la licenza elementare e chi è laureato, salvo le specifiche di alcuni settori. Inoltre, il commercio e il settore alberghiero e della ristorazione sembrano presentare meno barriere all’ingresso rispetto al manifatturiero, dove contano di più le competenze e i capitali iniziali. In generale, di nuove imprese ne nascono e i tassi di sopravvivenza sono in linea con quelli degli altri paesi europei, ma diversa è la crescita, più lenta senza dubbio.
Con Samuele Murtinu e Marco Vivarelli entrano in campo nell’analisi altri fattori all’origine dell’imprenditorialità, ovvero di quel “processo di entrata attraverso cui nuove imprese iniziano a partecipare al processo concorrenziale”.
Il background familiare, per esempio, oppure i vincoli finanziari o ancora fattori personali non-economici, quali il desiderio di autonomia, l’aspirazione a sfruttare la precedente esperienza lavorativa, sicché esistono anche i cosiddetti “errori di entrata” ovvero casi in cui gli imprenditori in questione hanno sottovalutato i rischi legati a nicchie di mercato altamente competitive oppure con scarsa profittabilità.
Accanto gli imprenditori realmente innovativi, dunque, convivono “imitatori, scommettitori ultra-ottimisti, persone che scappano dalla disoccupazione”, per questo motivi gli autori invitano alla cautela e a parlare in termini più neutrali di “fondatori di nuove imprese”.
La distinzione non è priva di conseguenze: chi detta la politica industriale di un paese, i cosiddetti policy maker, dovrebbe prestare molta attenzione a questo aspetto, rinunciando a sussidiare genericamente la nascita di nuove imprese per non sprecare risorse pubbliche. Sussidi selettivi, dunque, al posto dei sussidi “a pioggia”, perché da questi ultimi – è il ragionamento degli autori – verrebbero beneficiate imprese che senza l’aiuto non sarebbero mai state fondate e che non sarebbero sopravvissute alla prova del mercato.
Alessandro Arrighetti e Fabio Landini proseguono la riflessione sulla propensione all’imprenditorialità a partire dalla spinta apportata da esperienze lavorative svolte durante gli anni di studio. I due economisti commentano, inoltre, i risultati di una recente indagine condotta dall’Università di Parma e dall’Università Politecnica delle Marche, nella quale si esamina lo spirito “imprenditoriale” degli studenti universitari. Il desiderio di autorealizzazione, precedenti esperienze di lavoro e un network familiare e sociale vivace favoriscono indubbiamente il terreno, mentre al contrario la prospettiva di un reddito elevato non è tra le motivazioni più stringenti.
Sulla scelta pesa anche la percezione degli ostacoli e qui, si potrebbe dire, vengono alla luce fattori in un certo senso già noti, quali la mancanza di capitali iniziali, il carico degli adempimenti fiscali e la congiuntura economica sfavorevole. Limitata anche l’assistenza ottenuta dalle istituzioni mentre l’università, che viene riconosciuta come un incubatore ideale per le competenze imprenditoriali, non esprime in pieno tutto il proprio potenziale.
 Nel complesso l’Italia non incoraggia a diventare imprenditori, lo dimostra lo scarto consistente tra intenzioni dichiarate e realtà dei fatti o il forte pessimismo tra i giovani rispetto alle probabilità di riuscire. Accomunati da ambizioni e da obiettivi, gli imprenditori “scoraggiati” e gli imprenditori “probabili” si differenziano a livello psicologico: valutano diversamente le capacità possedute, le difficoltà e il contesto istituzionale.
Nel complesso l’Italia non incoraggia a diventare imprenditori, lo dimostra lo scarto consistente tra intenzioni dichiarate e realtà dei fatti o il forte pessimismo tra i giovani rispetto alle probabilità di riuscire. Accomunati da ambizioni e da obiettivi, gli imprenditori “scoraggiati” e gli imprenditori “probabili” si differenziano a livello psicologico: valutano diversamente le capacità possedute, le difficoltà e il contesto istituzionale.
Il contributo di Daniele Marini ricorre all’immagine del caleidoscopio per sintetizzare i risultati della ricerca promossa dal Csc e realizzata dall’istituto di ricerca Community Media Research alla fine dello scorso anno. Quella degli imprenditori si presenta, infatti, come una professione imprevedibile e variabile allo stesso modo dei riflessi prodotti dalle tesserine colorate dello strumento, all’interno della quale tuttavia la crisi del 2008 ha rappresentato uno spartiacque.
La stragrande maggioranza sembra aver assorbito il colpo ed esprime “un sentiment di generale apertura sulle conseguenze della crisi”. Non desta timore la domanda di miglioramenti tecnologici, ma è il salto culturale necessario a impensierire di più perché il modus operandi di un imprenditore non cambia dall’oggi al domani.
In generale, fare impresa è percepito come un’attività oggi più complicata rispetto al passato sia per l’accresciuta competizione, sia per la maggiore preparazione professionale richiesta. Non va trascurato il peso della concorrenza sleale, mentre meno problematici appaiono il clima sociale sfavorevole a chi fa impresa e la modesta disponibilità a rischiare da parte dei giovani. Con la crisi sembra essere cambiato anceh il “pacchetto” di abilità richieste per guidare un’impresa: innovazione, lavoro di squadra e capacità di valorizzare i lavoratori hanno scalzato dal primo posto della classifica l’attitudine al rischio. Nonostante le difficoltà, comunque, gli imprenditori restano profondamente legati al loro mestiere e la stragrande maggioranza si definisce soddisfatta.
Massimo Livi Bacci conclude la seconda parte della ricerca raccontando l’imprenditoria immigrata, un fenomeno di estrema attualità se si pensa che in appena quindici anni gli stranieri regolarmente residenti in Italia sono passati dal milione di inizio millennio ai cinque milioni del 2015, costituendo oggi il 10% della popolazione totale.
Per quanto riguarda l’imprenditoria, le aziende straniere sono sicuramente più piccole e meno profittevoli ma, fa notare lo studioso, “sono numerose e in crescita, cominciano ad assumere personale anche italiano e (…) stanno uscendo dal ghetto (e dallo stereotipo) della badante e dell’uomo che si occupa solo delle pulizie o dei piccoli cantieri edili”. Il bacino di indagine si ricava dal registro delle imprese delle Camere di Commercio e dall’Archivio Istat Asia (Archivio statistico delle imprese attive) con la precisazione che è il paese di nascita a determinare la classificazione come imprese straniera; ne consegue che le “seconde generazioni” nate in Italia non vengono incluse. Le comunità imprenditoriali più attive sono, nell’ordine, quella cinese, rumena, albanese, svizzera e marocchina e quello cinese, con la forte presenza nei distretti manifatturieri di Carpi e di Prato, è uno dei casi più studiati.
A influenzare la crescita dell’imprenditoria immigrata concorrono vari fattori, a cominciare da un naturale desiderio di riscatto sociale, più accessibile per gli stranieri tramite un’attività autonoma piuttosto che come lavoratore dipendente e dalla forte domanda di lavoro autonomo esistente nel settore dei servizi, si pensi alla ristorazione, ai piccoli trasporti, alle pulizie e al commercio di strada.