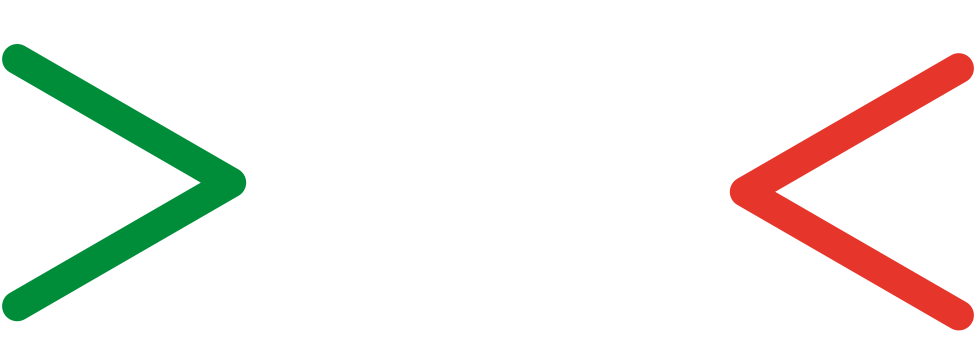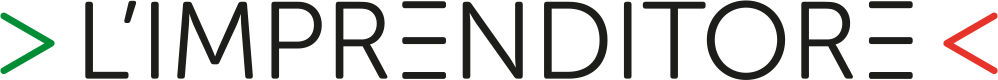Il Mediterraneo è di nuovo al centro della politica internazionale. Quali prospettive per le nostre imprese?

GIULIO TERZI DI SANT’AGATA
Il “Grande Mediterraneo”, che si estende da Gibilterra al Golfo, delinea forti opportunità, specialmente per le Pmi. Riforme strutturali, privatizzazioni, facilitazioni agli investimenti hanno sostenuto tendenze annuali di crescita dal 3,3% all’1,5%. L’Italia rappresenta un partner essenziale e presente storicamente nella regione, con scambi attorno ai 70 miliardi di euro, pari all’8,9% del nostro commercio globale. I migliori risultati sono con Turchia (17 mld), Algeria (7,9 mld), Arabia Saudita (6,7 mld), Emirati Arabi (6,3 mld), Tunisia (5,1 mld) ed Egitto (4,6 mld). Il “Baromed 2017” di Ernst&Young ci pone al settimo posto assoluto per investimenti greenfield nel Mediterraneo nel periodo 2013-2015 e al decimo per mergers&acquisitions, con enfasi su infrastrutture, logistica, costruzioni, agroindustria, rinnovabili, turismo, reti dell’energia e delle telecomunicazioni.
Nel Mediterraneo orientale, Israele rappresenta il partner di gran lunga di maggior rilevanza per le imprese italiane. La sua crescita economica è sostenuta dall’enorme sforzo effettuato in ricerca e sviluppo. Si tratta di una realtà aperta a partenariati internazionali, e in particolare con l’Italia, idonei a contribuire alla trasformazione delle nostre Pmi verso Industria 4.0.
Storicamente l’Italia ha avuto un dialogo privilegiato con alcuni paesi, si pensi ad esempio ai rapporti con la Libia. Oggi qual è la situazione?
Le criticità perdurano. Non si potrà mai sottolineare abbastanza la priorità che ha per l’Italia una Libia governata da istituzioni efficaci, stabili e a noi amiche. L’Isis è stato sconfitto a Sirte, ma è tutt’altro che scomparso nel sud del paese. Niger, Mali, Repubblica Centrafricana, Chad e Sudan sono l’immensa regione che alimenta e subisce quotidiani contraccolpi da ciò che avviene in Libia, dove il potere politico resta diviso fra Tripoli e Tobruk.
Sino all’entrata in campo dell’allora ministro dell’Interno Minniti, Roma si era essenzialmente affidata alle Nazioni Unite, ritenendo inopportune partecipazioni a missioni militari sui confini esterni della Libia, in funzione antiterrorismo e traffici di ogni natura che a esso si collegano. Sul finire del governo Gentiloni l’approccio si è fatto più dinamico anche nei rapporti tra Roma e il Generale Heftar, lasciati troppo a lungo appannaggio francese, americano, emiratino, egiziano e russo.
Credo, però, si debba uscire da una sospettosa rivalità con Parigi per puntare, nel solco della prima visita a Macron da parte del presidente Conte, a una stretta collaborazione italo-francese sul dossier libico. È un partenariato necessario anche per la Francia. Una riflessione diversa, invece, meritano i nostri rapporti economici con l’Iran.
Ovvero?
Le aziende italiane devono essere meglio informate, insieme alle opportunità esistenti in un mercato di 80 milioni di potenziali consumatori, del crescente business risk, che ha comportato nelle ultime settimane il congelamento di molti investimenti e progetti occidentali nel settore petrolifero, aeronautico, dei trasporti, bancario, infrastrutturale e dei beni di largo consumo.
È anche opportuno essere consapevoli delle carenze rilevate dalle istituzioni finanziarie internazionali nel contrasto al riciclaggio con finalità terroristiche e del “rischio sanzioni” per le aziende europee che entrino in contatto con entità legate al Corpo dei Pasdaran – l’Iranian Revolution Guard Corp – il cui controllo sull’intera economia del paese viene stimato superiore al 30% e concentrato nei settori strategici.
Parliamo anche della Cina. Come influisce sulla centralità del Mediterraneo la strategia di una nuova “Via della Seta” marittima e terrestre?
La presenza della Cina nel Grande Mediterraneo cresce, con interessi che vanno ben oltre l’approvvigionamento di idrocarburi. Pechino è diventata uno dei principali fornitori di beni dell’area – nel 2016 l’interscambio è stato pari a 186 miliardi di dollari – superando gli Stati Uniti (148 mld) e distanziando i principali partner europei: Germania (90 mld), Italia (75 mld), Francia (66 mld) e Gran Bretagna (52 mld).
Con il lancio della “Belt and Road Initiative”, Pechino sta investendo massicciamente nei porti del mare nostrum ed è interessata anche a Trieste e Genova.
Come altre economie emergenti, quella cinese afferma la necessità di liberalizzare i mercati, a condizione però di mantenere per i propri altissime protezioni. Il governo cinese applica dazi mediamente doppi alle importazioni dai paesi Ocse rispetto ai dazi praticati da questi ultimi alle importazioni dalla Cina. Elargisce inoltre enormi aiuti di Stato, controlla finanza e investimenti e interferisce su strategie e decisioni delle imprese. Da una parte quindi la Cina è una potenza globale che sembra voler condividere il sistema di regole esistente nella società internazionale, dall’altra appare evidente la sua determinazione a promuovere un parallelo sistema “revisionista”, autonomo e alternativo rispetto all’esistente. L’iniziativa “One Belt One Road” va vista in tale contesto. La promessa di investire mille miliardi di dollari nei mercati interessati dal progetto riguarda il Medio Oriente, il Mediterraneo e l’Europa meridionale.
Come dimostrano le acquisizioni e gli investimenti diretti cinesi in Europa negli ultimi dieci anni, essi sono sbilanciati a nostro sfavore, soprattutto nei comparti strategici – comunicazioni, energia e trasporti marittimi – nei quali Pechino sta entrando, senza che vi sia stata da parte europea una valutazione matura delle conseguenze per settori cruciali dell’economia e della sicurezza nazionale.
Ci sono le condizioni perché possa maturare una posizione unitaria europea?
Il mercato cinese è sostanzialmente chiuso a chiunque operi nell’economia digitale senza essere sottoposto alla cessione di tecnologie e di dati su server ubicati in Cina. Delle 17 più importanti acquisizioni cinesi di società europee tra il 2000 e il 2017 solo 3 o 4 sarebbero potute avvenire a parti invertite con le regole esistenti in tale paese.
Come conseguenza di ciò nell’ultimo decennio gli investimenti diretti cinesi in Europa sono passati da 700 milioni di euro a 30 miliardi, superando di quattro volte quelli europei in Cina, mentre da almeno cinque anni gli investimenti cinesi in Italia nei comparti strategici delle comunicazioni, dell’Ict e dei trasporti marittimi ci hanno fatto perdere posizioni significative di proprietà e di controllo.
Occorre pertanto definire con urgenza obiettivi nazionali e europei. Da alcuni anni il Parlamento europeo e la Commissione hanno agito per evidenziare i problemi che potevano nascere da forme di controllo esteso da parte di Pechino sulle infrastrutture critiche dell’energia, delle comunicazioni, dei trasporti. Non si tratta di una partita facile. Tuttavia sembra delinearsi una maggiore consapevolezza che, con un gigante come la Cina, la sola partita possibile da giocare è quella che vede l’Ue agire nel suo insieme.
Di fronte a questi scenari, cosa suggerire alle Pmi?
La globalizzazione prosegue in forme diverse da quelle tradizionali, trainata dalle tecnologie digitali. Si accresce nel Pil la componente immateriale, intellettuale, di innovazione e ricerca.
Se gli scambi di beni e servizi e l’impulso dato alle catene globali del valore dal basso costo del lavoro si stanno ridimensionando, la diffusione delle nuove tecnologie fa sì che una generalità di attori, fino ad ora esclusa, possa partecipare agli scambi internazionali in una misura sconosciuta in passato, sia che si tratti di piccole aziende o di multinazionali.
Il vero motore della crescita risiede nei flussi digitali ed è questa la sfida per le Pmi.