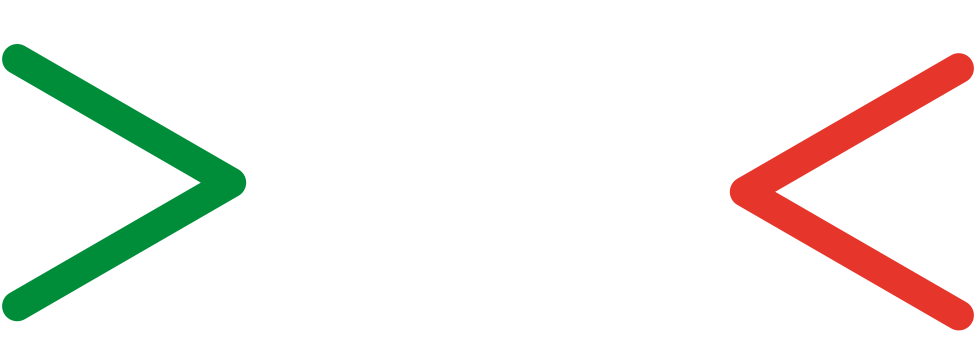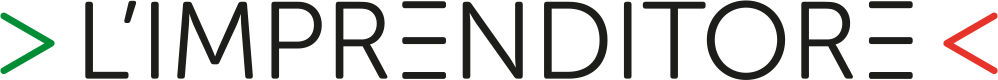La domanda di imprenditorialità cresce perché gli equilibri ereditati dal passato scricchiolano sotto la forza dei cambiamenti della società globale. Parte da questa premessa il capitolo firmato da Enzo Rullani che apre l’ultima parte della ricerca. Archiviati il fordismo della grande impresa del Novecento e il più recente capitalismo flessibile dei distretti industriali, oggi serve un diverso spirito imprenditoriale, che non per forza fa rima con high tech, ma necessariamente deve permeare la grande come la piccola e media impresa. E se è vero che il contesto italiano non aiuta, perché in passato ha sempre separato “l’apprendimento creativo e sperimentale (…) dai processi di istruzione”, è innegabile che le sfide dei nostri tempi chiedono una risposta o comunque di mettersi in gioco molto e più di prima.
In merito Rullani introduce il modello di “imprenditorialità distribuita” affiancandovi una riflessione sul concetto di rischio crescente e insiste sull’importanza di interpretare gli esempi di nuova imprenditorialità “non come casi unici”, ma come “modelli replicabili”. Le high growth firms rappresentano secondo l’autore una peculiarità dei nostri tempi: “imprese dotate di un alto potenziale di profitto e di traiettorie esponenziali di crescita” – si pensi a Uber, Alibaba o Airbnb – che usano al meglio i vantaggi offerti dalla globalizzazione, dall’automazione o ancora dal networking.
In questo scenario anche il mestiere dell’imprenditore sarà costretto a cambiare perché “dovendo guidare altre persone e interessi in un viaggio comune verso il nuovo”, dovrà imprimere senso alla “meta prescelta”. Le qualità necessarie a questo percorso vengono coltivate a sufficienza? Non esattamente. Secondo Rullani, infatti, a livello generale solo da poco “la logica imprenditoriale comincia ad essere adottata da categorie professionali e sociali che un tempo ne erano rimaste distanti”, mentre l’istruzione – e più in generale i processi di formazione – fino ad oggi hanno premiato soprattutto una conoscenza codificata a scapito di una conoscenza generativa, quest’ultima basata su creatività e spirito critico. Da qui alcuni suggerimenti pratici da parte dell’autore per consentire già durante gli anni scolastici di familiarizzare con quelle che saranno le complessità del lavoro.
Con Giangiacomo Nardozzi la ricerca affronta il tema della cultura d’impresa, intesa come lo strumento principe per traghettare il paese fuori dalla “stagnazione secolare”. Non saranno infatti le manovre monetarie a garantire l’uscita dalla crisi o la ripresa della produttività, ma un insieme di fattori a cominciare da una finanza che accetta di tornare al servizio dell’economia e da un efficace contrasto alla dispersione di imprenditorialità, risorsa sempre più scarsa e più preziosa. La cultura d’impresa opera per l’appunto in questa direzione e – avverte l’autore – va sempre letta nella sua doppia accezione, ovvero sia riferita al singolo imprenditore e/o all’impresa, sia riferita al contesto politico-economico in cui le aziende operano.
Qual è stata la sua evoluzione in Italia? Nardozzi sceglie di analizzarla recuperando alcune tappe del percorso di Confindustria come il Manifesto per la cultura d’impresa del 2010 – riportato in appendice – oppure citando il lavoro svolto da Guido Carli alla presidenza della Confederazione “per affermare la cultura della concorrenza, fondamento di quella d’impresa”. Un’azione che all’epoca non fu priva di difficoltà, precisa Nardozzi, il quale ritrova analoga attenzione al tema soltanto nel 2004 con il “Progetto concorrenza” avviato dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Gli studi realizzati e il convegno del 2006 a Vicenza testimoniano la sensibilità all’argomento ma da allora è passato un decennio e, afferma l’autore, “buona parte degli ostacoli alla concorrenza, delle problematiche relative all’azione dell’Autorità ad essa preposta (Agcm) e delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (Aeeg e Agcom) sono tuttora presenti e varie proposte allora avanzate per porvi rimedio ancora valide”.
L’area dove si è esercitata una maggiore cultura del cambiamento è forse quella della piccola e media impresa. Nardozzi riprende il ragionamento partito dal convegno di Palermo del 2009 “Oltre la crisi, Pmi classe dirigente” e approfondisce le conquiste intellettuali più significative: dal salto culturale/dimensionale auspicato da Giuseppe Morandini, all’affermazione che non è sufficiente essere buoni produttori senza divenire imprenditori illustrata da Vincenzo Boccia, fino alla responsabilità sociale promossa da Alberto Baban che, come specifica Nardozzi, “non è solo quel di più che si concretizza in tanti buoni atti di liberalità (…) ma rientra nella stessa funzione degli imprenditori di promuovere il cambiamento”. Ed è con questa crescita di consapevolezza che va spiegata secondo l’autore “la grande fiducia riposta dagli italiani nei piccoli e medi imprenditori come i soggetti che più possono contribuire al progresso economico e sociale”.
L’ultimo capitolo della ricerca è affidato a Nadio Delai e approfondisce il tema della rappresentanza. Dando per acquisiti alcuni aspetti di base – il fatto che le associazioni siano costituite da imprese e non da individui, la “diversità dei processi generativi degli imprenditori”, nonché le differenze createsi fra le imprese stesse a causa della selezione operata dalla crisi – secondo Delai resta immutato il fatto che “un’associazione di rappresentanza non può che ‘assomigliare’ alla propria base per potere essere riconosciuta e legittimata, ma deve contemporaneamente giocare ‘al rialzo’ rispetto ad essa per accompagnarla verso il futuro”. In particolare, lo studioso sottolinea i passaggi chiave con i quali è necessario misurarsi nell’attuale contesto: il ritorno all’economia reale con lo stop a una ricchezza creata esclusivamente dalla finanza; il rientro del sociale nell’economia e il conseguente recupero di fiducia e di un “noi” al posto dell’ “io” e, infine, il superamento delle attese sociali decrescenti che tanto hanno incupito il paese, rinchiudendolo in un atteggiamento di difesa.
Il ruolo associativo non è escluso da questa sfida, anzi è chiamato ad affrontare il “ciclo deflattivo della rappresentanza” trovando nuove strade e allo stesso tempo sapendo investire il patrimonio associativo fino ad oggi accumulato. Prendendo in prestito le parole dello scrittore Massimo Recalcati, Delai afferma che “i sistemi della rappresentanza, affrontando la mutazione necessaria che loro compete, debbono ridiventare adulti un’altra volta”. Come applicare tutto ciò? L’autore non si tira indietro e riepiloga al lettore un serie di punti che a prima vista potrebbero apparire scontati, ma in realtà richiamano il senso profondo del ruolo associativo racchiuso nella triade “identità, rappresentanza, servizi”.
“Diventare dirigenti associativi – spiega più avanti Delai – richiede anche la consapevolezza di assumere un ruolo e delle funzioni altri rispetto a quelli esercitati normalmente nell’ambito dell’azienda” per aggiungere che un’associazione di imprese da un lato “promuove gli interessi dei propri iscritti (…), ma sa anche promuovere gli interessi più vasti del paese”.
Quali dunque le funzioni da svolgere? Interpretazione, proposta e promozione del consenso e, per essere ancora più esplicito, Delai propone un decalogo di “malintesi, sbandamenti, tentazioni” dai quali chiunque si candidi a ricoprire un ruolo di rappresentanza dovrebbe stare lontano. Se ne citeranno solo alcuni, come ad esempio “il farsi tentare dalla discesa in politica” o “il concepire l’associazione come possesso”. Non è un mestiere facile verrebbe da dire e forse per questo l’autore sceglie di concludere il capitolo con un appello a praticare quattro virtù – coraggio, innovazione, tenacia e generosità – per esercitare al meglio il ruolo di classe dirigente e non restare impigliati “nella gestione pura e semplice del quotidiano, nella quale è relativamente facile adagiarsi, trasformandosi in classe ‘gerente’”.