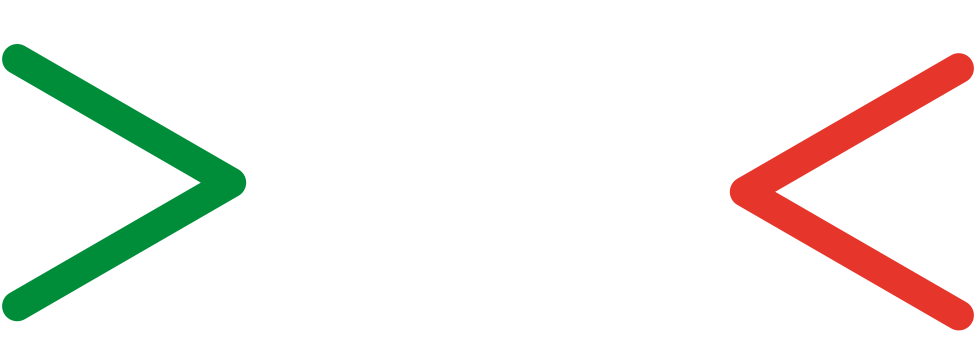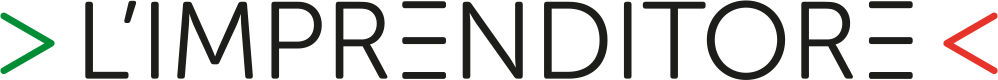“Dopo anni di sforzi per promuovere la credibilità fiscale e le riforme, l’Europa volta pagina”. Con queste parole il neo presidente della Commissione Jean Claude Juncker ha aperto il discorso alla plenaria del Parlamento europeo in cui ha presentato il piano da 300 miliardi per rilanciare gli investimenti.
“Dopo anni di sforzi per promuovere la credibilità fiscale e le riforme, l’Europa volta pagina”. Con queste parole il neo presidente della Commissione Jean Claude Juncker ha aperto il discorso alla plenaria del Parlamento europeo in cui ha presentato il piano da 300 miliardi per rilanciare gli investimenti.
È necessario andare oltre l’austerità e segnare una svolta in direzione della crescita e del lavoro. Il governo italiano sta cercando di spingere per questo cambiamento e gli imprenditori ne condividono lo sforzo. Ne abbiamo parlato con Lisa Ferrarini, Vice Presidente di Confindustria per l’Europa.
Pensa che la nuova Commissione europea sarà in grado di promuovere la crescita in Europa?
È ancora presto per dire se il presidente Juncker avrà la forza di determinare un vero cambio di rotta nella politica economica, andando oltre il dogma dell’austerità e mettendo veramente al centro dell’azione di Bruxelles l’economia reale.
Non si tratta di un’operazione facile, in quanto questo cambio implica sia l’utilizzo della leva dei bilanci pubblici a sostegno della domanda aggregata, sia una maggiore integrazione delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, dove la cessione di sovranità è controbilanciata da incentivi di tipo solidaristico.
In tal senso il recente via libera della Commissione alla legge di stabilità presentata dall’Italia e il riconoscimento di una seppur minima flessibilità nei conti sono un primo segnale positivo, così come l’impegno preso sul fronte del rilancio degli investimenti, anche se, sotto pressione dei paesi rigoristi, la Commissione ha per ora ritirato l’idea di scorporare dal deficit la spesa in investimenti produttivi.
I prossimi mesi saranno cruciali per valutare quanto il presidente Juncker saprà smarcarsi dai governi nazionali, implementando con coraggio una vera agenda per la crescita dove la politica fiscale riacquisti la sua funzione politica, al di là dei tecnicismi.
Quali sono le priorità che l’Unione europea deve affrontare?
Crescita e occupazione. Ormai da tempo cresciamo più lentamente dei nostri competitor globali e abbiamo raggiunto un tasso di disoccupazione pari all’11% a livello Ue. Sono dati allarmanti che necessitano di interventi immediati e di altri di più lungo respiro. Nell’immediato credo che l’azione sul lato della domanda sia fondamentale e ineludibile. Dobbiamo supportare i consumi, ma anche aumentare gli investimenti in infrastrutture immateriali e materiali, come quelle di trasporto e le Tlc, nonché la ricerca e l’innovazione. Oggi investiamo a livello Ue solo il 2% del Pil in R&I. Si tratta di un dato che dimostra come ci sia ancora poca consapevolezza del ruolo di pilastro strategico dell’innovazione all’interno della politica economica e industriale europea e nazionale. Di contro dobbiamo capitalizzare gli sforzi compiuti finora per rilanciare l’industria e il manifatturiero. Il percorso è stato già tracciato e si è ulteriormente consolidato durante il semestre di presidenza italiana del Consiglio Ue.
L’obiettivo dovrebbe essere quello di arrivare a una vera governance industriale che assicuri il mainstreaming, ossia contemperamento degli interessi dell’industria all’interno delle diverse politiche settoriali, in modo tale da poter sostenere il rilancio dell’economia e raggiungere l’obiettivo del 20% di contributo del manifatturiero al Pil Ue entro il 2020.
Ci sono numerosi fronti aperti, ne cito solo alcuni. Il completamento del mercato unico è fondamentale: bisogna rimuovere gli ostacoli, soprattutto di natura normativa o amministrativa, che frenano la libera circolazione di beni, servizi, persone e capitali. La semplificazione a livello europeo è una priorità e lo testimonia la scelta dello stesso presidente Juncker di affidare la “better regulation” al primo vicepresidente della Commissione Timmermans.
È importante, inoltre, che le politiche energetiche, climatiche e ambientali tengano conto dei bisogni delle imprese, evitando il più possibile iniziative unilaterali, penalizzanti per l’industria così come accaduto in passato.
E ancora, va valorizzato il ruolo della politica commerciale e della concorrenza, quali elementi di politica industriale.
Prioritario, infine, sarà il lavoro della Ue a sostegno delle pmi, vero motore dell’industria europea, ad esempio attraverso la revisione dello Small Business Act e l’adozione di misure per migliorare l’accesso al credito.
Il piano di Juncker di stanziare 300 miliardi di euro in 3 anni crede sia sufficiente per far rilanciare la crescita del vecchio continente?
 Per quanto mi riguarda, il piano Juncker è un primo e importante passo per ricominciare a crescere, agendo sul fronte della domanda. Il rischio è che potendo contare su una cifra attorno ai 20 miliardi di euro di risorse pubbliche non si raggiunga l’obiettivo di mobilitare complessivamente 300 miliardi di euro, affidando ai privati il compito di giocare il ruolo più importante. Il piano dovrebbe essere una vera terapia shock. Bisogna sempre ricordarsi che dal 2000 al 2013 il volume di investimenti in Italia è sceso dell’11%, con ricadute impressionanti per settori volano come quello delle costruzioni. In questi anni si è sempre più > marginalizzato il contributo della domanda al rilancio della crescita e soprattutto della domanda pubblica. È invece qui che dovremmo concentrare gran parte degli sforzi.
Per quanto mi riguarda, il piano Juncker è un primo e importante passo per ricominciare a crescere, agendo sul fronte della domanda. Il rischio è che potendo contare su una cifra attorno ai 20 miliardi di euro di risorse pubbliche non si raggiunga l’obiettivo di mobilitare complessivamente 300 miliardi di euro, affidando ai privati il compito di giocare il ruolo più importante. Il piano dovrebbe essere una vera terapia shock. Bisogna sempre ricordarsi che dal 2000 al 2013 il volume di investimenti in Italia è sceso dell’11%, con ricadute impressionanti per settori volano come quello delle costruzioni. In questi anni si è sempre più > marginalizzato il contributo della domanda al rilancio della crescita e soprattutto della domanda pubblica. È invece qui che dovremmo concentrare gran parte degli sforzi.
Sia chiaro, non si tratta di una dichiarazione di disimpegno di imprenditori e investitori privati. Dobbiamo però essere consapevoli che alcuni investimenti non possono essere colmati senza un attivo ruolo del settore pubblico e della Ue, cui è affidato il compito di indirizzo, programmazione e attuazione delle priorità strategiche.
L’obiettivo degli Stati Uniti d’Europa è perseguibile?
Ritengo di sì, ma dobbiamo fare i conti con un sempre più crescente euroscetticismo che rischia di allontanare le istituzioni europee e l’Europa dagli stessi cittadini.
Le ultime elezioni europee hanno dato un primo assaggio di quello che potrebbe accadere se la Ue non sarà in grado di dare risposte soddisfacenti alla crisi. La distanza tra istituzioni e cittadini in questi ultimi anni è frutto di un’assenza di pragmatismo, della sensazione che l’Europa fosse solo sinonimo di austerità e rigore. I cittadini cominciano a pensare all’Europa come qualcosa al di là dei propri interessi, una sorta di entità terza, tecnocratica, sempre più vicina alle sole cancellerie, ma ben lontana dai bisogni di benessere, di democrazia e di equità sociale delle persone.
È un errore che stiamo pagando a carissimo prezzo. Per questo occorre rafforzare la rappresentatività, la legittimità e l’autorevolezza delle istituzioni europee, anche con nuove forme di intervento diretto dei cittadini.
Se vogliamo che gli Stati Uniti d’Europa siano una realtà dobbiamo partire da qui. Lavorando su fronti diversi ma strettamente collegati.
La politica economica deve trovare come contraltare l’impegno a rafforzare la governance politica della Ue. Sono consapevole che si tratti di un traguardo difficile, soprattutto quando la crisi contribuisce a far emergere le differenze tra le diverse nazionalità, minando i passi compiuti fino ad oggi per costruire, sulle ceneri di secoli di conflitti, un’identità europea. Il nostro dovere di imprenditori è quello di contribuire a non lasciar prevalere le spinte nazionaliste e impegnarci affinché l’Europa sia sempre più sinonimo di condivisione, di collaborazione e integrazione.
In cosa consiste nello specifico la questione dell’etichettatura made in?
 Nell’apporre obbligatoriamente l’indicazione dell’origine doganale, così come è disciplinata dalle norme vigenti europee, sui prodotti destinati al consumo commercializzati in Europa, ad eccezione di quelli alimentari, sia prodotti in Europa che importati. Tale è la proposta contenuta nella bozza di Regolamento Ue sulla sicurezza generale dei prodotti attualmente in discussione al Consiglio, approvata in prima lettura a larghissima maggioranza dal Parlamento europeo nell’aprile scorso e in stallo per l’opposizione, in primis, della Germania.
Nell’apporre obbligatoriamente l’indicazione dell’origine doganale, così come è disciplinata dalle norme vigenti europee, sui prodotti destinati al consumo commercializzati in Europa, ad eccezione di quelli alimentari, sia prodotti in Europa che importati. Tale è la proposta contenuta nella bozza di Regolamento Ue sulla sicurezza generale dei prodotti attualmente in discussione al Consiglio, approvata in prima lettura a larghissima maggioranza dal Parlamento europeo nell’aprile scorso e in stallo per l’opposizione, in primis, della Germania.
Quali sono i principali rischi nel mancare questo importante obiettivo?
A livello nazionale perdiamo una battaglia nella quale abbiamo investito energie, risorse ed autorevolezza come sistema paese. L’obiettivo è condiviso e sostenuto da tutti: industria, artigianato, sindacati, commercio, consumatori e l’intero arco delle forze politiche. In sintesi è quel che si definisce un interesse strategico nazionale.
Sul piano della politica industriale europea, rischiamo che prevalga la linea liberoscambista dei paesi del Nord a scapito di quelli che invece hanno a cuore lo sviluppo dell’industria manifatturiera. Infine, ma si fa per dire, che le nostre produzioni, soprattutto di beni di largo consumo, rinuncino a una consistente parte della propria competitività che verrebbe invece salvaguardata rendendo obbligatorio il made in, come accade in tutti i principali mercati esteri.
E quali i vantaggi, per il manifatturiero italiano ma anche per i consumatori, dell’obbligatorietà di questo regolamento?
Anzitutto la trasparenza, perché il consumatore deve sapere da dove proviene ciò che acquista, scegliere in maniera consapevole il rapporto qualità-prezzo e dedurre dall’etichetta di origine le informazioni di carattere sociale o ambientale che la sua sensibilità gli suggerisce. In secondo luogo la reciprocità, perché un produttore italiano che deve esportare negli Usa o in altri grandi mercati mondiali deve etichettare l’origine, mentre chiunque commercializza in Europa lo fa solo se lo ritiene opportuno. Vi sono anche evidenti benefici economici. Prenda il caso delle calzature, che ipotizzano un incremento del 10% dell’occupazione e del 20% dei livelli produttivi. Indicazioni analoghe valgono per molti altri settori, quali l’abbigliamento, i mobili per arredo, le ceramiche o la gioielleria. Aiuterebbe la lotta alla contraffazione, perché si falsificano sia i marchi aziendali che l’origine geografica. Con questa norma inoltre si armonizzerebbero a livello Ue i controlli, così che alcuni porti del Nord Europa restituirebbero un po’ di traffico commerciale agli operatori portuali e della logistica italiani, dove i controlli vengono fatti in maniera più stringente. Infine, si avrebbe un effetto positivo in termini di reshoring degli investimenti in Italia perché potersi fregiare del made in Italy è un elemento premiante.
Oltre tutto ciò, si tratta di una battaglia di civiltà, di legalità e di trasparenza del mercato. Cose di non poco conto per chi produce e fa impresa.