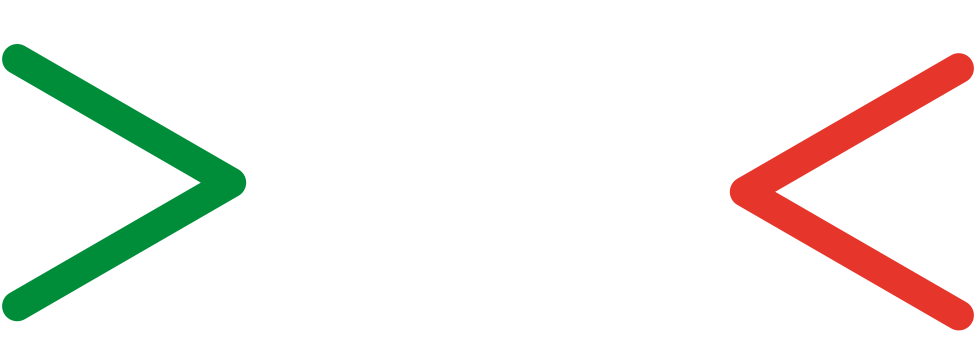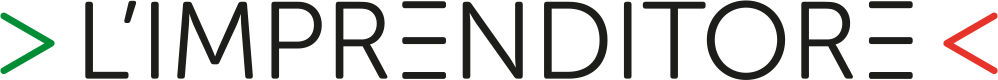ROSY BINDI
Mentre l’Italia inizia a rialzarsi dopo il ventennio fascista, il 10 marzo del 1946, le prime italiane si recano alle urne per il rinnovo di circa 400 consigli comunali. Pochi mesi dopo, tutte saranno chiamate a esprimersi nella scelta cruciale del referendum tra Monarchia e Repubblica.
Il diritto delle donne all’elettorato attivo e passivo segnò la prima vera rottura con la vecchia Italia, prefascista e fascista.
Un traguardo raggiunto molto più tardi rispetto alle altre donne europee e statunitensi ma, come per loro, frutto di lunghe battaglie per la parità. Le italiane erano state l’anello forte che aveva retto il paese prima durante la Grande Guerra e poi nel secondo conflitto mondiale. Molte si erano opposte alla dittatura che, tra l’altro, aveva interrotto il processo per il voto alle donne, e poi partecipato attivamente alla lotta di liberazione.
Perplessità, timori, persino ironie accompagnarono l’attesa di quel 2 giugno. Si disse che le donne non si sarebbero recate alle urne e invece andarono. Si scrisse che avrebbero seguito le indicazioni dei loro mariti e non fu così. Si temeva che le donne meridionali non partecipassero e, al contrario, andarono in massa come nel Centro e nel Nord d’Italia. E gli storici ormai concordano nell’attribuire la vittoria della Repubblica alla massiccia partecipazione femminile.
A distanza di 70 anni, possiamo riconoscere in quel diritto un elemento fondante della nostra democrazia.
Forse non tutte furono pienamente consapevoli dello straordinario valore, anche simbolico, di quella giornata. Ma molte ragazze, lo ricorda Tina Anselmi, che nella Resistenza avevano rischiato la vita per la pace pur non avendo 25 anni (l’età richiesta per votare) si rendevano conto di cosa sarebbe cambiato con quella conquista. Di fatto, la possibilità di esercitare una scelta politica cominciava a modificare anche l’immagine che avevano di se stesse e a rafforzare la loro autonomia. E offriva uno spazio di libertà in cui mettersi in gioco.
All’Assemblea Costituente furono elette solo 21 donne su 556 parlamentari. Una piccola pattuglia, molto determinata e competente, che riuscì a influire su passaggi qualificanti della Carta. Fu la più giovane deputata di tutta l’Assemblea, Teresa Mattei, a proporre, con un suo emendamento, le due parole “di fatto” che danno sostanza all’art. 3 della Costituzione. Quelle due parole, infatti, legano l’affermazione dei diritti con l’impegno della Repubblica a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
Da allora la presenza femminile nella politica e nelle istituzioni è cresciuta, anche se con grande lentezza e con un andamento tutt’altro che lineare.
Solo nel ‘63 Marisa Rodano ricoprì per prima la carica di vicepresidente della Camera e nelle elezioni politiche del ’68 furono appena 27 le parlamentari elette. Dobbiamo attendere il ’76 per vedere la prima donna in un governo. Sarà Tina Anselmi ministro del Lavoro e della previdenza sociale e poi della Sanità, madrina di una riforma storica che introdusse il Servizio Sanitario Nazionale. Tre anni dopo, nel ’79, Nilde Iotti (che pure era stata tra le costituenti) viene eletta alla carica di Presidente della Camera.
 Ma a differenza di altre democrazie nel mondo, in questi 70 anni non abbiamo avuto né un Presidente del Consiglio né un Presidente della Repubblica donna, così come nessuno dei grandi partiti che hanno occupato la scena del secolo scorso né quelli più recenti ha scelto e accettato leadership femminili.
Ma a differenza di altre democrazie nel mondo, in questi 70 anni non abbiamo avuto né un Presidente del Consiglio né un Presidente della Repubblica donna, così come nessuno dei grandi partiti che hanno occupato la scena del secolo scorso né quelli più recenti ha scelto e accettato leadership femminili.
È uno smacco grave, che racconta le contraddizioni e l’incompiutezza della nostra democrazia, le resistenze di un sistema politico e istituzionale che fa fatica a riconoscere nei fatti – per riprendere il dettato costituzionale – il contributo delle donne. Eppure il protagonismo femminile ha reso più ricco e fecondo l’orizzonte civile del paese e ha cambiato in meglio la nostra società.
Penso alle battaglie per il nuovo diritto di famiglia, la parità salariale e i congedi per maternità, al referendum sul divorzio e a quello sulla 194, alle leggi sulla conciliazione dei tempi di vita e lavoro e contro la violenza sulle donne, per il riequilibrio della rappresentanza in politica e nei consigli di amministrazione delle aziende. Tutte norme che hanno accompagnato la crescita economica e sociale, rimuovendo le più plateali discriminazioni di genere e promuovendo nuovi modi di convivere, più rispettosi dell’autonomia e della libertà delle donne.
Ma le leggi non bastano a cambiare mentalità, stereotipi, rapporti di forza antichi e consolidati. Nonostante le azioni positive e le “quote rosa” non si riesce a far saltare il “soffitto di cristallo”, che impedisce a tante donne di raggiungere le stesse posizioni degli uomini.
La lunga crisi economica ha avuto un peso decisivo. Non a caso registriamo una grave battuta d’arresto nei diritti delle donne, le più penalizzate dalle nuove diseguaglianze. Sono più laureate e meno occupate, più sole nella cura dei figli e degli anziani, più esposte a nuove forme di intolleranza e sessismo.

Non sono mai stata femminista ma devo riconoscere che la frantumazione del movimento rende oggi più difficile quella trasversalità femminile che aveva dato voce e forza alla politica delle donne. Chi è impegnata nella sfera pubblica o riveste responsabilità decisionali, nel mondo del lavoro o nelle istituzioni, si scontra ogni giorno con un modello di organizzazione della società e delle forme del potere sostanzialmente maschile che ancora non riconosce la differenza di genere.
E dobbiamo ammettere che molti degli spazi conquistati sono stati pagati a prezzo di una forte omologazione e della rinuncia alla nostra specificità, che è stata ed è un grande motore del cambiamento.
Certo ci sono le eccezioni, donne che si sono fatte avanti senza chiedere il permesso a qualcuno, autorevoli e credibili, capaci di sostenere i conflitti e tenere testa agli uomini. Esempi importanti che si moltiplicano, soprattutto nelle professioni, ma che ancora non sono sufficienti a creare quella massa critica indispensabile a mettere davvero in equilibrio la società.
Questo vale in particolare per la politica che appare ancora arroccata e più indietro. Non è detto che le donne facciano meglio degli uomini. Ma una società di uomini e donne non può essere governata da soli uomini o da tanti uomini e poche donne, spesso cooptate dal capo di turno. Del resto, le liste bloccate previste anche dalla nuova legge elettorale sono un altro segnale di come si possa neutralizzare il meccanismo positivo della doppia preferenza, con una nuova subalternità verso chi nei partiti ha il potere di nominare le donne.
Senza negare lo straordinario cammino percorso, dovremmo prendere atto con realismo e laicità dello stallo in cui ci troviamo.
Dobbiamo costruire una rappresentanza quanto più possibile paritaria, se vogliamo una società migliore e più giusta per tutti. E spetta alle donne farsi carico della crisi di partecipazione e sfiducia nelle istituzioni e nella politica. Non si tratta di riproporre una sterile e anacronistica contrapposizione tra i sessi. Ma sono convinta che forti dell’autonomia personale conquistata in questi 70 anni, le donne italiane debbano riannodare le fila di un sentire e di un pensiero comune, di una solidarietà trasversale che le renda protagoniste del cambiamento e del futuro.