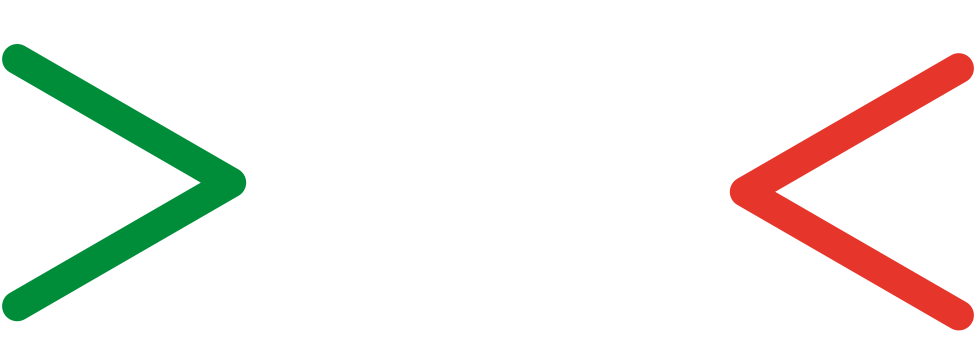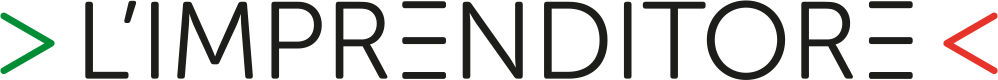In media i cittadini europei traggono importanti benefici economici dall’Unione europea e questo vale anche per il cittadino medio di ogni singolo stato membro. Oggi, la risposta coordinata alla pandemia sembra aver alimentato un rinnovato consenso per le istituzioni della Ue. Nonostante questo, la popolarità del progetto di integrazione continentale ha vissuto momenti migliori degli attuali. Da che cosa nasce la crescente antipatia per l’Unione che accomuna molti paesi membri?

GIANMARCO OTTAVIANO
La risposta si potrebbe trovare nella diffusa percezione di disuguaglianza. Il libero scambio promosso dall’Ue ha sì generato prosperità e potenzialmente lo ha fatto per tutti, ma nei fatti non tutti sentono di averne goduto. A questo si aggiunge il fatto che per molti cittadini è difficile riuscire a distinguere tra gli effetti specifici dell’integrazione economica europea e quelli generali della globalizzazione. Per esempio, la difficoltà di far fronte alle conseguenze della globalizzazione per l’economia locale è un fattore importante per spiegare la relativa popolarità del voto Leave nel referendum britannico sull’uscita dall’Unione europea.
In questa prospettiva, il modo più semplice per misurare l’esposizione di un’economia locale alla forza d’urto della globalizzazione, è quello di confrontare la crescita delle importazioni dalla Cina nei vari settori produttivi a livello nazionale con l’importanza che tali settori hanno per l’economia locale in questione. Se in un dato periodo le importazioni dalla Cina sono aumentate molto nei settori in cui l’economia locale era inizialmente specializzata, si può concludere che l’esposizione alla globalizzazione di tale economia è a sua volta fortemente cresciuta. L’economia locale ha cioè contratto una forte “sindrome cinese”.
La sindrome cinese può aiutarci a capire l’apparente paradosso della crescente avversione all’Unione europea da parte di cittadini che in media ne sono ampiamente beneficiati. In particolare, permette di spiegare la crescita elettorale dei partiti nazionalisti in molte regioni europee.
L’ascesa delle importazioni manifatturiere dalla Cina in Europa è vertiginosa, soprattutto dal 1988 al 2007, periodo che racchiude quello della creazione del mercato unico e successivamente della moneta unica. In quel ventennio la quota cinese nelle importazioni dell’Europa Occidentale passa dall’1% al 7%, nonostante il fatto che le importazioni europee a loro volta quasi raddoppino.
Questa ascesa porta nei mercati del Vecchio Continente nuove merci a prezzi inferiori, alleggerendo la spesa delle famiglie nel caso dell’importazione di beni finali e quella delle imprese nel caso dell’importazione di beni intermedi necessari alla produzione. Comporta, però, anche un parallelo aumento della competizione per le imprese specializzate nella produzione di beni in concorrenza con quelli cinesi e per le regioni in cui questo tipo di imprese sono particolarmente concentrate. In queste zone le aziende meno efficienti chiudono, le opportunità di lavoro si riducono e i salari calano.
Nella misura in cui è complicato, soprattutto per i lavoratori meno giovani o meno qualificati, trovare altre opportunità di lavoro o rinunciare ad una parte del proprio salario pur di lavorare, è di scarsa consolazione per l’economia locale sapere che le imprese più efficienti (ma anche più esigenti in termini di caratteristiche delle persone da assumere) creano nuovi posti di lavoro o che magari altrove, in regioni specializzate in altri settori, le cose vanno meglio di prima.
Il principio generale è molto semplice. Quando un’impresa va in crisi, tra i suoi lavoratori c’è chi trova facilmente occasioni lavorative in altre imprese e chi no. Quando è un’intera economia locale ad andare in crisi, qualcuno potrà e vorrà andare altrove per trovare lavoro. Molti però non potranno o vorranno andarsene, perchè per loro il gioco non vale la candela. Vedranno quindi la loro qualità di vita deteriorarsi. Questo ha importanti implicazioni politiche, indipendentemente da qualunque considerazione di merito sul perchè quei lavoratori non trovino occupazione localmente o non vogliano cercarla altrove.
All’inizio del progetto europeo i più pensavano che la convergenza nei livelli di benessere tra regioni più o meno dinamiche sarebbe stata una naturale conseguenza del processo di integrazione economica: imprese e persone si sarebbero ridistribuite tra le regioni fino ad eliminare ogni incentivo a farlo, cioè fino a quando le differenze regionali di profitti e salari fossero scomparse. Purtroppo, però, lo sviluppo economico passa spesso attraverso la concentrazione geografica delle attività economiche e quindi attraverso una divisione delle regioni in più o meno dinamiche.
Questo è quello che avviene anche in Europa. La sfida è quella di far sì che il successo delle regioni più dinamiche si diffonda anche a quelle meno attive. Se questo succede, lo sviluppo economico diventa inclusivo e riesce a godere di un maggiore consenso popolare.
Sintesi dell’articolo pubblicato su RPE – Dicembre 2020. Per scaricare il capitolo integrale cliccare qui
Per acquistare il volume https://www.limprenditore.com/rivista-di-politica-economica