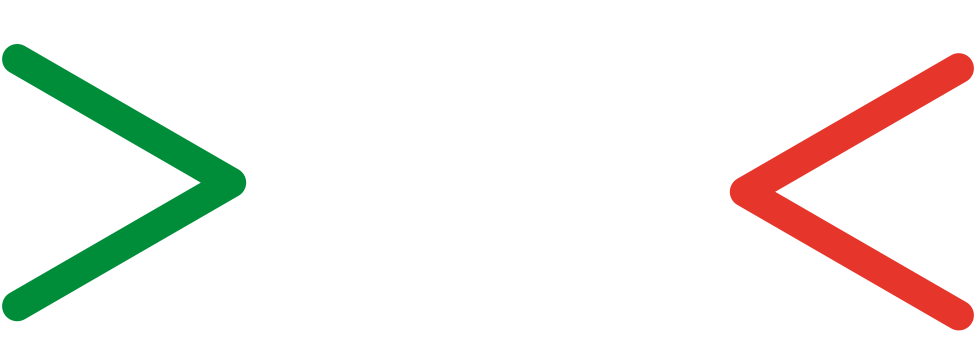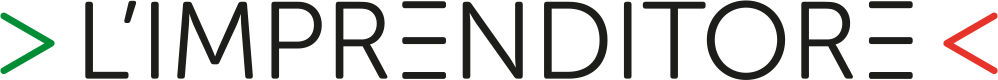Crediamo di sapere tutto sulle lobbies e riteniamo che sia loro la responsabilità dell’immobilismo in cui versa il nostro paese.
D’altronde basta aprire un quotidiano qualsiasi per leggere la parola “lobby” e capire che è colpa delle lobby se il Paese non fa le riforme che dovrebbe fare. Ma è proprio così? E cosa sono queste “lobby”? La parola lobby ha una storia antica.
Nella lingua inglese essa indica ancora la grande sala presente negli alberghi dove generalmente si incontrano gli ospiti dell’hotel e gli invitati esterni.

PIER LUIGI PETRILLO
Le prime tracce del termine si ritrovano in alcuni testi anglosassoni del 1553: derivato dal latino laubia (propriamente loggia, vestibolo), il termine era usato in ambienti monastici per indicare un luogo coperto in cui si cammina. Qualche anno dopo, nel 1575, la parola indicava il corridoio collocato davanti ad una stanza in funzione di sala d’attesa o vestibolo. Nel linguaggio nautico, nello stesso periodo, lobby era l’appartamento o il corridoio situato nella parte anteriore della nave sotto il cassero.
E nella seconda metà del ’700 con lobby si indicava, nella terminologia agricola, una piccola recinzione per il bestiame, adiacente all’aia. Nell’ambiente politico la parola lobby entra nel 1640 ed è usata per indicare la grande stanza d’ingresso della House of Commons di Londra, aperta al pubblico, dove conversavano parlamentari, giornalisti e, appunto, “lobbisti”, ovvero portatori di interessi particolari.
È negli Stati Uniti d’America che, dal 1832, la parola lobby viene utilizzata anche come verbo per indicare l’attività di persuasione messa in pratica nel Campidoglio di New York, in Albany, dai lobby agents verso i politici locali . “Fare lobbying” (in inglese “to lobby”) significa, quindi, essenzialmente, portare a conoscenza dei decisori pubblici (non solo politici) informazioni rilevanti su interessi particolari, al fine di influenzarne le scelte.
Chi esercita tale attività è, quindi, innanzitutto un esperto, uno specialista; deve saper “trasmettere” un messaggio preciso (come richiesto dal soggetto o dai soggetti di cui “porta” l’interesse); e deve saper convincere il proprio interlocutore sulla validità dell’opzione rappresentata .
Il lobbista non è, quindi, un corruttore; non fa pubblicità, né propaganda; il suo obiettivo è, all’opposto, fare in modo che l’interlocutore acquisisca le informazioni corrette (chiare e veritiere) per effettuare scelte libere e consapevoli; ovviamente, però, trattandosi di un portatore di interessi particolari, egli evidenzierà gli aspetti che maggiormente lo riguardano, spettando al decisore pubblico il compito di sintetizzare i diversi interessi particolari per definire una scelta a effetto generale e vincolante.
In quest’ottica il lobbying non è solo “marketing istituzionale”, come pure teorizzato dalla dottrina americana: così, per Jerome Mc Carthy, alle “4P” pilastri del marketing aziendale – product, price, place, promotion – vanno aggiunte altre “3P” pilastri del marketing istituzionale: people, power, pubblic relation. Si assume, in tal modo, una visione positiva dell’attività lobbistica, in quanto funzionale all’elaborazione di una decisione a basso grado di conflittualità, assunta dopo averne valutato l’impatto sui destinatari. In questo senso taluni parlano di “funzione pubblica” dei gruppi di pressione, in quanto “facilitatori” del processo decisionale .
Il fenomeno ha certamente aspetti patologici, anche molto gravi, e, spesso, nella percezione collettiva, specialmente in Italia, è legato alla commissione di illeciti penali, come se fossero due facce di una stessa medaglia.
Tale percezione è evidente nei dizionari di lingua italiana dove “gruppi di interessi” e “gruppi di pressione” sono definiti come “gruppi di potere in campo economico e politico” che, attraverso indicazioni occulte e sollecitazioni insistenti, tentano di influenzare la decisione generale. Si tratta, però, di gravi patologie, che derivano proprio dall’assenza di regole organiche e condivise.
In realtà, infatti, nelle democrazie più avanzate, dagli Stati Uniti d’America al Canada, da Israele all’Australia, dalla Germania alla Gran Bretagna, il lobbying è regolato da specifiche norme (perfino di rilievo costituzionale) che impongono, ad esempio, ai lobbisti di registrarsi in un elenco pubblico consultabile online, e ai decisori pubblici di rendere trasparenti gli incontri avuti con i lobbisti finanche indicando la durata temporale degli stessi.
In Italia la situazione è molto diversa. Nel nostro Paese, infatti, manca una regolamentazione organica di tale fenomeno e i rapporti tra decisori pubblici e lobbisti è avvolto da un velo impenetrabile.
L’effetto è che è sempre colpa delle lobby se non si fanno le liberalizzazioni; colpa delle lobby se il paese ristagna in paludi ottocentesche; sono le lobby a impedire le c.d. riforme strutturali. L’assenza di norme che rendano trasparente l’attività dei lobbisti consente alla politica di usare le lobby come paravento dietro al quale nascondere la propria indecisione, o la volontà di assecondare interessi poco condivisi. Per mantenere in vita il paravento, dietro cui la politica si nasconde, non viene approvata alcuna regolamentazione del lobbying. >
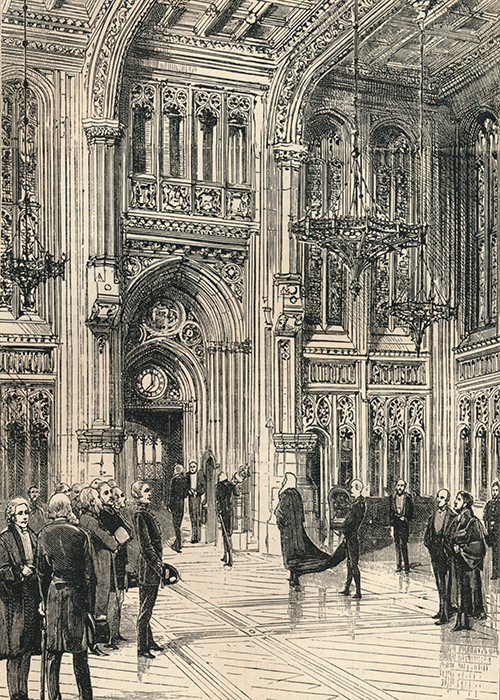
Nel contesto politico italiano, non possono essere approvate norme che rendano trasparente l’azione dei lobbisti perché altrimenti cadrebbero gli altarini e si scoprirebbe ciò che tutti sanno: ovvero che laddove la politica è fragile e mancano indicazioni chiari, i parlamentari si sentono liberi di assecondare le lobby a loro più vicine (magari perché ne finanziano la campagna elettorale) perché sanno che, nell’oscurità che circonda il mondo delle lobby, non sarà mai colpa loro, non dovranno mai rendere conto delle loro scelte a nessun elettore (gli inglesi direbbero accountability). L’assenza di una legge sulle lobby impedisce all’elettore di comprendere cosa c’è davvero dietro l’emendamento presentato dal singolo deputato, quale interesse e chi l’ha redatto; impedisce di sapere chi paga e per cosa.
Recentemente qualche segnale di cambiamento è venuto dalla decisione della Giunta per il regolamento della Camera dei Deputati di approvare il c.d. “Codice Pisicchio” ovvero una serie di principi finalizzati a regolare le modalità di relazione tra lobbisti e deputati. Nello specifico, il Codice prevede che chiunque voglia professionalmente esercitare l’attività di lobbying presso le sedi della Camera dei Deputati debba iscriversi in un registro pubblico e che, agli iscritti, l’ufficio di Presidenza della Camera rilasci un tesserino permanente. Se tali disposizioni verranno applicate sarà senz’altro un passo in avanti verso la trasparenza dei rapporti ma chi scrive teme che non troveranno mai applicazione anche per la loro difficile collocazione nel sistema delle fonti normative (ammesso che siano norme e che abbiano una qualche forza giuridica).
Tale situazione potrebbe, però, essere modificata facilmente: basterebbe un decreto del Presidente del Consiglio, in attesa che il Parlamento approvi una legge in materia, per introdurre l’obbligo per tutti i Ministri, ad esempio, di rendere pubblici gli incontri avuti con i lobbisti (cosa che ha deciso di fare, dal 1 gennaio 2015, un solo membro del governo Renzi ovvero il Vice Ministro alle infrastutture, Nencini). Se solo il governo volesse, dunque, il processo decisionale potrebbe diventare un po’ meno oscuro e la politica sarebbe costretta ad assumersi la responsabilità, alla luce del sole, di determinate scelte. Ma a questo punto nessuno più potrebbe nascondersi dietro al paravento delle lobby; cosa che, purtroppo, conviene a molti.