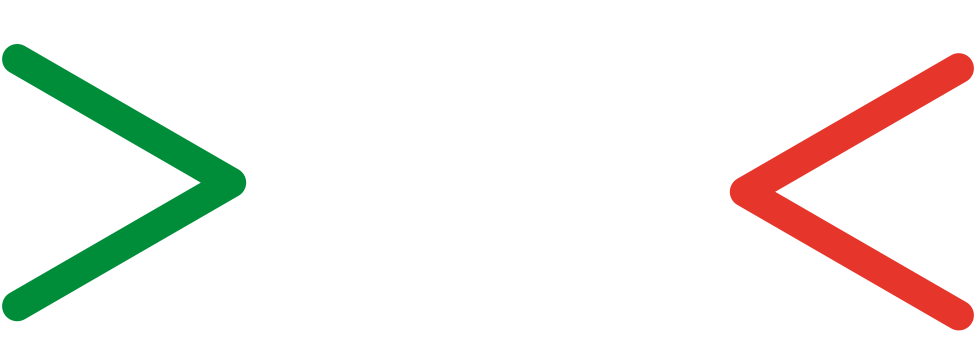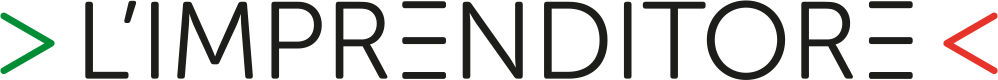ELENA CORRADI
Anno 2020: Stati Uniti e Cina hanno raggiunto il punto più basso delle loro relazioni negli ultimi 40 anni, mentre a Washington democratici e repubblicani attendono con grande fervore un’elezione dalla quale, secondo entrambi, dipende la sopravvivenza dell’America stessa.
Una coincidenza incendiaria che lascia presagire un impatto significativo sugli assetti geopolitici mondiali. Come evolveranno le relazioni Usa-Cina se l’inquilino della Casa Bianca dovesse rimanere Donald Trump? Come potrebbe invece cambiare la situazione con una presidenza Biden? E cosa, a dispetto delle apparenze, accomuna i due sfidanti nell’approccio verso Pechino?
USA, CINA E QUATTRO ANNI DI TRUMP: DOVE SIAMO OGGI?
Durante la sua presidenza, Trump ha bollato la Cina come l’antagonista per eccellenza, schierandosi in uno scontro frontale su temi come la guerra dei dazi, il decoupling, la supremazia tecnologica, i diritti umani e ora la pandemia. Ma attenzione: che la politica estera americana ruoti attorno alla Cina non è una novità portata alla ribalta dall’attuale presidente. Alla fine del loro primo mandato, Barack Obama e il suo vicepresidente Joe Biden avevano inaugurato una stagione di progressiva diminuzione dell’impegno americano in Europa e Medio Oriente (la cosiddetta politica del Pivot to Asia teorizzata dalla Segretario di Stato Hillary Clinton), per potersi così concentrare sull’area del Pacifico e fare i conti con una Cina emergente e sempre più assertiva. Con l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca, però, il presidente ha spinto il piede sull’acceleratore in un modo difficile da immaginare solo quattro anni fa. Fin da subito, già nel novembre 2016, Trump ha giocato la carta dello scontro con Pechino in campagna elettorale. Una scommessa vincente, dato che molti dei suoi elettori nei tre swing states che gli consegnarono la vittoria – Michigan, Wisconsin e Pennsylvania – vivevano in aree molto esposte alla competizione cinese: a motivare il loro voto per l’outsider repubblicano erano proprio le fabbriche chiuse e i posti di lavoro persi per le delocalizzazioni in Cina.
Nei suoi quattro anni di presidenza, Trump ha continuato a puntare il dito contro il forte deficit commerciale di Washington verso Pechino, che nel 2018 aveva superato i 400 miliardi di dollari, tentando di riequilibrare la situazione a colpi di dazi e quote sulle importazioni dalla Cina. La guerra commerciale ha presto mostrato le sue conseguenze: nel 2019, la Cina ha perso la posizione di primo partner commerciale degli Usa a favore di Canada e Messico; gli investimenti diretti cinesi negli Usa sono diminuiti nettamente, fino a toccare il loro punto più basso degli ultimi dieci anni (solo cinque miliardi di dollari nel 2019 secondo i dati del Rhodium Group); l’industria manifatturiera statunitense ha continuato a spostare le proprie catene del valore dalla Cina verso altri paesi come Vietnam e Messico.
Oggi, in molti parlano di una “nuova Guerra Fredda” tra Stati Uniti e Cina. Anche il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha fatto suonare il campanello d’allarme alla 75esima Assemblea Generale dell’Onu a fine settembre, chiedendo ai leader mondiali di lavorare per evitare che tale scenario si concretizzi. A differenza di Stati Uniti e Unione Sovietica 30 anni fa, oggi Washington e Pechino sono però due economie fortemente interdipendenti. Oltre che importanti partner commerciali, la Cina è infatti il secondo detentore di debito pubblico Usa dopo il Giappone e molte aziende statunitensi sono ormai una presenza stabile in Cina, dove sono sbarcate negli ultimi decenni in cerca di manodopera a basso costo. Ecco allora i trend che motivano un’altra delle politiche portate avanti dall’amministrazione Trump verso la Cina: il decoupling, ovvero il processo di “disaccoppiamento” delle catene del valore che legano l’economia degli Usa a quella cinese, a favore di un riposizionamento verso altri paesi asiatici “amici” di Washington (ad esempio l’India, il Vietnam, la Corea del Sud) o un ritorno in patria (reshoring).
Un altro terreno di scontro aperto tra le due superpotenze in questi ultimi anni è stato quello della tecnologia. A catalizzare l’attenzione mondiale è stato per primo il caso Huawei, l’azienda cinese che Trump ha cercato di bloccare dall’assicurarsi contratti di fornitura delle reti 5G in giro per il mondo; compreso in paesi alleati di Washington, i quali la Casa Bianca ha però messo in guardia sulla vulnerabilità delle infrastrutture di Huawei allo spionaggio cinese. Un rischio, sostiene la Casa Bianca, che potrebbe compromettere la cooperazione tra Washington e gli alleati su dossier chiave quali intelligence e difesa.
Negli ultimi mesi, la nuova battaglia tecnologica è stata quella sull’accesso della app TikTok al mercato americano. Anch’essa accusata di prestarsi alla sorveglianza dei servizi di sicurezza cinesi, TikTok è stata bersaglio di un ordine esecutivo con cui Trump ha proibito alle aziende americane di fare affari con il social media. Dopo le minacce del presidente, si era arrivati a un accordo per cui il 20% delle azioni dell’app sarebbero dovute passare in mano americana, ma Trump non sembra ancora soddisfatto. Al di là dell’esito della vicenda e delle ragioni (o meno) del presidente, il caso è un altro esempio di come la Casa Bianca di Trump guardi alla Cina e ai suoi giganti economici con occhio sospettoso, quando non apertamente ostile.
DOPO NOVEMBRE, QUALI SCENARI?
Se a novembre gli americani dovessero optare per altri quattro anni di Trump possiamo immaginare che, nonostante l’imprevedibilità che contraddistingue il presidente in carica, la linea di Washington verso Pechino continuerà ad essere quella dello scontro aperto. Una linea inasprita anche dal coronavirus e resa ancora più evidente dal recente discorso di Trump all’Assemblea Generale dell’Onu, dove il presidente ha attaccato Pechino senza mezzi termini additando la Cina come responsabile della pandemia che sta colpendo gli Stati Uniti e il mondo: “Dobbiamo ritenere responsabile il paese che ha scatenato questa piaga nel mondo: la Cina”.
Sono lontani i toni di apertura di gennaio, quando l’accordo di “fase uno” verso un possibile futuro trattato commerciale tra Stati Uniti e Cina sembrava lasciar presagire una relativa normalizzazione dei rapporti diplomatici. Oggi, la possibilità che questo avvenga è assai ridimensionata; a prescindere dal fatto che si possa arrivare a una “fase due”, il processo di decoupling delle due economie continuerà, se non addirittura accelererà. La conseguenza più probabile sarà dunque un ridimensionamento degli scambi tra i due paesi e una riduzione della dipendenza degli Stati Uniti dalle forniture cinesi di materie prime, semilavorati e componentistica, specialmente nelle industrie più strategiche.
Da senatore, vicepresidente e ora candidato presidente, Joe Biden ha adattato e in una certa misura mutato il proprio atteggiamento nei confronti della Cina. Se fino a pochi anni fa Biden, come buona parte dell’establishment di politica estera di Washington, nutriva la speranza che l’integrazione della Cina nel sistema globale potesse avvicinarla alle regole del libero mercato e dell’ordine internazionale liberale, l’approccio oggi è ben diverso. Come Trump, anche Biden considera la Cina il principale avversario degli Stati Uniti; una posizione ancor meno conciliante di quella che aveva adottato come vice di Barack Obama. Così, i piani economici presentati dal candidato del Partito democratico, che prevedono più spesa pubblica per prodotti made in Usa e il rilancio di ricerca e sviluppo sulle nuove tecnologie, sembrano mimare la retorica di Trump con titoli come “Build Back Better”, “Buy American” e “Made in America Plan”.
Invece di puntare allo scontro diretto con Pechino, l’ex vicepresidente punta però a ricostruire la leadership – politica, morale ed economica – degli Stati Uniti nel mondo e recuperare i rapporti con gli alleati storici, in primis l’Europa. Pur mantenendo le relazioni con la Cina al centro della sua politica estera, una Casa Bianca a guida Biden lascerebbe probabilmente da parte le guerre commerciali per concentrarsi sulla salvaguardia di quell’ordine globale multilaterale e liberale che proprio Washington e i suoi alleati hanno costruito e salvaguardato dalla fine della Seconda guerra mondiale.
Seppur distinti nei metodi, Biden e Trump sembrano dunque condividere un obiettivo simile nel lungo periodo. Indipendentemente da chi andrà a sedere nello Studio Ovale, il decoupling rimarrebbe un asse portante della politica Usa verso la Cina, sottomettendo le logiche commerciali e di mercato a esigenze di autonomia strategica e sicurezza globale.
A differenza di quanto si potrebbe pensare in un primo momento, quindi, le elezioni del 3 novembre probabilmente non segneranno un radicale cambiamento nella direzione delle relazioni tra Washington e Pechino. D’altra parte, sempre più americani guardano in modo negativo alla Cina, con percentuali che hanno superato il 70% dopo l’inizio della pandemia. Davanti a una relazione che appare destinata a farsi sempre più tesa, il resto del mondo – Europa in testa – teme così di dover essere messo di fronte a una scelta di campo tra Washington e Pechino.
(Articolo tratto dal numero di ottobre de “L’Imprenditore”)