
Il calo demografico non è un tema di attualità, è un problema strutturale. Spiegarne il perché e identificarne possibili soluzioni è compito da addetti ai lavori. Poiché non lo sono, faccio un centinaio di passi indietro e metto sul tavolo qualche provocazione sui rapporti tra andamento demografico e dinamiche imprenditoriali, tra ricambio generazionale e competitività delle imprese.
Trampolino di lancio una tesi di Luigi Einaudi: “Migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli. È la vocazione naturale che li spinge; non soltanto la sete di guadagno. Il gusto, l’orgoglio di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia a clientele sempre più vaste, ampliare gli impianti, costituiscono una molla di progresso altrettanto potente che il guadagno.” (citazione tratta da Dedica all’impresa dei Fratelli Guerrino, ndr).
Era il 1960. Gli scenari del terzo millennio rischiano di configurare una inversione a U: da “migliaia, milioni di individui” a “milioni, migliaia di individui”. Non ce lo possiamo permettere. Urgono azioni di riequilibrio e ce n’è per tutti. In primis per chi continua imperterrito a “molestare, inceppare e scoraggiare” gli imprenditori, predicando competizione e razzolando rendite. Poi per tanti altri attori, protagonisti e comparse dell’ecosistema che circonda le imprese. Non da ultimo, sul palcoscenico si presenta anche la demografia: la popolazione “conta”, non solo perché esprime mercati potenziali (dei consumi, del lavoro, della formazione, del risparmio e così via), ma anche perché influenza il fattore imprenditoriale.
Tre riscontri, che configurano situazioni in cui la variabile demografica ha giocato e sta giocando un ruolo importante ai fini dell’imprenditorialità.
La prima evidenza fa riferimento al contributo che la natalità ha dato allo sviluppo dei distretti industriali. Più di un secolo or sono, discutendo di localizzazioni produttive, Alfred Marshall ne rilevava l’“industrial atmosphere” e i suoi benefici effetti: “I misteri dell’industria non sono più tali, è come se stessero nell’aria e i fanciulli ne apprendono molti inconsapevolmente”. Già, i fanciulli e le fanciulle, proprio loro. Se tanto mi dà tanto, l’analisi dello sviluppo industriale italiano del primo e del secondo dopoguerra, sensibilmente determinato dalle economie di localizzazione, non può prescindere dalla demografia. Per i San Tommaso di turno, ci sono montagne di dati sull’evoluzione della popolazione, delle famiglie, della numerosità media dei membri. Distretto per distretto, censimento su censimento.
Il secondo riscontro riguarda i flussi di imprenditorialità connessi all’immigrazione. Due dati relativi al 2020, giusto per dimensionare il fenomeno, tratti dal Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione della Fondazione Leone Moressa:
- gli imprenditori immigrati (persone fisiche titolari di cariche imprenditoriali) risultano circa 740mila, più del 10% dei quali di origine cinese;
- su un totale di circa cinque milioni di imprese attive in Italia, quasi l’11% è a conduzione straniera. Non si tratta di un fenomeno marginale, soprattutto se lo si considera in prospettiva dinamica e se lo si contestualizza nei settori di attività economica in cui è prevalente (più del 60% delle imprese opera nel commercio e nelle costruzioni).
In buona sostanza, è come se si fosse innescata una dinamica di sostituzione tra imprenditoria italiana e imprenditoria immigrata, in particolare nei settori tradizionali dell’economia.
Il terzo riferimento sposta l’attenzione sulle Pmi e sul capitalismo familiare, asse portante del sistema economico italiano. Molte famiglie imprenditoriali si sono messe in discussione e hanno percorso sentieri virtuosi. Per altre, permangono situazioni di conflitti, di insoddisfazioni, di tensioni relazionali che ne minano la continuità. Si tratta di snodi problematici che tendono ad accentuarsi quando la deriva generazionale avanza e/o i ceppi familiari si moltiplicano.
Tutto ciò premesso, che c’entra la demografia? C’entra, per almeno una buona ragione: la numerosità dei figli e delle figlie conta. La storia di tante imprese familiari è dinastica, ha origini lontane nel tempo, conserva simboli, riproduce nomi propri. Basta mapparne gli alberi genealogici per crederci. Se è vero che un elevato numero di figli non è garanzia di successo della transizione imprenditoriale, è pur vero che mette sul piatto maggiori opzioni per valutare attitudini e competenze, per selezionare l’erede al trono, per mantenere alta la bandiera della famiglia proprietaria. Detto terra terra: con gli scenari che lo attendono, il capitalismo familiare non può più permettersi molte cose. Nemmeno il calo demografico dei propri protagonisti.
Si potrebbe portare altra acqua al mulino dei rapporti tra demografia e fattore imprenditoriale, delineando fenomeni socio-economici come le startup, gli spinoff, l’imprenditoria femminile. Ma la sostanza non cambierebbe di gran che e il filo rosso del “più natalità, più imprenditorialità” ne uscirebbe ulteriormente rafforzato. Con una sottolineatura finale.
Ai fini del fattore imprenditoriale, la popolazione conta non solo perché è funzionale al mestiere di imprenditore, ma anche perché fa cultura, diffonde valori, comunica modelli, elabora benchmark. Abbiamo urgente bisogno di educare al rischio, di stimolare l’intrapresa, di legittimare l’impresa. Più sono quelli che stanno “dalla parte giusta”, meglio è per tutti.
Nota
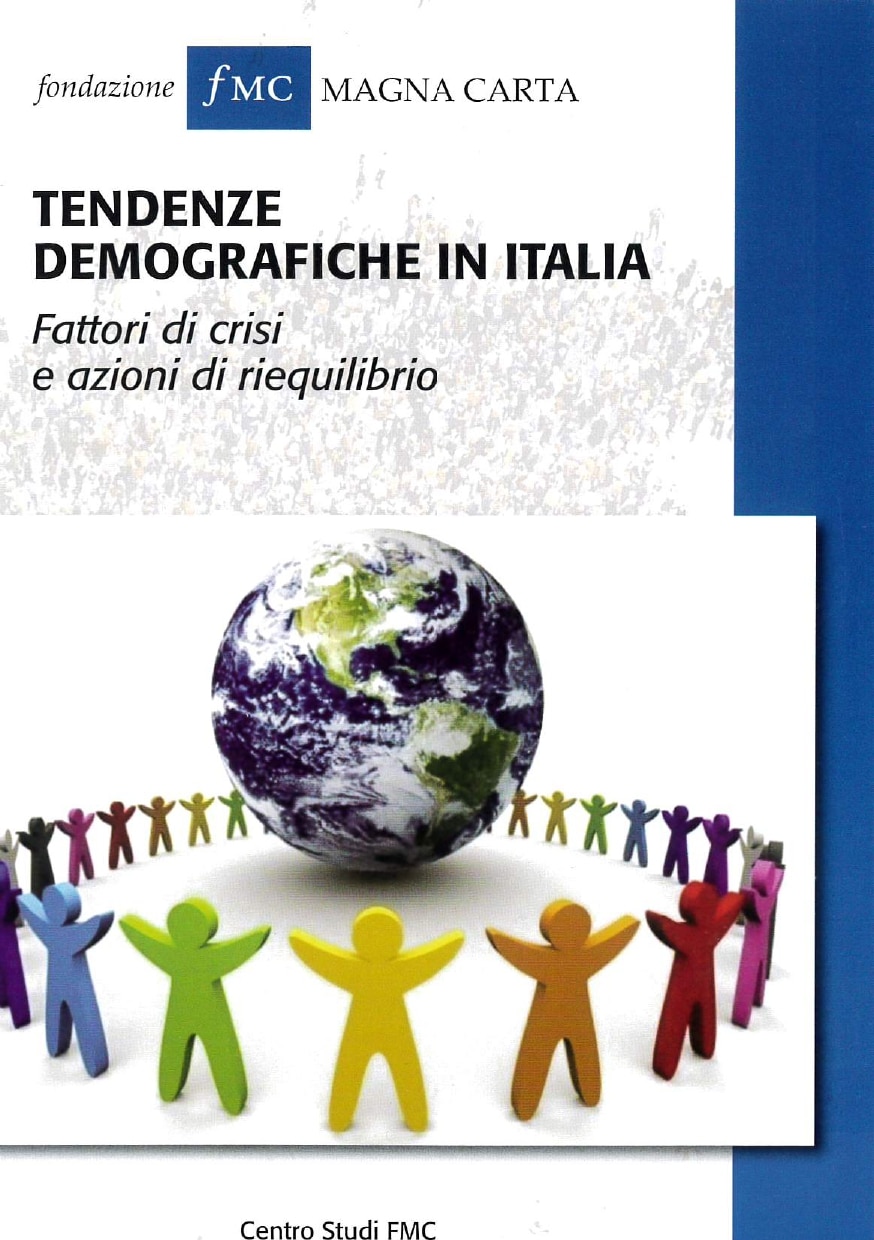 L’articolo è una sintesi del contributo del professor Visconti pubblicato all’interno del volume Tendenze demografiche in Italia. Fattori di crisi e azioni di riequilibrio, edito da Fondazione Magna Carta. Tredici capitoli che affrontano il problema del calo demografico sotto diversi aspetti, dal mercato del lavoro all’impatto sul welfare, dal contributo apportato dall’immigrazione alle conseguenze psicologiche sui legami sociali, dai risvolti sul dinamismo dell’imprenditoria fino alla demografia come variabile geopolitica.
L’articolo è una sintesi del contributo del professor Visconti pubblicato all’interno del volume Tendenze demografiche in Italia. Fattori di crisi e azioni di riequilibrio, edito da Fondazione Magna Carta. Tredici capitoli che affrontano il problema del calo demografico sotto diversi aspetti, dal mercato del lavoro all’impatto sul welfare, dal contributo apportato dall’immigrazione alle conseguenze psicologiche sui legami sociali, dai risvolti sul dinamismo dell’imprenditoria fino alla demografia come variabile geopolitica.

