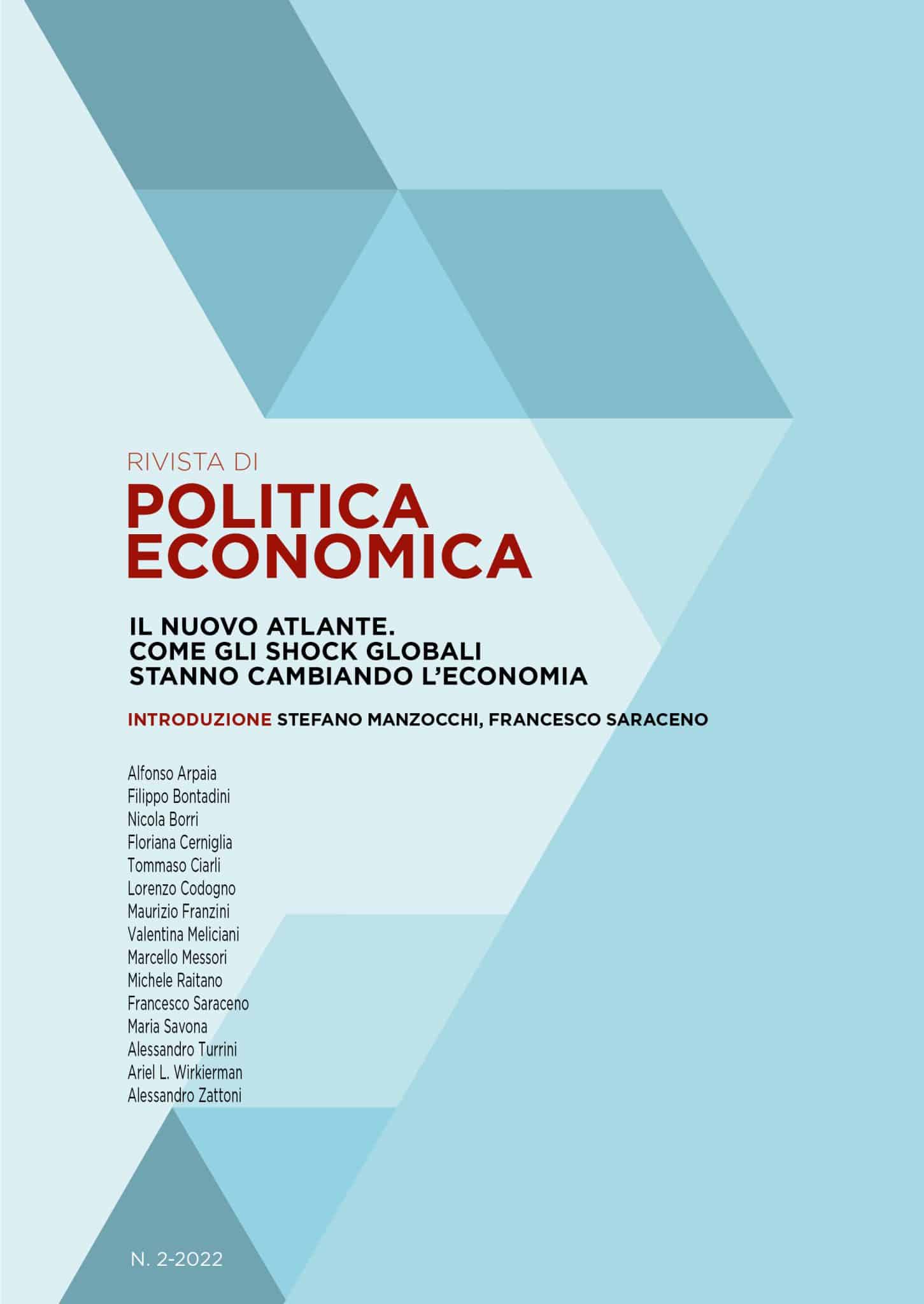Con il secondo numero del 2022 la Rivista di Politica Economica ha tagliato il traguardo dei quattro anni dall’ultima “rinascita”. Negli oltre 110 anni di storia che ormai la contraddistinguono, sono state infatti diverse le azioni di restyling messe in atto, ma la nuova veste che ha assunto a partire dal 2019 è da considerare un vero e proprio ripensamento complessivo della rivista, che oggi è pubblicata in lingua italiana e ospita di volta in volta saggi scientifici su un tema unico, scelto per ciascun numero.
Per Stefano Manzocchi (nella foto in alto), direttore di RPE nonché prorettore per la ricerca all’Università Luiss Guido Carli di Roma, il bilancio di questo nuovo corso è positivo. “La rivista continua a essere letta da economisti, accademici o da chi in azienda si occupa di scenari economici – spiega – ma la nuova impostazione e la scelta della lingua italiana l’hanno aperta maggiormente a tutto il dibattito culturale del Paese. Manager, imprenditori, sindacalisti, e mondo delle professioni in genere, la trovano un utile strumento per approfondire alcuni temi di attualità”.
L’argomento viene scelto di volta in volta in condivisione con il comitato editoriale, un organismo che il direttore di RPE ha contribuito a rinnovare un anno fa, ampliando le tematiche coperte e inserendo più componenti donne e più giovani. “Cerchiamo di individuare i temi che appaiono centrali nel nostro Paese e al tempo stesso rilevanti a livello europeo – spiega –. In alcuni casi, anzi, direi che abbiamo anticipato argomenti che poi sono ‘esplosi’ nel dibattito pubblico. Si pensi alla demografia o alla questione della nuova globalizzazione. Il numero che uscirà a giugno, il primo del 2023, si occuperà di formazione, un tema più che mai attuale”.
Parliamo, invece, di quello attualmente in distribuzione, intitolato “Il nuovo atlante. Come gli shock globali stanno cambiando l’economia”. Si discute di politica di bilancio e torna la dialettica Stato versus mercato, dove sembra prevalere il primo. È così?
“Un filo rosso del volume è senz’altro quello del rapporto fra Stato e mercato, fra Stato e sistema delle imprese, ma non direi che vinca lo Stato. Piuttosto, si evince che gli shock di questi anni – pandemia, guerra in Ucraina, aumento dei costi energetici – hanno costretto il mondo dell’economia nel suo complesso – imprese, lavoratori, associazioni, Pubblica amministrazione – a prendere atto che tali sconvolgimenti richiedono inevitabilmente un maggiore intervento del pubblico. Peraltro, non dimentichiamo che nel decennio precedente avevamo affrontato già una crisi finanziaria e poi economica pesantissima e avevamo corso il rischio di un’implosione dell’Unione europea con la crisi dei debiti sovrani. Quando è arrivato il Covid-19, per fare un esempio, è stato naturale che lo Stato tornasse ad essere più protagonista. Pensiamo alla campagna vaccinale che ha coinvolto la popolazione: soltanto uno Stato attivo ed efficiente può portarla a termine, in sinergia con le imprese”.
Qual è quindi il messaggio complessivo del volume?
“Che si esce vincenti soltanto con l’interazione virtuosa tra Stato, sistema delle imprese e lavoratori. Per anni lo Stato è sparito dall’orizzonte – beninteso non la burocrazia –poi improvvisamente è tornato, andando talvolta anche oltre le intenzioni di chi ha dovuto gestire alcune fasi. E questo è accaduto sia negli Stati Uniti che in Europa, le aree geografiche che prendiamo in esame nella nostra analisi”.
Due dei saggi presenti sulla rivista affrontano da differenti punti di vista il tema del lavoro: l’uno approfondendo l’aspetto della disoccupazione, con un confronto tra la risposta europea e quella americana alla crisi, l’altro occupandosi della disuguaglianza. Come mai si torna a parlare di lavoro? L’esistenza dei cosiddetti working poor suggerisce che qualcosa nella globalizzazione non ha funzionato?
“Diseguaglianza e lavoro sono centrali nel volume e la loro attualità nel dibattito socio-economico è sotto gli occhi di tutti. Perché? Proviamo a dare una risposta. La crisi – o questa lunga sequenza di shock che abbiamo attraversato negli ultimi anni – ha messo in luce i cambiamenti radicali avvenuti nella società, da una parte sul fronte delle competenze, dall’altra su come le imprese evolvono e si interfacciano con il mondo del lavoro, ponendo la domanda su che cosa lo Stato possa fare per accompagnare questo cambiamento.
La transizione ecologica e quella digitale richiedono competenze nuove rispetto a quelle del mondo del lavoro di prima del 2019. Attenzione, non perché prima non esistessero questi driver, ma perché l’accelerazione prodotta dal Green Deal e dalla pandemia hanno richiesto un cambio di passo del sistema lavoro. E questa accelerazione ha prodotto grandi aumenti di ricchezza in alcuni punti del sistema e grandi cadute in altri, cadute che hanno riguardato al tempo stesso imprese, lavoratori e investitori”.
Come si potrebbe intervenire?
“Nel caso specifico della diseguaglianza, gli autori del saggio mettono in luce che la carenza di concorrenza accresce le diseguaglianze. In un sistema che tende a ingessarsi si creano rendite di posizione e questo fa a pugni con gli sconvolgimenti profondi che, in altri punti del sistema, la transizione verde e quella digitale stanno creando. Si discute della apertura dei mercati per alcuni servizi, e naturalmente esiste il tema delle modalità più idonee, ma pensiamo al sistema delle imprese esportatrici: in questi anni ha dovuto rispondere a una concorrenza anche molto feroce, in certi casi”.
Nel nostro Paese sopravvive la cultura della rendita, è un retaggio antico…
“Sì, ma nel caso dell’industria manifatturiera la conservazione dell’esistente è praticamente impossibile. Non ci si può sottrarre alle sfide che vengono dall’esterno ed è per questo motivo che la triade Stato-imprese-lavoratori deve trovare la giusta chiave, avendo la capacità di intervenire anche su alcune condizioni di rendita che peggiorano la disuguaglianza”.
Nel dibattito pubblico si parla molto di de-globalizzazione, mentre nel volume si introduce il concetto di una globalizzazione che decelera. Può spiegarci meglio?
“È un tema che ci accompagnerà per molto tempo perché è legato agli stravolgimenti cui è sottoposta l’economia, che partono a loro volta anche dalle tensioni internazionali. I grandi sistemi continentali – europeo, nordamericano, asiatico – sono molto diversi fra loro ed è probabile che nei prossimi anni aumenterà la dose di regionalismo negli scambi commerciali. Pensiamo anche alla questione energetica, nella quale il Mar Mediterraneo sta diventando sempre più importante per l’Europa.
D’altra parte, sappiamo anche che ci sono alcuni aspetti del sistema economico e sociale – la tecnologia o la finanza – dove la natura degli scambi contempla meno la distanza. Quanto le tensioni internazionali costringeranno a una deglobalizzazione o a una sua rilettura con diverse caratteristiche? Credo che sia troppo presto per dare una risposta e, come studiosi, dobbiamo continuare a osservare e studiare”.
(Per informazioni e acquistare il numero, cliccare qui)