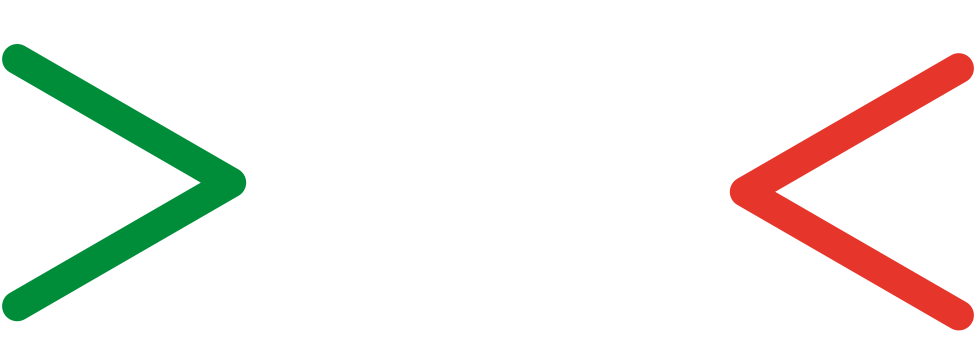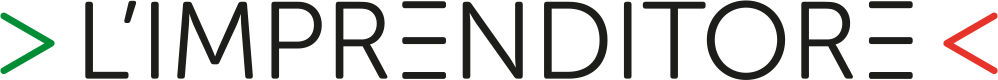Alla vigilia del primo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina e del nono anniversario degli eventi della piazza Maidan, una prognosi credibile della durata e degli effetti globali a medio-lungo termine della più grave crisi europea dalla fine della Seconda Guerra Mondiale va necessariamente sottratta allo specchio deformante della propaganda e soprattutto del whishful thinking. Al tempo stesso va innanzitutto chiarito che la responsabilità del Cremlino per una sciagurata iniziativa militare è indiscutibile ed enorme.
Tale assunto è imprescindibile, qualunque sia la valutazione delle dinamiche politico-diplomatiche che hanno contrassegnato i 33 anni dalla caduta del Muro di Berlino, la riunificazione della Germania, lo sgretolamento del Patto di Varsavia e l’implosione della stessa Unione Sovietica. In effetti, se tali eventi furono determinati da fattori interni ad un sistema disfunzionale costruito sulle realtà militari e territoriali del 1945, fissate a Yalta e Potsdam, le dinamiche “esterne” successive al 1989 sono state alimentate dall’apparenza di un nuovo assetto unipolare succeduto a quello bipolare della Guerra Fredda.
La globalizzazione commerciale, finanziaria e tecnologica – con gli “off shoring” e la creazione del Wto e del G20 e le fallimentari profezie di Francis Fukuyama sulla fine della Storia e di Thomas Friedman sul “mondo piatto” – ha poi distratto l’attenzione dalle costanti geopolitiche, cioè di “prossimità”, e storico-culturali sottostanti, favorendo in Europa processi semi-automatici di allargamento della Nato e dell’Unione europea, che hanno spostato ad Est il baricentro politico del continente europeo con prevedibili effetti incrociati in termini di minaccia e, soprattutto, di “percezione” della minaccia.
Il castello di carte della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (poi Osce) svaniva rapidamente mentre l’Ue, funzionale e settoriale, di Maastricht si rivelava incapace di dotarsi di una politica estera e di difesa comune e ripiegava pigramente sullo spregiudicato mercantilismo della Germania di Kohl, Schroeder e Merkel, il confuso protagonismo della Francia di Chirac e Sarkozy, l’ambiguo isolamento della Gran Bretagna di Blair e Cameron culminato nella disastrosa Brexit.
Per quanto riguarda la Russia, la convulsa transizione di Yeltsin si limitava a rivendicare una generica salvaguardia dell’“Estero vicino”, comprendente l’Ucraina, la Bielorussia, le tre Repubbliche caucasiche e le tre Repubbliche baltiche. L’ingresso di queste ultime nella Nato nel 2003 – unitamente alle forzature in seno al Consiglio di Sicurezza dell’Onu per le operazioni militari in Serbia nel 1999 e in Iraq nel 2003 – segnava una battuta d’arresto del processo di Pratica di Mare e spingeva Putin, creatura degli apparati di sicurezza e di uno Yeltsin al crepuscolo, alla reazione in Georgia nel 2008 fino all’annessione della Crimea nel 2014.
La debole risposta euro-atlantica a quest’ultima palese violazione dell’integrità territoriale dell’Ucraina, qualunque siano state le ingerenze esterne sulle vicende di Maidan, è efficacemente sintetizzata nelle sprezzanti parole di Victoria Nuland circa il ruolo dell’Unione europea. Dal canto suo la Germania addirittura “premiava” l’aggressione decidendo di raddoppiare la capacità di trasporto del gasdotto North Stream da 55 a 110 miliardi di metri cubi annui, mascherando assieme alla Francia l’irrilevanza politico-militare dell’Ue con le futili intese di Minsk, ignorate sia da Mosca che da Kiev. Dal canto loro negli Stati Uniti si apriva la lunga stagione dello shock interno e dell’aspra contrapposizione tra la presidenza Trump e la presidenza Biden, anche circa il rapporto con la Russia.
Mentre gli scenari futuri aperti dall’aggressione russa del 24 febbraio 2022 alimentano torrenziali disquisizioni geostrategiche sulla dimensione eurasiatica, riesumando le dottrine di Mackinder, Haushofer e Brzezinski, è utile assumere come base di partenza alcune realtà fattuali quali:
- la miscalculation politico-militare e di intelligence di Mosca circa la capacità di resistenza militare ucraina, grazie alla massiccia mobilitazione della Nato, resistenza culminata addirittura nel rafforzamento di un’identità nazionale malgrado le storiche articolazioni etnico-culturali presenti sul suo territorio;
- l’analoga ma delusa aspettativa di Mosca di una vistosa frattura tra Europa e Stati Uniti nel sostegno a Kiev, malgrado i distinguo dovuti all’evidente asimmetria transatlantica degli effetti sul terreno della sicurezza energetica e strategica e le più recenti tensioni dovute a misure protezionistiche, quali l’Inflation Reduction Act e le contromisure europee, tuttora in via di definizione tra l’aiuto di stato a livello nazionale ovvero risorse comuni da raccogliere sui mercati finanziari;
- la diversa percezione della guerra scatenata dal gruppo dirigente russo, purtroppo con il perdurante sostegno nazionalista della maggioranza della propria opinione pubblica, tra l’Occidente e vasti settori del resto del mondo (The West and the Rest, dal titolo dell’opera di Niall Ferguson), riluttanti a condannare l’iniziativa del Cremlino nei voti alle Nazioni Unite. Una riluttanza non limitata alla Cina, pur allergica alle soluzioni militari e orientata a nuove forme di egemonia economica attraverso il formato dei Brics e la Belt and Road Initiative, ma che è condivisa da numerosi paesi asiatici, africani e latinoamericani nella scia di una percezione, giusta o errata, di un unilateralismo americano, evidente nelle lunghe e fallimentari campagne militari in Afghanistan e in Iraq.
Le prospettive restano aleatorie. Mentre è evidente l’escalation dei bombardamenti e della preannunciata offensiva primaverile russa cui si contrappongono le richieste di forniture militari di Kiev in vista di un’improbabile liberazione dei territori occupati, Crimea inclusa, è altrettanto intuibile l’esistenza di canali di comunicazione riservata tra Washington e Mosca per evitare un allargamento del conflitto dagli imprevedibili sbocchi fino alla soglia nucleare.
Trattasi tuttavia di un crisis management precario, esposto anche all’esigenza di “salvare la faccia”, presente in entrambe le capitali, soprattutto in vista delle scadenze elettorali per la successione di Biden e forse dello stesso Putin nel 2024. È d’altro canto percepibile, soprattutto in un’Europa al rimorchio degli eventi, una strisciante stanchezza per le incognite di sicurezza che si aggiungono a quelle delle prospettive economiche, nel narrow path tra inflazione e rischi di stagnazione, sia pur fortunatamente inferiori a quelli paventati nell’autunno scorso, grazie anche al successo delle politiche di diversificazione energetica rispetto alle forniture russe.
Al tempo stesso si intensifica la ricerca di un nuovo assetto dell’economia globale a fronte delle minacce alle supply chains evidenziato dal dibattito sul re-shoring, near-shoring, friendly-shoring, ovvero dall’attenzione alla cosiddetta “sovranità tecnologica” attraverso i Chips Acts, sia negli Stati Uniti che nell’Unione europea. L’unica certezza risultante dal conflitto ucraino riguarda comunque la generalizzata crisi della governance internazionale, tra miscalculation, opportunismi di breve respiro e crisi di leadership minate spesso dalle tossine della comunicazione istantanea.
(Intervento pubblicato sul numero di febbraio dell’Imprenditore)
Nota sull’autore

SERGIO VENTO
Laureato in Scienze politiche alla Sapienza nel 1960, dopo il servizio militare Sergio Vento è entrato in diplomazia nel 1963. Ha svolto i primi incarichi all’estero, in Olanda, Argentina e Turchia. Rientrato alla Farnesina, è stato dal 1975 al 1979 responsabile dell’Ufficio Medio Oriente-Nord Africa della Direzione Affari politici. Dal 1979 al 1984 è vice rappresentante all’Ocse e all’Agenzia internazionale dell’Energia a Parigi. Responsabile delle Istituzioni finanziarie multilaterali e quindi consigliere diplomatico del ministro del Tesoro dal 1985 al 1989.
È stato ambasciatore in Jugoslavia dal 1989 al 1992, consigliere diplomatico di quattro presidenti del Consiglio dal 1992 al 1995 e sherpa ai vertici del G7 di Halifax 1995 e Lione 1996. Ambasciatore a Parigi dal 1995 al 1999, alle Nazioni Unite a New York dal 1999 al 2003 e a Washington dal 2003 al 2005.