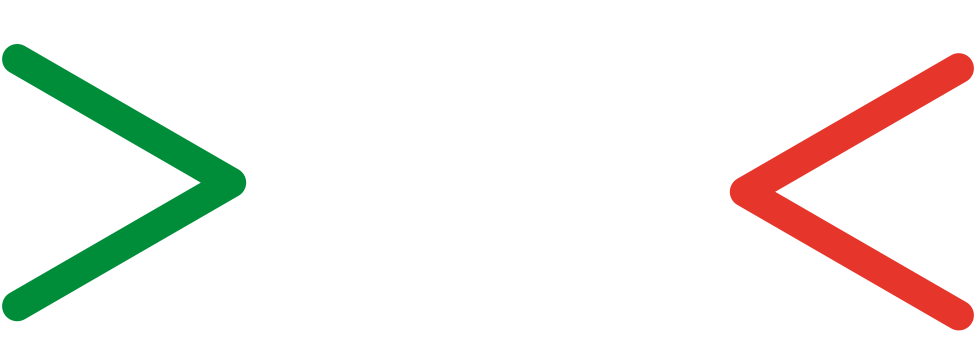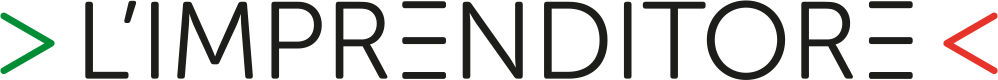Gioco di sponda. Da una parte un pensiero di Tommaso Padoa Schioppa: “Si è accorciato l’orizzonte temporale dei mercati, dei governi, della comunicazione (…), dei nostri atteggiamenti mentali. È in questa ‘veduta corta’, in questa incapacità di andare oltre il calcolo di breve periodo e di guardare il futuro lungo che sta la radice più profonda della crisi in atto”. Dall’altra alcune considerazioni di Dario Di Vico sul Corriere di lunedì scorso: “L’industria resta per la politica un incidente di percorso. Non serve ad accumulare consenso e quindi può essere derubricata. (…) È tradizione che in Italia la politica privilegi i consumi sugli investimenti, la domanda sull’offerta, il debito sulla crescita. Guardare al lungo termine è stato sempre considerato una bestemmia”.
Tra le due sponde sono passati una quindicina d’anni. Verrebbe da dire che si stava meglio quando si stava peggio. Certo, le condizioni di contesto sono cambiate drammaticamente rispetto ad allora, con nel mezzo pandemia e guerra, crisi energetica e inflazione, e molto altro ancora. Ma è pur vero che la veduta corta tenda ormai al cortissimo. Viaggiamo con l’abbrivio degli instant poll. Rischiamo la miopia endemica.
Prendiamo i rapporti tra politica e industria. È difficile reperire nel dibattito di queste settimane programmi rigorosi e visionari in tema di trasformazione digitale, ricerca e innovazione, nuova finanza, filiere produttive, reshoring. Che poi in modo ricorrente spunti fuori il “fungo Pnrr” (siamo anche in stagione!) a fare da “grande casa” alle proposte più variegate consola fino a un certo punto. Al di là dei contenuti, bisognerà anche scaricare a terra i fatti e, quanto a execution, dovremmo conoscere i nostri limiti. A volte ci comportiamo da Ponte Morandi, spesso da Salerno-Reggio Calabria.
Spendo qualche parola sul tema del lavoro, facendo riferimento all’Assemblea di Confindustria in udienza da Papa Francesco. Se ne è parlato tanto, roba da mettersi a contare le citazioni del presidente Bonomi e del Papa. Delego i data analyst e mi focalizzo su due passaggi.
Il primo, dedicato al lavoro “degno”. Snocciolando evidenze sui tassi di partecipazione di giovani e donne, sulla crescita dei poveri assoluti, sugli squilibri nella spesa sociale, sul numero elevato di Neet, sulla carenza di profili professionali adeguati alle richieste delle imprese, Bonomi ha ammesso che, purtroppo, l’Italia non è paese da lavoro “degno” e che molto resta da fare per renderlo tale. Le proposte nella relazione non mancano, accomunate – se mi posso permettere una interpretazione –, da una tesi di fondo: “Lavoro, non sussidi che lo scoraggiano”.
Il secondo passaggio è centrato su dove il lavoro prende forma, su come lo si determina. Papa Francesco ha esortato gli imprenditori con parole inequivocabili: “Io vi chiedo questo favore: che qui, in questo Paese, grazie alla vostra iniziativa, al vostro coraggio, ci siano posti di lavoro, si creino soprattutto per i giovani”. Frase di circostanza? Richiesta scontata? Non penso proprio. Da aziendalista di vecchio corso e da grande tifoso del Brambilla medio, considero il Francesco-pensiero un segnale di stima verso la categoria dei risk takers, un riconoscimento outstanding del ruolo dell’impresa, una legittimazione autorevole del “luogo” dove si generano posti di lavoro (o si prova a difenderli).
Non tutti in Italia la pensano così, tant’è vero che Bonomi stesso ha lanciato un grido d’allarme: “Avvertiamo un totale disinteresse per l’importanza del valore creato dalle imprese stesse”. C’è tutto un mondo che, parlando di creazione di posti di lavoro, si riempie la bocca di mantra fini a sé stessi, spara tweet senza fondamento. Vi appartiene chi non ha stima dell’impresa, chi non ne riconosce la missione competitiva e sociale, chi non si impegna per indagarne i meccanismi di funzionamento, i problemi gestionali, le dinamiche esterne.
Un dato dal particolare valore segnaletico, tratto da una ricerca recentemente condotta dall’istituto di ricerca GPF Inspiring Research per conto di Economy. Ben più della metà degli intervistati (circa 400 persone) considera le piccole e medie imprese non particolarmente rilevanti per la crescita virtuosa del Paese. Non solo, ma quasi l’80% del campione ritiene che la tenuta del modello economico italiano in questi anni difficili derivi dalle agevolazioni e dalle manovre europee, non dalla capacità di reazione delle imprese.
Qualche centinaio di persone non rappresentano una nazione. Fanno però riflettere, rimettendo sul tavolo la vexata quaestio a sfondo cultural-ideologico che ci trasciniamo da decenni: siamo un Paese pro o contro l’impresa, l’intrapresa, l’industria, la concorrenza? Domanda conseguente: possiamo permetterci il lusso di essere contro? Risposta, con lo sguardo fisso in avanti: no way!