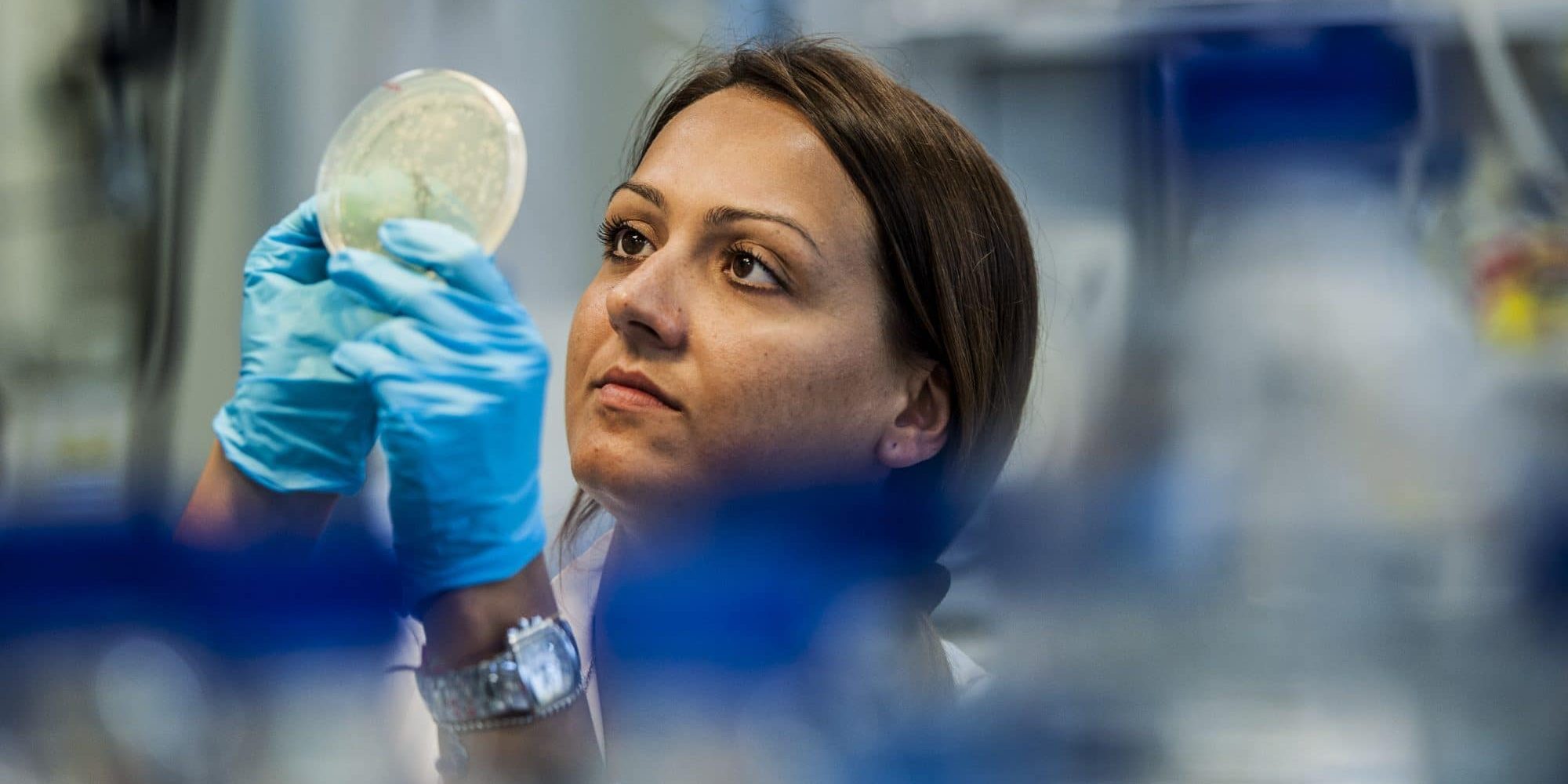
Sono bastati trenta giorni a cambiare l’usuale corso delle cose in Italia e nel mondo. A cambiare la vita dei cittadini e delle imprese. A far accadere “l’impensabile”, come lo ha definito lo scrittore Paolo Giordano, l’imprevedibile. O, usando il gergo degli economisti, a materializzare il cigno nero. Il mese che va dal 21 febbraio, giorno in cui l’ospedale di Codogno in provincia di Lodi ha reso noto di avere ricoverato il primo paziente italiano positivo al coronavirus, al 21 marzo, il primo giorno di primavera, il giorno in cui anche le attività produttive “non necessarie”, oltre a quelle commerciali, della ristorazione e del tempo libero, sono finite in “lockdown”.
Un primo giorno di primavera diverso da tutti i precedenti: niente gite al mare o alla casa di campagna, passeggiate sulla spiaggia o al lago, picnic nei parchi cittadini. Gli italiani hanno salutato l’arrivo della stagione della fioritura chiusi dentro casa, o per i fortunati che ne hanno uno, sul terrazzo e sul balcone. Passo dopo passo, l’Italia è andata in quarantena forzata e si è scoperta il Paese più colpito ed esposto, al centro della bufera perfetta. Fino a diventare il benchmark a cui i vicini guardano per decidere cosa fare e come farlo.
Insieme ai 60 milioni di italiani sono finiti a poco a poco “ai domiciliari” oltre un miliardo di persone nel mondo, in tutti e cinque i continenti. A provocare questa “clausura” obbligata è stato un minuscolo microorganismo acellulare che sembra sbucato dal passato, da altre epoche storiche, un parassita che ha scatenato un evento che l’Italia contemporanea, come del resto gran parte del resto del mondo, aveva dimenticato, non fosse che per averne letto gli effetti sulle società del tempo nei grandi classici della letteratura nazionale, dal Decameron di Giovanni Boccaccio ai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni: l’epidemia.
Un’epidemia indotta da un virus della classe dei coronavirus – quelli che portano il raffreddore e la febbre oppure lievi disturbi intestinali – comparso, ancora non è ben chiaro attraverso quali passaggi da animale a uomo, in Cina, a Wuhan, nel dicembre del 2019, dove ha mietuto la prima vittima l’11 gennaio. Da allora l’escalation del contagio è stata incontrollabile: dalla Cina è passato in Thailandia e in Corea del Sud e da lì in altri paesi asiatici; è approdato verso fine gennaio, senza poter essere individuato perché sconosciuto, in Europa, in Germania e in Italia, e negli Stati Uniti fino ad allungarsi nell’America del Sud e in Africa.
Il 30 gennaio l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato – non ascoltata a sufficienza da molti governi, che all’inizio hanno reagito con incredulità – l’emergenza globale; meno di due mesi dopo, l’11 marzo, a certificare l’ormai avvenuta espansione del coronavirus all’intero globo, ha dichiarato la pandemia. Nello stesso giorno il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato il decreto numero 5 denominato #Iorestoacasa, con il quale ha esteso all’intero Paese le restrizioni precedentemente in vigore nelle cosiddette “zone rosse”, lasciando aperte solo poche tipologie di esercizi commerciali, alimentari, farmacie, edicole e tabaccai.
L’ultimo giro di vite il governo l’ha dato il 21 marzo, primo giorno di primavera, quando il grafico quotidiano del virus si era impennato a 53.500 contagiati e a quasi 5mila morti, con un annuncio del premier Conte in diretta Tv che ha chiuso tutte le attività produttive, salvo quelle delle filiere ritenute necessarie, fino al 3 aprile, dopo un confronto serrato con le associazioni imprenditoriali, i sindacati e gli amministratori locali. Data che certamente non segnerà l’uscita dalla “clausura” perché l’emergenza non è finita, l’epidemia non ha mollato la presa sul Paese. Una ulteriore blindatura è arrivata, infine, il 24 marzo quando il governo ha varato sanzioni più severe per chi non rispetta le regole ed esce comunque di casa non avendone necessità, con multe fino a 3.000 euro.
Il nuovo giro di vite si è reso necessario perché ancora troppi italiani continuavano a uscire di casa: del resto, sin da subito, molti hanno grandemente sottovalutato le potenzialità infettive del virus e faticato a seguire le indicazioni del governo e dei virologi, affollando strade, parchi e spiagge. Ahimè come molti europei.
Le tappe dell’emergenza sanitaria
Nel dicembre 2019 il virus fa la sua comparsa a Wuhan, capitale dello Hubei, in Cina; l’11 gennaio 2020 si conta la prima vittima a Wuhan, due giorni dopo, il 13 gennaio, la prima vittima fuori dalla Cina, in Thailandia. Il 28 gennaio l’Italia registra il primo caso di coronavirus: una coppia di cinesi di Wuhan in vacanza in Italia viene ricoverata all’Istituto Spallanzani di Roma, i loro compagni di viaggio vengono posti in quarantena nella città militare della Cecchignola.
Il 30 gennaio l’Oms dichiara l’emergenza globale. Il 21 febbraio segna la svolta: il virus diventa autoctono. L’ospedale di Codogno (Lodi) segnala il primo italiano positivo al test, un uomo di 38 anni, e la Lombardia annuncia 15 contagiati. Si scopre anche il focolaio veneto, localizzato a Vò Euganeo. Primo morto a Padova. Il 22 febbraio il governo emana il primo decreto relativo all’epidemia e dichiara il lodigiano e Vò Euganeo, “zona rossa”, da cui non si può né entrare, né uscire e tutte le attività vengono chiuse tranne negozi di alimentari e farmacie: si tratta di 11 comuni, per circa 50mila persone.
Il 25 febbraio arriva il decreto 2: le misure di contenimento vengono estese a Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Il 4 marzo è il giorno del decreto 3: università e scuole chiuse in tutta Italia fino al 15 marzo, restrizioni per cinema, teatri e manifestazioni di ogni genere, si sollecita l’uso dello smart working in tutte le situazioni lavorative in cui sia applicabile. Sabato 7 marzo il decreto 4 dichiara “zona rossa” la Lombardia e 14 province di Veneto, Emilia Romagna e Piemonte.
L’11 marzo porta l’ennesima svolta, il decreto 5, #Io resto a casa, estende le misure di contenimento delle ex “zone rosse” a tutto il Paese, le aziende manifatturiere possono continuare a produrre, garantendo le regole di sicurezza contro il contagio. L’11 marzo l’Oms dichiara la pandemia. Il 14 marzo a Palazzo Chigi imprenditori e sindacati siglano il protocollo con le norme da applicare sui luoghi di lavoro, dalla sanificazione degli ambienti, alle distanze di sicurezza, all’impiego di guanti, mascherine e gel disinfettanti. Il 19 marzo l’Italia supera la Cina per numero di morti. Il 21 marzo si decide la chiusura totale.
Le misure a sostegno dell’economia
Ma non c’è solo l’emergenza sanitaria a stringere nella sua morsa il Paese, ben presto si manifesta anche l’emergenza economica con la necessità di sostenere imprese e lavoratori, in tutti i settori, primario, manifatturiero e terziario per evitare che lo stop delle attività finisca con il rendere impossibile la ripartenza e privi del reddito migliaia di persone. Il 18 marzo il governo vara il decreto 6, il “Cura Italia”, che mette in campo una manovra da 25 miliardi di euro e un’ampia gamma di strumenti per superare la fase di stop, dalla cassa integrazione in deroga anche per le piccole e piccolissime imprese, alla sospensione dei pagamenti delle imposte e dei contributi previdenziali, ai voucher per le babysitter per chi deve recarsi al lavoro, all’una tantum per le partite Iva.
Contemporaneamente l’Abi, l’Associazione bancaria italiana, sigla un accordo con Confindustria per agevolare le imprese, sospendendo il pagamento dei mutui e garantendo la liquidità. Banca Intesa Sanpaolo rende immediatamente disponibili 15 miliardi di euro per le Pmi.
Nella notte tra il 18 e il 19 marzo, dopo che lo spread Bund/Btp era schizzato a 320 punti base, un “board” di guerra a Francoforte decide la svolta europea. La Banca centrale europea rispolvera il “whatever it takes”, la frase che l’ex governatore Mario Draghi ha reso famosa nel 2012 quando caricò il cosiddetto “bazooka” per salvare l’euro, e annuncia che per sconfiggere l’emergenza economica – e la speculazione – è pronta ad acquistare fino a 750 miliardi di titoli pubblici e privati. “Tempi straordinari richiedono azioni straordinarie – la presidente Christine Lagarde finalmente riconosce la situazione –. Non ci sono limiti all’impegno della Bce per l’euro”. Il nuovo Quantitative easing durerà “finché non giudicheremo che la crisi del Covid-19 è finita, ma in ogni caso non terminerà prima di fine anno”.
Dopo la Bce, anche la Commissione europea mette tutto il suo peso sul tavolo. Il 20 marzo Ursula von der Leyen sospende il Patto di stabilità, uno dei pilastri della costruzione europea. “Ci sentiamo vicini agli amici italiani. Faremo tutto quanto è possibile per aiutare l’Italia – dichiara commossa –, lo stiamo davvero facendo.
Siamo profondamente colpiti da come state affrontando questa crisi. Siete un esempio meraviglioso per il resto d’Europa. Lo ripeto: siamo tutti italiani”. Il pacchetto annunciato “è fortissimo e si completa con la nuova potenza di fuoco annunciata dalla Bce. La Commissione, e questo è importante per l’Italia – continua von der Leyen – concederà la massima flessibilità sugli aiuti di Stato e sul Patto di stabilità così il governo italiano potrà aiutare le imprese e il mercato del lavoro e investire nella sanità. Le regole del Patto, solitamente rigide, sono state molto allentate.
Per la prima volta nella storia ho attivato la clausola di sospensione. Significa che il governo italiano potrà mettere nell’economia tanto denaro quanto serve. Le normali regole di bilancio, quelle sul debito ad esempio, non saranno applicate in questa fase”. La presidente ha poi parlato dell’iniziativa per gli investimenti: “Soldi che vengono dai fondi strutturali inutilizzati, che l’Italia non potrebbe più usare e che noi le lasciamo.
I fondi potranno essere impiegati in tutti i settori considerati prioritari: sono 11 miliardi. L’Italia potrà investirli nelle piccole e medie imprese, o per la disoccupazione di breve termine o altro. In più attraverso la Bei forniremo otto miliardi di garanzie a livello europeo per i prestiti che le Pmi possono usare”. Il tassello mancante, l’ultimo che potrebbe andare in posizione e che ha già ottenuto un ufficioso via libera del Commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, sono gli eurobond, ribattezzati coronabond o covidbond: “Non si può affrontare questa emergenza con gli stessi strumenti anticrisi di dieci anni fa. Sul tavolo dei ministri ci sono molte opzioni. Tra queste i covidbond, nuovi prestiti dal Fondo salva-stati e dalla Bei e l’idea di costruire un fondo europeo per la disoccupazione e la gestione della cassa integrazione”.
Articolo pubblicato sul numero di aprile dell’Imprenditore

