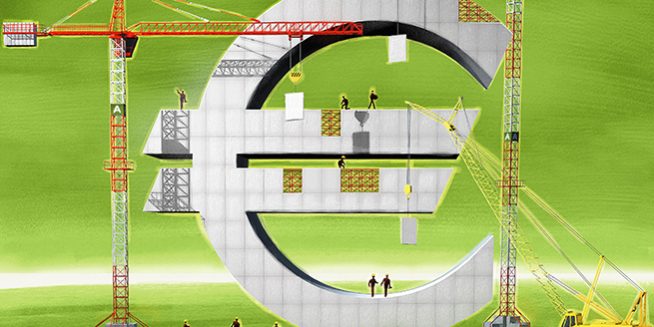
La crisi finanziaria del 2008 e le successive complicazioni sono state, forse, il primo banco di prova per la tenuta dell’Unione europea. Oggi a che punto siamo?

STEFANO MANZOCCHI
L’Unione europea resta il continente più ricco e il mercato economico per lo scambio di beni e servizi più importante del mondo. Parliamo di circa 500 milioni di consumatori che per reddito pro-capite si collocano mediamente nella fascia più alta a livello globale. Sessant’anni di storia comune hanno prodotto una forte integrazione sotto il profilo industriale e manifatturiero e ciò rende il mercato europeo molto interessante per i produttori del resto del mondo.
Sotto altri aspetti, quale ad esempio la vigilanza degli istituti bancari o le politiche di immigrazione, coesistono ancora oggi poteri nazionali e comunitari. Ne deriva un’integrazione ad assetto variabile a volte confusa ed opaca, che spesso non può agire nei tempi e nei modi che le circostanze richiederebbero: in questo senso, le recenti dichiarazioni di Angela Merkel aprono nuove prospettive con opportunità ma anche rischi. Potremmo dire che l’Unione europea è tuttora un “cantiere aperto”, la cui capacità di azione è lenta perché gli interessi nazionali pesano e le istituzioni comunitarie non sempre sono efficienti.
La crisi ha messo a nudo questa lentezza?
Assolutamente sì. Vi sono stati ritardi nell’impostare la politica monetaria perché molti paesi erano riluttanti ad adottare una strategia espansiva. Quando si è finalmente deciso, nel 2011 è arrivata la crisi dei debiti sovrani, che ha riportato a galla gli interessi in parte contrapposti fra le economie dei paesi nordici e quelle dei paesi mediterranei.
In tutto ciò non dobbiamo dimenticare che la politica fiscale dipende dai governi nazionali. Non esiste un organismo federale sul modello della Bce, sicché ciascun governo imposta la propria politica destreggiandosi fra i vincoli del Trattato di Maastricht, il Patto di stabilità e quanto viene deciso dalla Commissione europea e dalla Bce. Per tornare alla domanda, la risposta alla crisi finanziaria è stata certamente tardiva rispetto a quella degli Stati Uniti e ha pagato lo scarso coordinamento fra i paesi e le istituzioni economiche.
Dal punto di vista industriale come si è evoluto il continente?
Ricercatori e analisti della disciplina oggi parlano di “Fabbrica Europa”, definizione con la quale rappresentano l’insieme delle relazioni, dei vincoli e delle sinergie sempre più forti esistenti tra i sistemi industriali dell’area europea. Un’area che vede al centro la Germania e poi la Francia, l’Italia, i paesi del Benelux e quelli dell’Est. La centralità del sistema tedesco esiste ed è inutile negarlo. Sono il primo paese manifatturiero in Europa e un grande esportatore a livello mondiale e – nonostante a volte gli venga rimproverato – sono stati bravi a trarre beneficio dall’integrazione monetaria. Per quanto riguarda l’Italia, siamo la seconda industria del continente e abbiamo punte di eccellenza in molti settori. Siamo anche importanti fornitori di beni intermedi dell’industria tedesca, ma questo fa parte di un meccanismo di integrazione che, diversificando i ruoli al proprio interno, diventa sempre più europeo e sempre meno nazionale. Beninteso, all’interno delle catene del valore non sono spariti gli interessi nazionali; tuttavia è come se un organismo si fosse andato sviluppando in modo autonomo. È molto interessante confrontare questa “integrazione spontanea” che scaturisce dalle imprese con il disallineamento degli assetti politici.
Che posto occupano economicamente i paesi del gruppo di Visegrad?
Storicamente sono legati al sistema tedesco. Per quanto riguarda le politiche nazionali hanno fruito dei fondi strutturali e adesso dovrebbero ripensarsi non più solo come esclusivi beneficiari, ma come partner a pieno titolo del progetto europeo, i quali sopportano anche alcuni oneri: politicamente è difficile da accettare. Pesano alcuni retaggi del Novecento, c’è uno spirito di rivalsa verso il blocco dell’Ovest che spesso li ha trattati con condiscendenza e c’è, infine, il timore di affrontare la questione dei rifugiati perché le politiche di accoglienza sono costose e mal vissute dalla popolazione locale.
Pessimista rispetto al futuro?
Siamo in un momento ancora in parte indecifrabile. L’Unione ha dimostrato capacità di resistere agli shock – la crisi del 2008, quella del 2011, la crisi della Grecia e adesso la Brexit – ma la mia impressione è che prevalga una resistenza passiva, dove le forze centrifughe rendono qualsiasi risposta più lenta.
L’Europa è un grande esperimento democratico ed economico, oggi sotto pressione sia dall’esterno sia dall’interno.
Voliamo oltre Atlantico. La presidenza Trump ha annunciato una svolta protezionistica. Quale potrebbe essere l’impatto sull’Unione e come questa dovrebbe rispondere?
Qui entriamo in un territorio veramente sconosciuto, anche perché molte delle intenzioni andranno poi verificate al vaglio del potere politico americano.
Detto questo, l’intenzione di Trump è quella di affiancare ai trattati e alle organizzazioni internazionali una forma di rapporto bilaterale da gestire quasi personalmente. È chiaro che più l’interlocutore è diviso, più il potere americano aumenta. Oggi trattare con l’Unione europea è complesso, ma un domani negoziare singolarmente con la Polonia o l’Italia potrebbe essere molto più facile. Trump, quindi, ha tutto l’interesse a che l’Unione si indebolisca.
Molta della sua attenzione è rivolta alla Germania perché il deficit commerciale statunitense rispetto all’Unione europea ammonta complessivamente a 100 miliardi di dollari annui, ma di questi circa 65 dipendono dalla Germania.
Strategia analoga rispetto alla Brexit?
Gli inglesi sono molto più piccoli. Non hanno la rilevanza strategica, né la potenza economica degli Stati Uniti. Per loro può anche risultare ragionevole staccarsi in quanto non hanno l’euro e la loro economia si basa quasi del tutto sulla finanza piuttosto che sull’industria o sul commercio. Il vero rischio è il messaggio che arriva agli altri paesi, ovvero si può sopravvivere e stare anche meglio fuori dall’Europa: si dimentica, però, che l’impatto su paesi come la Francia, l’Italia o la Spagna sarebbe ben diverso.
L’uscita del Regno Unito rafforza o indebolisce l’Unione europea?
Per l’Unione potrebbe essere l’occasione per darsi lo slancio che finora è mancato. Gli inglesi stanno tergiversando e in questo c’è sicuramente della tattica politica perché lasciare nell’incertezza fa emergere le contraddizioni europee.
Molte delle prossime sfide economiche si giocheranno sulla capacità di trasferire innovazione nel sistema produttivo. Siamo preparati?
L’innovazione è un campo dove i differenti interessi nazionali e le diverse culture scientifiche hanno mostrato talvolta difficoltà nel giungere a un disegno comune.
Tuttavia va al tempo stesso riconosciuto che in questi 60 anni molto è stato fatto in termini di integrazione universitaria – si pensi ad esempio allo straordinario successo del Programma Erasmus – costruzione di network per la ricerca scientifica, politiche per l’innovazione industriale. Sono processi lunghi, secolari, e invertire la rotta ci porterebbe ad essere dei nani rispetto agli americani, ai cinesi o agli stessi giapponesi. Anche per l’innovazione vale lo stesso che in altri campi. Lo status quo è l’unica opzione che non è in campo: o si progredisce o la regressione potrebbe essere dolorosa.

