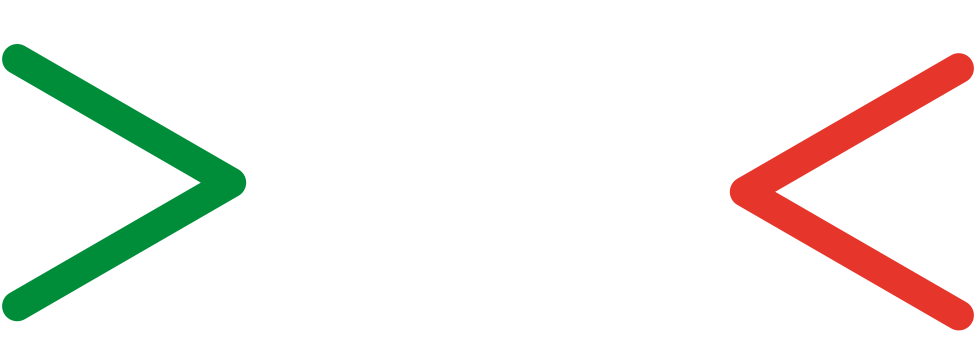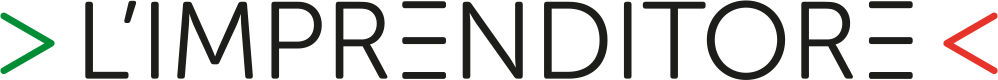di Carlo Robiglio, Presidente Piccola Industria Confindustria
“Se l’Africa produrrà, allora sarà in grado di dare occupazione ai suoi ragazzi” ha detto a marzo di quest’anno Vera Songwe, la giovane economista a capo dell’UNECA, la Commissione economica per l’Africa delle Nazioni Unite, in occasione del lancio della zona di libero scambio continentale africana a Kigali. Basterebbe questa frase per capire in quale direzione si stia orientando il continente.

CARLO ROBIGLIO
Se ne sono accorte persino la Cooperazione internazionale e quella italiana, che guardano ora al settore privato come elemento centrale di sviluppo. La partita Italia-Africa si gioca su due elementi: modello industriale e partenariato di co-sviluppo. Con l’Africa il primo vero problema italiano è cambiare l’approccio, ad oggi prevalente, rispetto a questo immenso continente. Che, appunto, è composto da paesi ciascuno con la propria identità e i propri bisogni, anche se accomunati da una serie di trend trasversali: quali crescita demografica, maggiore urbanizzazione, aumento del potere d’acquisto della classe media, regionalizzazione dei mercati e più recentemente anche una crescente digitalizzazione. Ma che è anche al centro di una partita globale di interessi economici e dove dal 2000 ad oggi, in particolare la Cina, oltre a infrastrutture ed aiuti, ha mobilitato anche i media, televisione compresa.
Una strategia che però ha il rovescio della medaglia nell’indebitamento sempre più forte di molti paesi africani nei suoi confronti, destinato ad aumentare con la Belt and Road Initiative che dal Corno d’Africa, ora in via di pacificazione, poi attraverso il Kenya e Gibuti, risalirà attraverso Suez verso il Mediterraneo.
È evidente allora che la narrativa italiana sull’Africa, incentrata per lo più su charity, migrazioni e stereotipi provoca alle imprese, specie alle piccole e medie, che sono la stragrande maggioranza delle aziende italiane, un disorientamento. E quindi potenziale perdita di competitività. Certo, l’Italia non può offrire i 60 miliardi di investimenti promessi dalla Cina o avere l’ambizione della Gran Bretagna – nelle parole di Theresa May – di diventare entro il 2022 il maggior investitore del G7 in Africa, superando gli Stati Uniti, e così rimediare in qualche modo agli effetti della Brexit nei rapporti commerciali con il continente.
Ma la chiave è che i leader mondiali, e ultimamente anche la Ue con il Piano Junker, si pongano su un piano di parità con l’Africa promettendo e offrendo investimenti.
La risposta italiana, in questo scacchiere mondiale che ha al centro l’Africa, è un elemento immateriale, flessibile e trasversale, perfettamente capace di adattarsi molto più di altri al contesto locale africano: il modello industriale della Pmi.
Che non vuol dire solo transazioni commerciali ma un modello di sviluppo industriale che trasformi in loco le materie prime di cui la maggior parte dei paesi africani è ricchissima, attraverso partenariati imprenditoriali con Pmi italiane, all’interno dei programmi di sviluppo che gran parte dei paesi africani hanno messo a punto su un orizzonte di medio periodo.
Un modello che dia sviluppo win-win sia ai paesi africani che crescita alle imprese italiane.