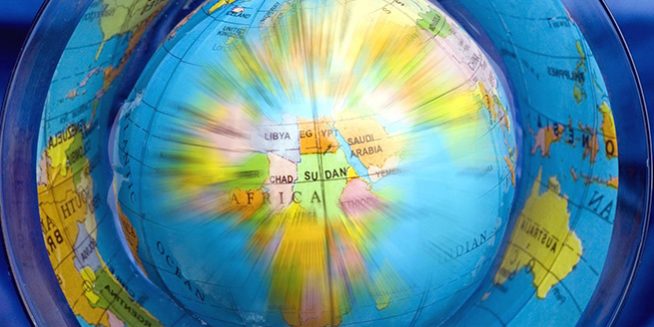
In questi ultimi tempi si riparla molto di Africa. Sia perché i flussi migratori in arrivo nel nostro Paese, che molto preoccupano l’Europa, provengono o sbarcano dalle coste africane, sia per il Migration Compact, sul quale le posizioni dell’Italia e dell’Unione europea sembrano distanti. Se la Ue appare incagliarsi su soluzioni di breve respiro per trattenere i migranti ai propri confini, l’azione italiana inaugurata con la Conferenza ministeriale Italia-Africa del 18 maggio ha lanciato un nuovo paradigma e cioè quello di coinvolgere gli Stati africani, facendone dei partner politici paritari e progettando di mettere sul piano della bilancia dei corposi e concreti investimenti. Economia? No, è politica. Proviamo a fare una semplice equazione: si scrive Africa e si legge demografia, crescita, sviluppo e mercati. L’ultimo rapporto del Centro Studi Confindustria sull’immigrazione presentato il 22 giugno ha reso noto che a fine secolo l’Africa in termini di popolazione sarà 7 volte l’Ue.
Se leggiamo questo dato al rovescio rispetto alle interpretazioni abituali, ciò significa che l’Africa rappresenta un mercato colossale, visto anche l’emergere di una classe media di dimensioni crescenti e a bisogni crescenti, non solo in termini di bisogni primari. Alimentata più dalle rimesse degli emigranti che dagli aiuti allo sviluppo, i flussi finanziari che arrivano nei paesi di destinazione servono a comprare telefonini, frigoriferi, auto e servizi.
L’Africa, secondo dati Sace, è già oggi leader mondiale nel mobile money, con il 12% degli africani sub-sahariani che posseggono un account mobile money (contro il 2% della media mondiale) e lo usano per il trasferimento di denaro, pagare bollette e piccole transazioni online.

Uber e le compagnie aeree low cost sono sbarcate in Africa, sintomo delle necessità africane di spostarsi all’interno del continente, e le principali catene di distribuzioni internazionali, specie quelle francesi continuano a espandersi. Di più: per quanto possa sembrare inconsueto, l’Italia e il continente africano sono accumunati dalla necessità di implementare crescita endogena e occupazione. Un fenomeno che peraltro assume una dimensione gigantesca nel continente africano, in grande ritardo rispetto alle potenzialità di sviluppo e cui l’Africa sta mettendo riparo con un silente ma costante percorso di integrazione regionale.
In Europa si parla molto di Ttip-Transatlantic trade and investment partnership, l’accordo commerciale di libero scambio in corso di negoziazione tra Ue e Stati Uniti. Ma si parla solo (per ora) fra gli addetti ai lavori del Tfta-Tripartite free trade area, l’accordo che a giugno 2015 ha integrato Comesa, Eac e Sadc, tre blocchi commerciali africani che, semplificando, raggruppano i paesi del continente che vanno dal Cairo a Johannesburg: 26 paesi, che riuniscono 625 milioni di persone e hanno un Pil di circa 900 miliardi di euro.
Al di là dei numeri quest’ultimo accordo è soprattutto una risposta al problema dell’integrazione regionale e, sotto un’altra angolazione, è una parziale dichiarazione di fallimento del temporeggiare della politica comunitaria verso l’Africa. La visione dell’Unione europea lanciata nel 2000 con l’Accordo di Cotonou, che prevedeva l’apertura della zona di libero scambio euro-africana, la più grande del mondo, attraverso il passaggio intermedio degli accordi di partenariato economico con singoli gruppi di paesi africani, era lucida e realista: agganciava l’Africa all’Europa e, attraverso aiuti allo sviluppo e investimenti, mirava ad assicurare la sostenibilità delle economie locali.
Peccato che gli aiuti a pioggia e l’assenza di investimenti, che per inciso anche la business community sud mediterranea rimprovera all’Unione europea per la fascia del Nordafrica, hanno fatto incagliare questa grande policy euroafricana. Ma la consapevolezza della propria potenzialità – unita al progressivo entrare in funzione dell’Unione Africana – ha fatto partire il processo di integrazione regionale autoctono. Che nel 2017 dovrebbe aprire la strada a un’area di libero scambio ancora più grande, questa volta per tutta l’Africa, comprendente quasi un miliardo di persone e denominata Continental free trade area.
Oggi il commercio intrafricano vale appena il 12% delle loro esportazioni, mentre vale il 40% in Nord America, il 30% nei paesi Asean e il 63% per l’Europa dell’Est. Secondo l’Unione africana “Non esistono buoni motivi perché avere scambi commerciali con Asia, Europa e America sia più facile che averli tra di noi” ha sintetizzato il Presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta. Una chiave di interpretazione inequivocabile, che apre la strada a una necessaria, maggiore consapevolezza che l’Africa, dal Mediterraneo sino alla sua punta Sud, sia la nuova via del cosviluppo.
Per ora lo è per Francia e Germania, Cina, Corea, Giappone. Ma se persino la Banca di sviluppo della Bielorussia stringe un accordo con la AfreximBank evidentemente questa percezione si sta allargando. Anche nell’industria italiana, siamo certi.

