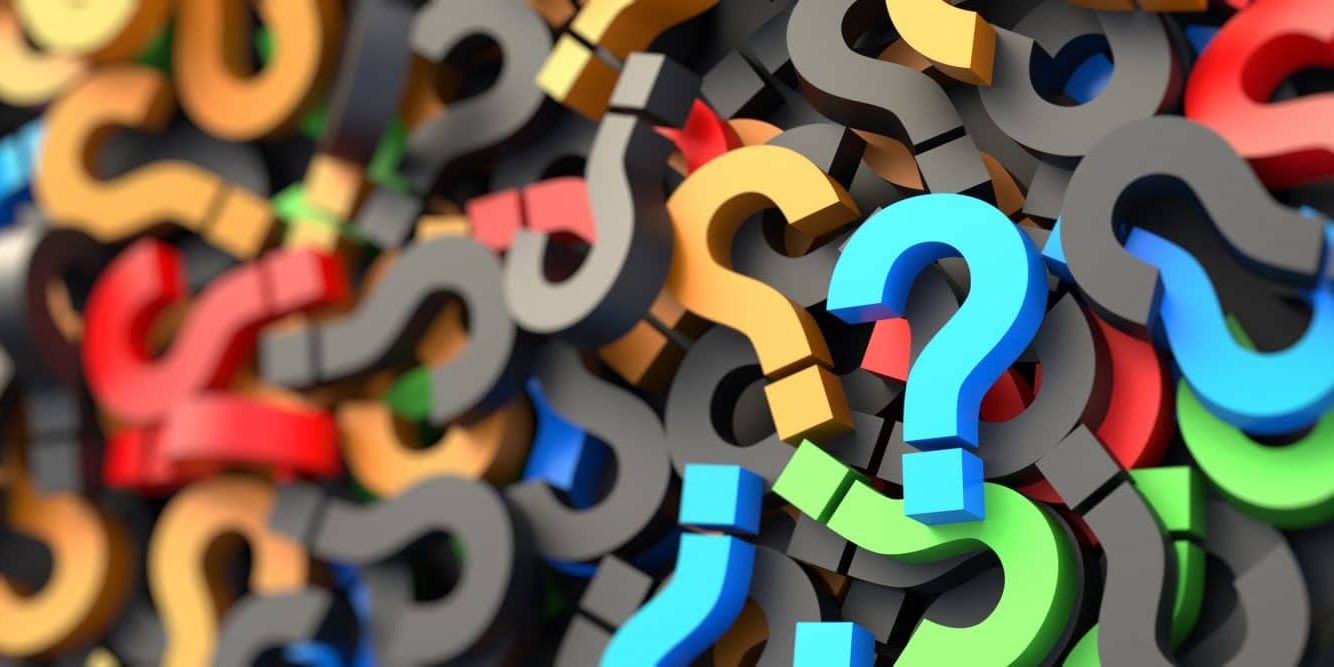
In pochi mesi l’Intelligenza artificiale è passata da promessa a componente concreta delle dinamiche di business, mentre i modelli generativi come ChatGPT, Claude e Gemini ridefiniscono la discoverability digitale e impongono nuove logiche di visibilità basate su coerenza semantica e reputazione.
L’IA sembra essere ovunque ed è entrata con decisione nei processi aziendali, ma in molte imprese italiane, in particolare nelle Pmi, non esiste una responsabilità chiara per la sua adozione e integrazione. Le sperimentazioni sono frammentate: il marketing utilizza gli strumenti IA per generare contenuti, l’IT introduce automazioni, l’area operations cerca efficienza, ma nessuno coordina tutti questi nuovi strumenti né sistematizza i processi. Questo porta a soluzioni parziali, non scalabili e spesso scollegate dalle priorità aziendali.
È qui che si apre un vuoto di ownership, che rischia di rallentare e spesso addirittura compromettere il ritorno strategico degli investimenti in Intelligenza artificiale. Le aziende italiane sono indietro nell’adozione dell’IA perché, nella pratica, sembra creare più problemi di quanti ne risolva.
Per superare questo stallo, nelle aziende più evolute sono ricorsi a una nuova figura, con competenze trasversali: il Chief AI Officer. All’estero questo ruolo è già realtà: negli Stati Uniti le nomine CAIO sono cresciute del 70% nell’ultimo anno e quasi metà delle aziende del FTSE 100 ne ha uno in organigramma.
Carlyle, con Lucia Soares, ha costruito un’infrastruttura interna che ha ridotto da settimane a ore il tempo di risposta nella valutazione di investimenti. Persino realtà come Meta e Dell hanno messo questa funzione al centro, con manager che hanno il compito di facilitare l’adozione degli strumenti di Intelligenza artificiale e sviluppano piani di formazione interna.
Anche in contesti meno strutturati la figura del CAIO può fare la differenza, soprattutto se interpretata come temporary o “fractional” manager: un esperto esterno con mandato di sei o dodici mesi, incaricato di mappare la maturità digitale dell’azienda, individuare casi d’uso prioritari, impostare una governance dei dati e formare le figure interne alla futura gestione. La sua funzione include progettare una roadmap coerente, scegliere i casi d’uso più rilevanti, individuare le tecnologie efficaci, garantire la compliance con regolamentazioni e principi etici e monitorare risultati con indicatori chiave.
Questo è un approccio pragmatico che riduce i costi fino al 40-60% rispetto a un ruolo full-time, che consente di importare conoscenze maturate in contesti diversi e di creare le condizioni perché le competenze restino all’interno una volta concluso il mandato. Una modalità adatta alle Pmi che non possono permettersi strutture sovradimensionate ma vogliono giocare d’anticipo in un contesto competitivo che si sta ridefinendo rapidamente.
La lezione che arriva dai casi di successo internazionali, come quelli documentati anche dall’Osservatorio Startup Thinking del Politecnico di Milano, è chiara: l’Intelligenza artificiale funziona davvero quando non è confinata a un reparto tecnico, ma diventa un linguaggio condiviso tra le funzioni aziendali.
Il change management torna dunque al centro dell’attenzione come leva abilitante: il suo ruolo è quello di costruire consapevolezza interna, ridurre le resistenze, favorire l’adozione diffusa e generare fiducia nei nuovi processi. Introdurre l’Intelligenza artificiale in azienda significa toccare abitudini, ruoli e flussi decisionali. Senza un percorso di accompagnamento che coinvolga leadership, comunicazione interna e formazione continua anche le migliori soluzioni rischiano di fallire, perché l’IA non può essere imposta dall’alto o lasciata al caso: va compresa e metabolizzata a tutti i livelli, solo così diventa davvero può davvero esprimere il suo potenziale trasformativo.
La competitività del futuro, dunque, si costruisce già da ora a partire da una nuova domanda: “Chi si prende cura dell’IA in azienda?”.
NOTA SULL’AUTORE

RAFFAELE BIFULCO
Raffaele Bifulco è co-fondatore e managing director di NEWU, soft infrastructure consultancy. Laureato in Estetica e con un master in Management e marketing presso la Luiss Business School, Bifulco ha iniziato la sua carriera nell’industria culturale come communication specialist del Museo MAXXI di Roma.
Con NEWU e nel suo precedente ruolo esecutivo nell’industria dei media, ha lavorato per clienti come Google, Prada, Sky, Amazon, Netflix, Ferrero, Samsung e Spotify, guidando sia progetti di comunicazione a livello globale che team dedicati.
Collabora con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Nuova Accademia di Belle Arti, tenendo corsi di marketing, comunicazione e project management. Inoltre, è mentor per il programma di accelerazione startup dell’Università Bocconi, Bocconi 4 Innovation.









