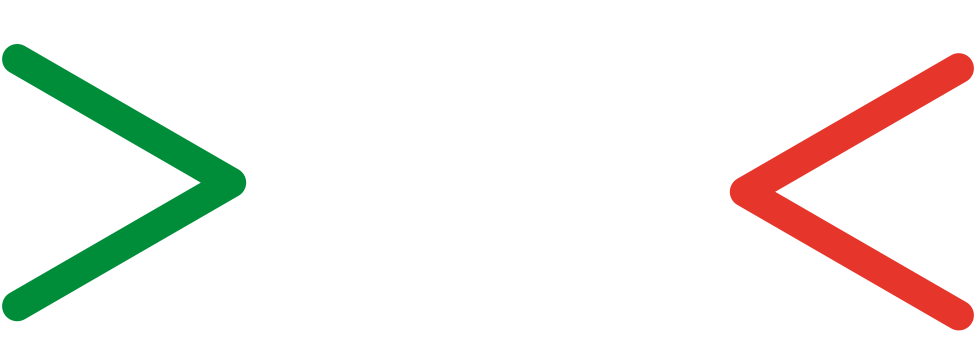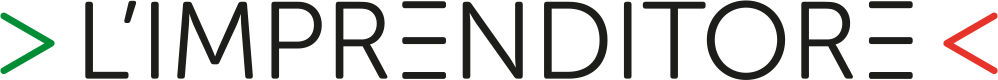Cominciamo a convincerci che la fase che stiamo vivendo finirà per smentire la famosa battuta “ha da passa’ ‘a nuttata”, tratta dalla commedia “Napoli milionaria” di Eduardo De Filippo. Gli avvenimenti, i dati oggettivi, la magnitudo dei cambiamenti in atto non possono essere rapidamente liquidati, come si è fatto sinora, alla stregua di una business disruption, sia pure di grandi dimensioni.
Stiamo in realtà archiviando 70 anni di una storia economica, come del resto già nel 1989 Francis Fukuyama aveva preconizzato nel saggio “The end of history”, e stiamo dando inizio ad una nuova era dai contorni e dagli sviluppi che nessuno è oggi in grado di prevedere, anche se possiamo già affermare senza ombra di dubbio che niente sarà più come prima.
Mentre in un precedente contributo su questa testata abbiamo affrontato il tema del business model, vorremmo avere la pretesa di tratteggiare quelle che, sulla base delle esperienze maturate sinora, delle riflessioni e dei confronti con gli imprenditori, sono le competenze necessarie per affrontare e non subire le incognite di questi tempi.
Parliamo di competenze e quindi di know how e non di attitudini personali. In un contesto caratterizzato da guerre, costo dell’energia, dazi, mercantilismo aggressivo della Cina, occorre sicuramente allenare il pensiero critico. Il pensiero critico comporta saper distinguere fatti da opinioni, decostruire narrazioni e riconoscere bias cognitivi e distorsioni mediatiche.
In un’epoca segnata da disinformazione e manipolazione dei dati, esercitare uno sguardo critico permette di leggere la realtà con maggiore lucidità e di formulare scenari coerenti per gestire l’impresa. Oggi più che mai è una competenza essenziale per il sovraccarico informativo, per l’aumento, causato dall’IA generativa, per il diffondersi di un “plausibile” non verificato. Non solo ma le decisioni sono spesso data-driven, per cui il rischio di decidere senza un’adeguata contestualizzazione diventa elevato.
Ultimo ma non ultimo, la pressione del time to market porta a privilegiare scorciatoie cognitive (per esempio bias di conferma, bias dello status quo, dare peso a eventi recenti o facili da ricordare, continuare a investire tempo o risorse economiche in un progetto fallimentare solo perché ci è già speso molto).
Considerando poi il contesto nel quale stiamo vivendo, un’altra competenza necessaria è la familiarizzazione con le relazioni internazionali. Non è più sufficiente avere un’infarinatura di geopolitica: serve conoscere gli attori, le dinamiche storiche e le istituzioni multilaterali, le ricadute possibili sui mercati anche perché, al di là del fatto che il processo di globalizzazione abbia subito un rallentamento se non una battuta di arresto, è anche vero che il livello di interdipendenza fra le varie economie è tale che non esiste un mercato che, per quanto di nicchia, possa considerarsi indenne dagli eventi internazionali.
La conoscenza di queste relazioni aiuta ad adottare una logica quotidiana di what if, a valutare rischi/opportunità, ad anticipare le possibili tendenze. Non si tratta certo di diventare analisti internazionali, ma nella pianificazione aziendale sarà sicuramente sempre più necessario ricorrere alla triangolazione delle fonti (confrontando dati economici/energetici, media locali/internazionali, think tank), seguire gli indicatori precoci (gli early warning), identificare le dipendenze commerciali/energetiche al fine di aggiornare la strategia aziendale, la supply chain e le operations, predisporre piani di emergenza (contingency plan).
La rapidità e l’imprevedibilità rispetto al passato, caratterizzato da cicli più o meno prevedibili e comunque su lassi temporali più lunghi, del contesto internazionale e dei mercati impongono di acquisire la capacità di cambiare prospettiva, di adottare nuovi paradigmi, di aggiornarsi rapidamente, di integrare più punti di vista nelle decisioni aziendali, in altri termini di maturare una flessibilità cognitiva per gestire la complessità.
Non solo ma fondamentale diventa la capacità di valutare i rischi e gestire le crisi, ovverosia il risk assesment. Non si tratta solo del crisis management classico, ma di imparare a costruire scenari in un’ottica di crescente gravità (passando dal best al moderate, al worst case). Più precisamente ci si riferisce ad un processo sistematico per identificare, analizzare, valutare e prioritizzare rischi (strategici, operativi, finanziari, legali, reputazionali, cyber, HSE ecc.) rispetto a obiettivi e al livello di rischio che un’azienda è disposta ad accettare e/o tollerare (risk appetite), al fine di decidere processi da implementare (ridurre, trasferire, accettare, evitare) e impostare un monitoraggio continuo (KPI, audit, review).
Non si tratta certo di una competenza nuova, ma sicuramente oggi è divenuta, anche per effetto della complessità del contesto, più sofisticata e soprattutto ricorrente.
Infine, per competere adeguatamente è urgente e non più rinviabile l’acquisizione di un mindset digitale. Secondo l’agenzia statistica europea Eurostat, nel 2024 solo l’8% delle imprese italiane hanno impiegato l’IA, posizionandosi al sestultimo posto in Europa dopo Cipro, Ungheria, Bulgaria, Polonia e Romania.
Tanto per avere un’idea del contesto competitivo, nel 2025 negli Stati Uniti risulta che il 45% delle imprese utilizza l’IA, mentre in Cina siamo al 39% e in India al 28%.
Sebbene siano passati oltre 45 anni da quando il sociologo statunitense Alvin Toffler scrisse “The third wave”, liquidato allora dai più come un suggestivo saggio di futurologia, i dati esposti denunciano come non si siano ancora comprese le potenzialità dell’IA, che non è un’opzione per le multinazionali e/o per le grandi aziende ma rappresenta un’opportunità enorme per tutte le imprese.
Acquisire un mindset digitale comporta la disponibilità a ricercare e sperimentare nuove soluzioni, a valutare la scalabilità, a coinvolgere in questa ricerca i collaboratori, a stimolare e integrare nuove competenze, mantenendo il cliente al centro e sfruttando gli strumenti digitali per personalizzare esperienze e servizi post-vendita.
La dimensione dell’azienda non deve costituire, come spesso ci capita di sentire, un pretesto assolutorio. Facendo attenzione ad evitare sedicenti apprendisti stregoni, si può attivare con l’aiuto di operatori rigorosi una valutazione sul grado di maturità del business e identificare le soluzioni scegliendo fra le opportunità dell’IA: diagnostica, predittiva, generativa.
Mario Draghi in un recente intervento a Bruxelles ha definito l’IA come una tecnologia trasformativa paragonandola all’invenzione dell’elettricità. Se questa invenzione non ha eliminato la produzione delle candele – come sotto forma di battuta ci è stato fatto notare quando abbiamo ripreso nel corso di un dibattito questa immagine – è anche vero che in questi 140 anni ha avuto un impatto clamoroso, sia sulla vita delle persone che sulle imprese.
Allenare il pensiero critico, familiarizzare con le relazioni internazionali, sviluppare il risk assesment, acquisire un mindset digitale richiedono impegno, disciplina e senso etico, ma come diceva Adriano Olivetti “senza un profondo senso morale, senza una nuova coscienza del lavoro, non può esserci progresso dell’impresa né gioia nel costruire”. E fortunatamente per l’Italia esistono molti imprenditori che operano nel solco di Adriano Olivetti, magari meno famosi ma comunque importanti per la solidità del sistema paese.
Nota sull’autore

ANTONIO ANGIONI
Laureatosi con lode in giurisprudenza, dopo aver conseguito un master ha iniziato un percorso professionale ampio e strutturato, sia in Italia che all’estero, lavorando per aziende di rilievo quali Fiat, Duracell, Air Liquide, ricoprendo incarichi che gli hanno permesso di sperimentare diverse aree manageriali.
Capitalizzando queste esperienze, nel 2017 ha fondato con un socio Poliedros Management Consulting, società di consulenza di direzione. Autore di numerosi contributi di management, privilegia i programmi di change management e di sviluppo della leadership.